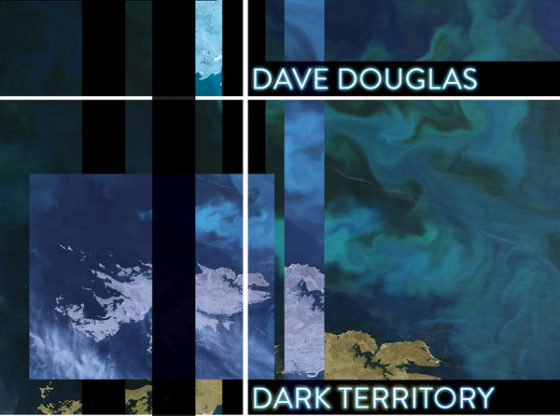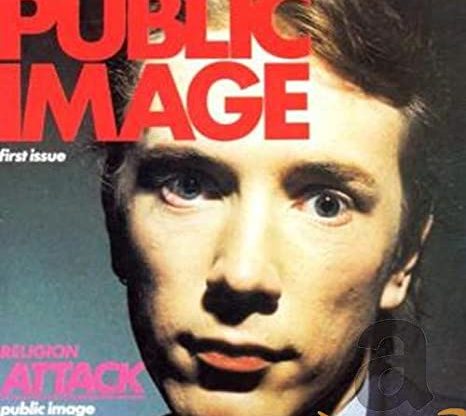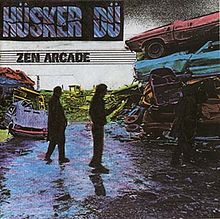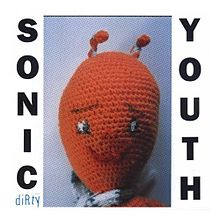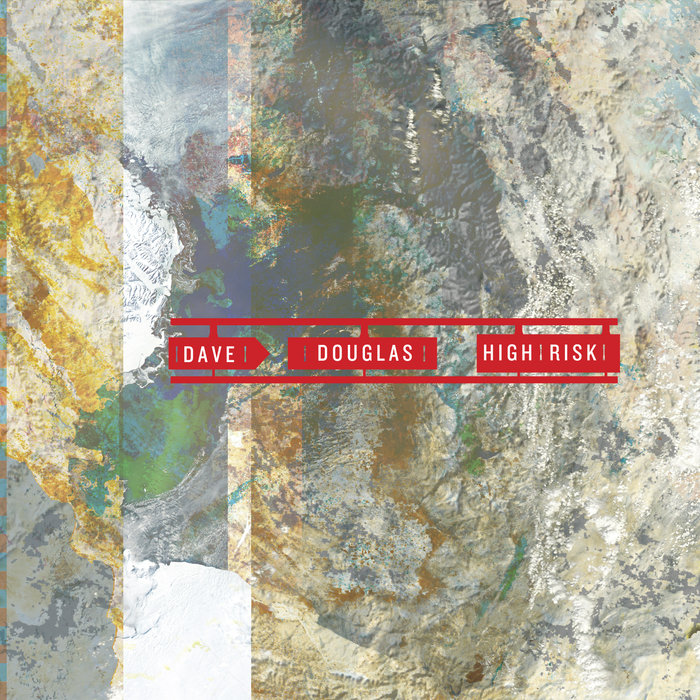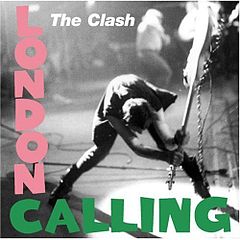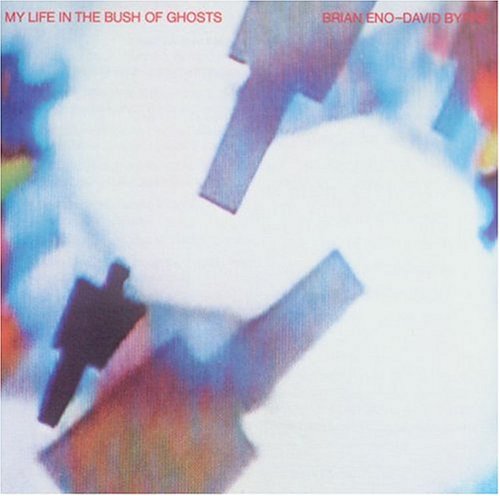Nei primi mesi del prossimo anno (2017), saranno esattamente 40 anni da quando uscì il capolavoro iniziale degli STRANGLERS, antesignani del punk inglese provenienti da Londra, quartetto stratosferico sicuramente fino al 1981, capace di piazzare 5 dei primi sei dischi entro le prime 10 posizioni della classifica inglese, con “Black and White” e “The Raven” addirittura al N° 1 delle charts di quegli anni (1978 e 1979).
Fondati nel 1974 col nome The Guilty Stranglers, esordirono su disco nel 1977 con la formazione leggendaria degli inizi: Hugh Cornwell (chitarra e voce), laureato in chimica, Jean Jacque Burnel, francese, (basso e voce), laureato in lettere e filosofia, Dave Grenfield (tastiere) e Jet Black, vero nome Brian Duffy, (oggi settantottenne ma già “grande” di età agli esordi) alla batteria. “IV Rattus Norvegicus” (nome scientifico del topo di fogna) come detto, è il loro disco di esordio. Era tempo di calzoni strettissimi e corti, di scarpe con i lacci che si allacciavano da sopra, di cappotti pesanti e di pelo nero, di giubbotti di pelle di pari colore (come indossati da Burnel sulla copertina del disco), di rabbia proletaria contro la Thatcher che governava con polso inflessibile a Londra e nel Regno Unito, la differenza con gli altri incazzatissimi protagonisti di allora era che gli Stranglers, unici, utilizzavano le tastiere e che tastiere! (organo e moog soprattutto) nelle mani del mago Greenfield! I testi erano di Cornwell e Burnel, spesso con evidenti sottolineature misantropiche e sessiste. Su questo disco abbiamo almeno due brani in questo senso indimenticabili. La copertina del disco li ritrae in stanze differenti in una sorta di piccolo museo gotico. Le esalazioni mefitiche ed il respiro spesso asmatico quando non strettissimo e violento di questo grande disco, garantite dall’organo splendido di Greenfield e dal basso che pare suonato dentro le tubature del gas, da Burnel (cintura nera di karate oltre che laureato), associate alla voce durissima e virile di Cornwell ed al suono della sua chitarra molto metallico e swingante, col supporto della batteria veloce e potente di Black, diventano da subito, il loro inconfondibile marchio di fabbrica. L’album si scosta nettamente dalle produzioni discografiche del periodo, arriva fino al n°4 delle classifiche di vendita inglesi, conferma nel quartetto qualcosa di davvero innovativo ed irrinunciabile. Il disco si apre con “Sometimes” caratterizzata da svisate del synth, dalla voce cupa di Cornwell e dalla struttura circolare della melodia che ricorda qualcosa dei Doors addirittura per come viene portata avanti. Il riff centrale torna continuamente a galla sottolineato dalla voce dura del chitarrista. Grande brano. “London Lady” è la rappresentazione ironica della classica donna inglese. Cantato stretto, riff di chitarra ben sagomato, la melodia che funge da piattaforma per i “soli” ai vari strumenti dei quattro componenti del quartetto. “Goodbye Toulouse” sul grande impressionista francese, Toulouse Lautrec, è uno dei migliori brani del disco.
Cantato sempre duro, ricami di tastiere e melodia che non si scorda mai. Il basso di Burnel, come in tutto il disco, è EPOCALE! “Peaches”, arrancante, sparata nella voce con un ossessivo riff di organo, si imprime immediatamente nella corteccia cerebrale di chi ascolta. Brano malato, doorsiano nell’uso delle tastiere con grandi prestazioni di Greenfield e Burnel, soprattutto. “(Get a) Grip (on yourself)” è il singolo di gran successo con l’aggiunta sporadica e solitaria di un inatteso sax, capace di miscelare aggressività e melodia, un po’ quello che avviene nella loro musica sempre. “Ugly” è il velo squarciato su una personalità malata e deforme (“ugly” per l’appunto), brano che pare sguazzare nella descrizione della Londra più malfamata e pericolosa nei suoi vicolo trasandati e minacciosi, nelle sue innominabili attività notturne. La voce bofonchia, scatarro indistinto ed indistinguibile che urla tutto il suo disprezzo al mondo, con l’Hammond di Greenfield che vola alto su tutto e tutti, abbinato in un abbraccio vizioso col basso di Burnel, vera catapulta del suono Stranglers. Il brano che va a chiudere il disco, “Down in the sewer” (laggiù nella fogna) è esemplificativo del punk e della sensibilità di fine Settanta. La base è costituita da basso, moog e batteria, con inserti di chitarra (Cornwell) apparentemente pacifici ma, verso la metà del pezzo, lo scenario cambia drasticamente, tutto diventa drammatico, basso e batteria serrano i ritmi, l’organo spezza le reni al suono, occhieggiando a destra ed a manca nei cunicoli puzzolenti ed attraversati da un’acqua nera delle fogne. Parte così un solo straordinario di organo che, ad ogni passaggio, aumenta di velocità fino a farti alzare da terra, letteralmente e che va a concludersi in modo glaciale ed incombente con il rumore dello scorrere dell’acqua e gli squittii di mille e mille topi di fogna, famelici, aggressivi, senza pietà. Un must nei concerti dal vivo ma, soprattutto, un brano che deve essere ascoltato. E’ rock, è psichedelia, suonata veramente alla grande da una band come non ce ne erano in Inghilterra in quel preciso momento, nell’ambito di una musica che, al tempo stesso, facesse riflettere ma fosse pure fruibile e restasse bene impressa nella mente. Grandissimi Stranglers che, avrebbero poi prodotto un disco eccellente nello stesso anno, attraverso il quale li conobbi a Natale del 1977 e, poi, come detto, i due capolavori citati in apertura di questa recensione che andremo ad analizzare nelle prossime uscite. Quattro dischi di tal livello compreso questo esordio, credetemi, se li sono potuti permettere in pochissimi. Viva.
 IV Rattur Norvegicus
IV Rattur Norvegicus
Punk inglese
1977