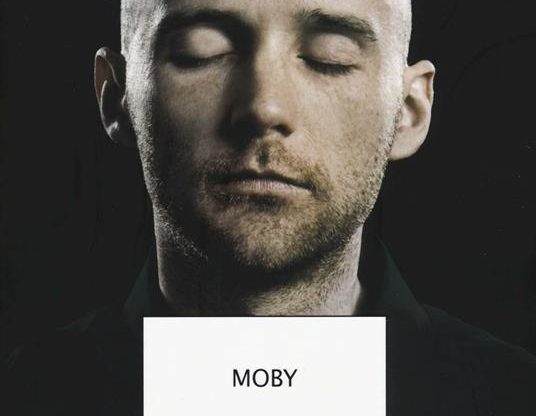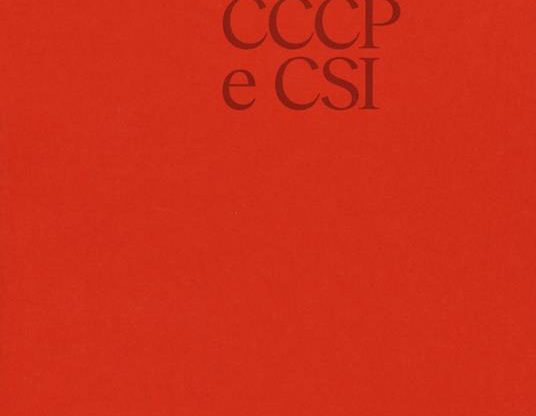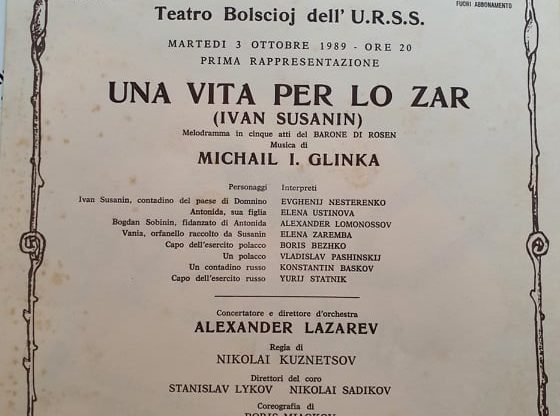Non c’è niente di più bello di ciò che non è lineare, limpido e che desta sempre interesse, curiosità. Ogni giorno si assume una consapevolezza, una crescita interiore, una sensibilità mentale che si ripercuote nei semplici gesti, nella guida da intraprendere nella vita. Ci si accorge piano piano dei particolari, si rimuovono delle cose e se ne ottengono altre, mentre lentamente si scorge una forma. Questo processo vitale si ripercuote nell’arte, creata dall’umano, il quale a sua volta viene ispirato dalla natura. Ma non c’è niente di più mistico di una novità, di un concepimento di qualcosa di unico, proprio come è avvenuto a Canterbury.
E’ un panorama che possiede un’atmosfera particolare, un umore crepuscolare, che si collega perfino alle arti visive. Il dadaismo è l’espressione nella quale cade il pensiero Canterburyano. Quello che si trova nel sound di Gong, Henry Cow, Caravan e Hatfield & The North è un mood oscuro, industriale, il grigio prettamente inglese e autunnale. Il genere è camaleontico, ha una doppia faccia, come gli stati d’animo dell’uomo, ovvero la rabbia dell’elettronica cupa del Moog e la rarefazione dei timbri eterei. Vi è un sentimento, una malinconia che è quella che influenzerà lo spirito di Joy Division, Echo & The Bunnymen e Cocteau Twins. Un malessere dell’anima misto ad alienazione propria dell’ambiente hippy post Woodstock, che consacra numerose band artefici di opere eccelse.
I Soft Machine esordiscono nell’importantissimo 1968, fanno da spalla ad Hendrix e si fanno notare con uno stralunato free jazz. Originalissimo è il timbro vocale del batterista Robert Wyatt, mostro sacro al pari di Byrne, Eno, Gabriel e Fripp. La “Macchina Soffice” inaugura il suo primo LP con il manifesto “Hope For Happiness”, dove notiamo subito il falsetto di Wyatt toccare stati di trance mista ad agitazione. Il suo modo di suonare è eccelso, da session man di Miles Davis a dir poco, e il resto della ciurma non è da meno. Da menzionare è anche il basso del geniale Ayers (sostituito nel secondo lavoro dal divino Hugh Hopper), come nella graziosa ‘Joy Of A Toy”, che non fa sentire la mancanza della chitarra. (ah, ci fosse stato Hendrix..)
Insomma il primo album è incentrato su una psichedelia di buona fattura, tanto che pochi erano arrivati a ciò nella fine dei Sessanta, a parte i Red Krayola e i Silver Apples. C’è originalità, spensieratezza mista a genio e l’evidenza che si sono aperte le porte di un’era irripetibile, che andrà a influenzare il post rock e il noise industrial. I Soft Machine, dopo “Third”, eseguono un jazz convenzionale a causa dell’assenza di Wyatt, mentre per il biondo batterista ci sono due capolavori shockanti, commoventi.
In “Soft Machine” non troviamo il jazz dominare sulla psichedelia, bensì il contrario. Non sono presenti ancora il sax di Dean, il flauto e clarinetto di Hastings e il trombone di Nick Evans. Troviamo invece Kevin Ayers. Realtà tipicamente inglese, dimessa, poco egocentrica, un tipo alla Nick Drake e Tim Buckley. Qui lo vediamo al basso, ai cori con il suo timbro profondo, al pianoforte e ad arricchire gemme come “We Did It Again” e ” Why Are We Sleeping?”. Incappiamo in ” So Boot If At All” di sette minuti dove Ratledge e Wyatt iniziano a mettere in mostra le loro personalità, picchiando più di un Ginger Baker e di un Winwood. Si sente, comunque sia, ancora un minimo di acerbità, che sarà tolta nel collage sonoro di “Volume Two”, grazie al dialogare del minimalismo con bruschi accenti. Il miracolo arriva con “Moon In June” di “Third”.
Il centro del Canterbury Sound è quello del surrealismo che esprime la vastità dei travagli della psiche. Lo scopo è quello di turbare lo stream of consciousness di ognuno di noi.
 Soft Machine
Soft Machine
Psychedelic Rock
1968