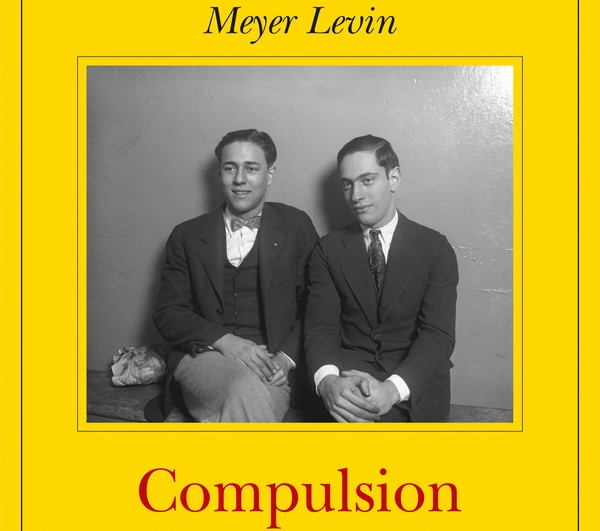Circa dieci anni prima di A sangue freddo, a torto considerato il primo romanzo verità, Meyer Levin scrisse questo Compulsion, regalando al mondo intero un capolavoro di scrittura, a metà tra la cronaca giornalistica e la ricostruzione romanzata. In un’epoca, la nostra, in cui con i fatti di sangue ci si costruisce il palinsesto di intere trasmissioni tv, tracimando nella spettacolarizzazione priva di contenuti, sorprende e colpisce un libro come questo. In cui è, appunto, la scrittura a fare la differenza, anche etica, tra ciò che significa ricostruire un evento e fare pornografia catodica.
Siamo nella Chicago degli anni ’20 quando la città viene sconvolta, letteralmente, da quello che sarà nel libro definito “il delitto del secolo” e, a seguire, “il processo del secolo”. Due rampolli di famiglie milionarie del South Side di Chicago, rapiscono e uccidono un ragazzino, solo per vedere cosa si prova. Artie e Judd, così si chiamano nel libro, sono spinti dal desiderio di realizzare il delitto perfetto, sull’onda del superuomo di Nietzsche. Qualcosa che provi al mondo, e a loro stessi, di essere superiori e al di fuori da ogni legge e regola.
Un fatto vero che Meyer Levin, allora giovanissimo giornalista del Chicago Daily News, ricostruisce con precisione da cronista di razza trent’anni dopo i fatti, come dice lui stesso: “non per sensazionalismo ma nella speranza di applicare a questo caso le accresciute conoscenze acquisite nel corso degli anni, per trarne ulteriori elementi utili all’interpretazione del comportamento umano”
Mentre si legge questo libro sembra di vedere, come nei film in bianco e nero, i titoli dei giornali che sfumano con una voce fuori campo che urla “edizione straordinaria”. Perché questo Compulsion è, prima di ogni altra cosa, magistrale giornalismo e del magistrale giornalismo ha gli odori, la frenesia, la fame di scrivere, di arrivare alla notizia ma, soprattutto, l’onestà intellettuale verso i lettori.
In una Chicago raccontata senza quasi mai nominarla, gli anni venti sono quelli della criminalità, di Al Capone, di omicidi efferati. Ma questo ha e avrà qualcosa che continuerà a lungo a colpire proprio per le motivazioni. Due ragazzi appena diciottenni che ammazzano un quattordicenne a caso, senza alcun motivo che non sia quello di assecondare il proprio senso di superiorità. Ma per ogni delirio di onnipotenza c’è una crepa, qui rappresentata da una serie di errori, ingenui, che porteranno gli inquirenti e due giornalisti (di cui uno l’alter ego letterario di Levin) a stringere sempre più la morsa attorno ai due assassini.
In Compulsion si alternano le immagi e le descrizioni dei giorni immediatamente precedenti il crimine a quelle dei giorni seguenti, i momenti concitati subito dopo l’uccisione e quelli della meticolosa preparazione della stessa. In un rutilante susseguirsi di personaggi, avvocati, psicologi e detective, Levin ci accompagna in una storia che sembra un film o un libro di Ellroy e invece è la realtà. Preciso, quasi chirurgico, il racconto si addentra nella ricostruzione psicologica dei due assassini,(e del loro rapporto mai ben definito) fatta sulla base delle perizie psichiatriche ma resa come fosse un romanzo senza mai sconfinare nell’empatia. E questa, anche questa, è la grande differenza tra Compulsion e A sangue freddo. Qui c’è una cronaca precisa ma non fredda, fatta da un osservatore/narratore che non giudica ma cerca di capire.
Si può raccontare, tenendo il lettore incatenato alle pagine fino alla fine, il buco nero dell’animo umano, senza toccare le corde del patetismo ma senza ergersi a giudici? Meyer Levin ci è riuscito in questo libro che definire “colossale” è il minimo. Un inno al potere della scrittura, quella vera.
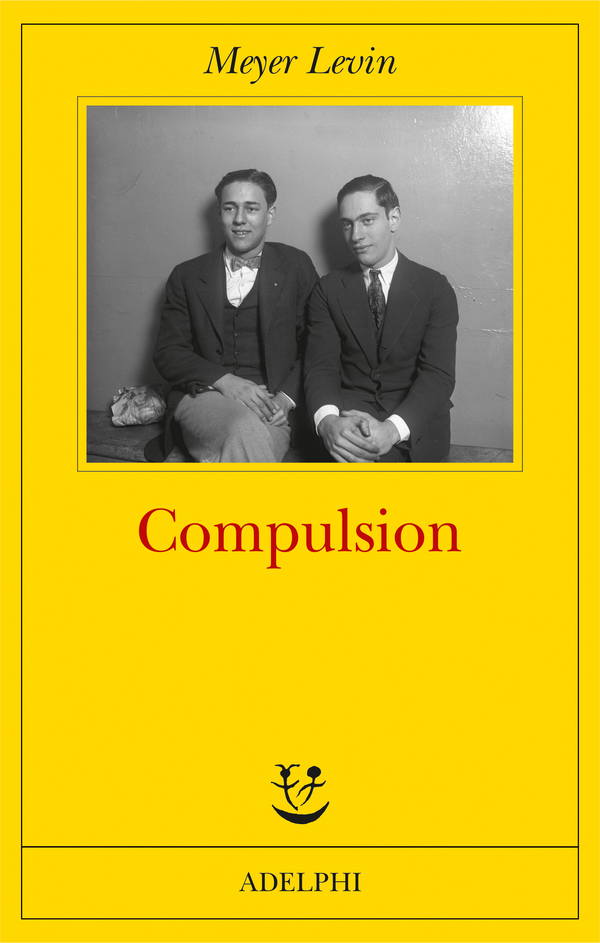 Compulsion
Compulsion
Non fiction novel
Adelphi
2017
580