Recensione di Paolo Vanini, ricercatore all’Università di Trento
Emil Cioran è stata una delle voci più scettiche, e probabilmente meno ascoltate, del Novecento. Ad oltre un ventennio dalla sua morte, e in un momento di riscoperta del suo pensiero, la ferocia dei suoi dubbi resta però per molti un inconfutabile segno di pessimismo, di un nichilismo che non avrebbe altro scopo che compiacersi del nulla di cui ci si è circondati.
Nicola Vacca, nel suo ultimo libro Lettere a Cioran (recentemente pubblicato dall’editore Galaad), confuta precisamente questa interpretazione dell’opera cioraniana. Il saggio, che non supera il centinaio di pagine, si compone di diciotto brevi capitoli, i quali, lungi dal seguire un ordine sistematico o strutturale, si presentano invece come una serie di lettere in cui si parla di ed a Cioran, consci di quel principio, così caro allo scrittore rumeno, per cui parlare di qualcuno equivale sempre a confessare qualcosa di noi stessi. In tal senso, questo «epistolario» si presenta non solo come un sommario delle perplessità cioraniane, ma anche come una confessione dell’autore medesimo, che già nel prologo del testo ammette che «ogni giorno della mia vita adulta è stato scandito dalla forza» delle parole di Cioran. Parole capaci sia di vivisezionare la miseria della condizione umana che di riscattarla attraverso una miracolosa resurrezione di tutte le contraddizioni dell’esistenza, troppo spesso taciute in nome della ragione, della logica e di un certo galateo metafisico per cui tutto ciò che non è coerente è presumibilmente grottesco – e dunque filosoficamente irrilevante.
Cioran si situa agli antipodi di un postulato del genere, che egli confuta con tutti i mezzi della ragione, dell’intuizione e dell’umorismo. Se Cartesio aveva mostrato che la ragione deve dubitare di tutto, Cioran ci insegna a sua volta che il dubbio, lungi dall’essere metodico, non può che essere capriccioso, proprio come i capricci del sottosuolo di Dostoevskij, capaci di barattare l’intero universo per una tazza di tè. Le certezze, prima ancora di venir confutate, devono essere ridicolizzate, messe alla berlina, esiliate negli anfratti del buon senso. In tutto ciò il dubbio non serve solo a rinnegare o ad edificare il nulla, ma soprattutto a capovolgere le prospettive, a destabilizzare qualsiasi presunzione di serietà – permettendoci così di ridere di ciò di cui nemmeno si sarebbe potuto discutere.
Nel primo capitolo del libro, Nicola Vacca evidenzia che per Cioran lo scetticismo è «un atto politico», nella misura in cui implica una postura nei confronti del reale in grado di «disinnescare tutti i canoni della stupidità», ossia della quotidiana inerzia del dogmatismo e della miopia fanatica, a causa delle quali la verità non si configura come una nuova prospettiva sul possibile, ma come una cementificazione del possibile stesso. In questo frangente, l’estremismo del dubbio cioraniano – che ha a che fare con una cosciente e meditata violenza sul verbo – non si concretizza in un gesto semplicemente aggressivo, bensì in una riflessione che è tanto benevola quanto atroce, poiché mira a scalfire il carattere demoniaco della volontà umana, di quella predisposizione antropologica a non astenersi da nulla, edificando il male in nome del bene. Vacca si domanda al riguardo se si possa «davvero essere buoni senza essere scettici»: ossia, senza aver coltivato quel dubbio capace di svelare a noi stessi il mostro che si nasconde in ognuno di noi, e dal quale si deve imparare a prendere le distanze. La risposta è evidentemente negativa e assume come paradigma l’esempio di Cioran, il quale, nelle sue pagine, ha confessato gli aspetti più aberranti e fallimentari del suo carattere, e proprio così è riuscito a domarli, a diminuirli, a convertirli in un’accettazione di sé tanto disillusa quanto tragicamente divertita. Spesso ci si vendica degli altri per ciò che non si è stati personalmente capaci di realizzare. Cioran, viceversa, espone senza pietà (e quasi con rancore) ogni suo fallimento, cercando di consolarsi per esser riuscito a «non essere niente». Si tratta di un bizzarro rinnegamento di sé che – come sottolinea Vacca – rivela un carattere propositivo, poiché l’asceta che sa «pensare contro se stesso» non sarà costretto a pensare ipocriticamente contro gli altri, nella speranza di ingigantire le colpe altrui per sfuggire all’insignificanza propria.
Nel nono capitolo del libro – intitolato Altro che nichilista, il vero Emil era immanente – l’autore si sofferma per l’appunto sul rapporto tra nulla e negazione e osserva che, in Cioran, il nulla è il centro gravitazionale di una paradossale fascinazione per l’abisso, che da un lato ha a che fare con la catastrofe dell’esistenza, ma che dall’altro risulta il solo plausibile motivo per vivere: «Tutto il mistero della vita – scrive [Cioran] nei Quaderni – sta nell’attaccamento alla vita stessa, in un’obnubilazione quasi miracolosa che ci impedisce di distinguere la nostra precarietà dalle nostre illusioni». Cioran, che non si illude mai sull’esistenza di un altro mondo oltre al presente, è consapevole di amare «questo mondo orribile» proprio perché è troppo precario, perché manifesta il mistero di una grandiosità assurda e vulnerabile, simile ad una cosmica e fragile superficie di vetro sotto la quale si nasconde un’oscurità devastante. Infrangere questa oscurità dovrebbe essere facile come lanciare un sasso contro una finestra; tuttavia, visto che su quella finestra è inciso il riflesso del nostro volto, nessuno trova il coraggio di frantumare la nostra speculare identità.
«Sogno una lingua le cui parole, come pugni, fracasserebbero le mascelle» – leggiamo nel Funesto Demiurgo. In un altro aforisma dei Quaderni, citato sempre nel libro di Vacca, Cioran confida di andare ogni giorno «verso il Dubbio come gli altri vanno in ufficio», riferendosi forse a quella rancorosa apatia nei confronti della propria professione tipica di molti impiegati. Non si è mai felici di entrare in ufficio; ragion per cui, sarebbe propedeutico scaraventare le scrivanie contro la porta d’ingresso dopo aver timbrato il cartellino. Chi intuisce le ragioni di questa provocazione, intuisce anche che nei passi appena menzionati, a cui se ne potrebbero aggiungere molti altri, il filosofo rumeno tradisce un umorismo che eccede i parametri del pessimismo e che di certo stona con la gravità del nichilismo. A conferma di ciò, Vacca si focalizza su un’intervista con Christian Bussy (Vivere contro l’evidenza, a cura di Antonio Di Gennaro, Mimesis 2014), in cui lo stesso Cioran delinea le sue dissonanze con le conclusioni puramente teoriche di buona parte del nichilismo accademico: «Io non sono nichilista, non sono niente. […] Di certo sono un negatore, tuttavia la mia negazione non è astratta, quindi un esercizio. È una negazione viscerale, dunque, nonostante tutto, un’affermazione; è un’esplosione. Uno schiaffo è forse una negazione?» Sarebbe stupido chiedersi se uno schiaffo sia o non sia nichilista, perché un ceffone, nel momento in cui colpisce il nostro volto, ci obbliga a reagire in qualche modo: non ci si addormenta mai a suon di sberle; allo stesso modo, non si può sprofondare nel torpore del dogmatismo se la nostra coscienza è continuamente squartata da qualche dubbio e diniego salvifico. Scrive Nicola Vacca: «Per Cioran, infatti, negare è il modo migliore per emancipare lo spirito: la negazione è l’humus per cui vale la pena di esistere. Deve però trattarsi di una negazione feconda, e perché sia tale occorre conquistarla, lasciarsene sedurre e al contempo impugnarla consapevolmente».
A tal proposito è opportuno seguire l’autore quando, nell’undicesimo capitolo, ci ricorda che Squartamento è stato il primo libro di Cioran che gli sia capitato di leggere (coincidenza che, sia detto tra parentesi, accomuna lo scrittore recensito al correttore di bozze recensore). Era l’aprile del 1981. A distanza di trentasei anni, queste Lettere a Cioran rappresentano il resoconto di uno studio che è stato in primo luogo una questione esistenziale, una progressione nel dubbio in compagnia di un pensatore che si è continuato a frequentare come si frequenta un amico irriverente e fidato. La stessa brevità del saggio sembra affine allo spirito della frammentaria scrittura cioraniana, che – nel quindicesimo capitolo – viene giustamente definita non «tanto come un percorso quanto, piuttosto, come un risultato, un residuo: del processo del pensiero restano visibili solo le scorie, ciò che si conserva dopo la fermentazione». Da questo punto di vista, le Lettere di Nicola Vacca sono anche un suo ringraziamento a Cioran. Un Cioran che, in virtù delle proprie scorie, ha insegnato al suo amico di penna che «non si scrive sullo scrivere», perché un buon scrittore «sarà tutto, salvo che l’anatomista del Verbo».
Qualcuno, che sicuramente non stava pensando a Cioran, mi disse una volta che un buon libro, se ti cade sul piede, non fa male alle dita. Questo piccolo saggio, che non è certo stato progettato per infortunare caviglie, ha il pregio cioraniano di non disdegnare le cadute – di non ignorare, cioè, i dubbi, i fallimenti e le miserie di chi scrive, di chi legge e di chi è commentato. Nel far questo, resta fedele al dettato di Cioran, secondo cui «un libro deve essere un pericolo», nel senso che deve provocare una ferita in colui che legge. Non si tratta, ovviamente, di un urto fisico provocato dall’obesità di un manoscritto, ma di una lacerazione metafisica, che stravolge il lettore nella misura in cui lo amputa di qualche certezza, esasperandone in tal modo la coscienza. Essere lucidi, per Cioran, significa sviluppare la consapevolezza che ogni convinzione personale è tanto più ridicola quanto più definisce in modo univoco la nostra soggettività. È necessario, dunque, colpire il proprio sé, in un’opera di auto-lacerazione che viene onestamente e malinconicamente stilizzata in un aforisma dei Quaderni, dove Cioran ammette: «È divorandomi che ho trovato tutto ciò che ho trovato. Mi sono diminuito per poter penetrare alcune verità».
Chiunque porti a termine codesto esercizio di diminuzione, si riconoscerà nella seguente sentenza di Squartamento, che attraversa in controluce il libro di Nicola Vacca e che, proprio per questo, ci servirà da congedo: «Siamo tutti nell’errore, eccetto gli umoristi. Solo loro hanno compreso l’inanità di ciò che è serio e anche di ciò che è frivolo».
Paolo Vanini
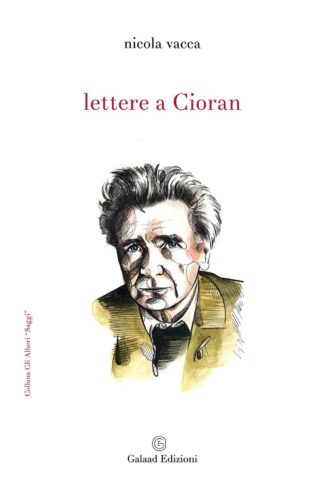 Lettere a Cioran
Lettere a Cioran
Critica letteraria, saggistica, letteratura
Galaad Edizioni
2017
104















