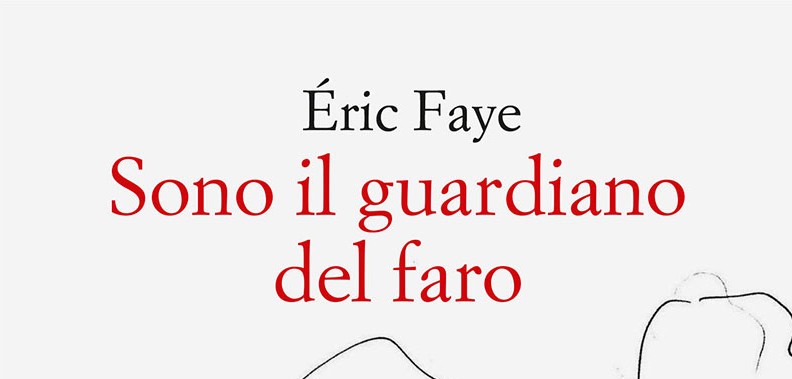In un’intervista rilasciata nell’ottobre 2016 a Orazio Labbate su Il Mucchio Selvaggio lo scrittore francese Éric Faye rivelava quali fossero i suoi autori prediletti. Accanto ad alcuni mostri sacri, Kafka, Gogol’, Maupassant, Conrad, Čechov, vi aggiungeva un grande “antimoderno” del Novecento, Julien Gracq (da leggere assolutamente La riva delle Sirti, capolavoro ripubblicato lo scorso anno da L’orma editore) e quel grande inventore di letterature che è stato Julio Cortázar. Tra gli italiani, a parte l’immancabile Dante, Faye indicava Buzzati, Calvino, Pavese, Brancati, Svevo, Malaparte. E i contemporanei? “Ah, sì, ho letto Seta di Alessandro Baricco. Un libro che m’ha deluso. Non ho ben capito perché abbia avuto tanto successo in Francia”. Tracce di alcuni dei maestri citati affiorano in Sono il guardiano del faro (Racconti edizioni, traduzione di Valentina D’Onofrio). E, a ben vedere, si può comprendere anche l’ultima stroncatura: in Faye non incappiamo né in semplificazioni estetizzanti né in compiaciuti ammiccamenti al vasto pubblico dei lettori. Siamo in presenza, piuttosto, di una scrittura asciutta e precisa, che si staglia su uno sfondo metafisico impervio.
“Gli inquilini della torre d’avorio non sono molti. Se ne vanno per il mondo, come se nulla fosse, per i mari o sui treni. Nel cuore degli inverni più rigidi portano qualcosa con sé, una ventiquattrore favolosa da cui non si separano mai. Vanno da soli, è la loro natura”. Nei nove racconti Faye riduce l’esistenza umana all’osso, riportandola al grado zero della solitudine e della disperazione. È un quadro filosofico tragico e ironico, dove ogni ipotesi di verità è falsificata, alla base, dalla mancanza di interlocutori validi, volti empatici o sguardi concilianti. Se l’altro c’è, ha una chiave d’accesso ad un mondo diverso, distante, che non è il mio. I ricordi scivolano nel cono d’ombra dei silenzi autoimposti e delle relazioni mutilate. I giorni, disossati dalla presenza di persone amiche, si accumulano lenti, verso un intuibile ultimo atto.
Sono il guardiano del faro è composto da nove storie di viaggio, nove drammi congelati, nove itinerari di perdita e di dissipazione del sé. Fari, muri, agende, treni sono vettori spogliati dalle loro funzioni e riesumati come simboli universali del disagio, avvitati sulla spina dorsale di un’umanità paradossalmente immobile. “Gli inquilini sono innamorati della loro torre d’avorio. Il loro unico timore è di vedere, un giorno, il contratto d’affitto sciolto. Di ritrovarsi per strada, di non potersi più rinchiudere e di non poter più resistere, contro venti e maree, a quel nonnulla, a quella sciocchezza, che li assedia e li commuove”.
Il guardiano del faro, protagonista dell’ultimo dei nove racconti, incarna alla perfezione il disagio esistenziale dell’uomo costituzionalmente solo. Non sappiamo nulla di lui, a parte vaghi accenni alla sua vita passata. Perché ha scelto una professione così strana? Da chi o da cosa fugge? Dalle donne? Da un impegno politico naufragato? Dalla civiltà nel suo complesso? Giorno dopo giorno redige il suo diario, e ce lo consegna, ritagliando una testimonianza attorno alla sua aura di solitudine. In fondo al faro sono sepolti i manoscritti dei suoi predecessori, riflessioni vecchie di duecento anni compilate accanto a note tecniche sul funzionamento della lanterna e ai bollettini del mare. Cosa resta di un vocabolario se eliminiamo il superfluo? Quanti e quali termini sono utili all’umanità? Di quanto si dovrebbero sfrondare le nostre discussioni per ridare un senso alle parole? Da molto tempo nessuna nave rompe la monotonia dell’orizzonte. Tempeste si intervallano a belle giornate. La natura scandisce lo scorrere delle settimane, dei mesi, degli anni, mentre un elicottero provvede a fornire all’eremita lo stretto necessario per sopravvivere. Poi, inattesi, irrompono alcuni eventi, e con essi un problema nuovo: come distinguere un fatto vero da un sogno? Qual è lo statuto ontologico della realtà, se siamo soltanto noi ad osservare e sperimentare ciò che avviene? E se fossimo pazzi? Se la realtà si risolvesse unicamente nelle nostre percezioni? In un faro sperduto nessun altro può attestare che è così, o che è altrimenti. Faye, nei suoi racconti metafisici all’insegna di un sottile perturbamento, pone al lettore quesiti filosofici maturati nei secoli, instillando dubbi, perplessità e paure.
Una costante di queste narrazioni dal sapore bergmaniano è la difficoltà, per il protagonista, di uscire dalla sua sfera vitale, dal guscio entro cui è calato. Vi è una corrispondenza simbiotica fra uomo e contesto, e ogni passaggio assomiglia ad un salto quantico, uno scarto di energia tra un dominio di appartenenza e l’altro. Così, Anton e Antonia, nel primo racconto, sono un uomo e una donna alloggiati in convogli separati, che solo in alcuni momenti si accostano su binari vicini, consentendo ai passeggeri di scambiarsi occhiate, di conoscersi seppur a distanza e di innamorarsi: “Antonia è l’amore della mia vita; ma è sull’altro treno. Dovrei dire: Antonia è l’amore della mia vita perché è sull’altro treno”. Nessuno ha potuto vedere, dall’esterno, il proprio treno lanciato verso il nulla né ha memoria di cosa vi fosse prima della partenza, mentre tutti hanno il sospetto di cosa accadrà a fine corsa. Similmente, un altro viaggiatore, nel secondo racconto, si lancia dalla sua carrozza per visitare la misteriosa città siberiana di Taka-Maklan, fermata depennata per errore dagli orari ferroviari e divenuta un’entità fantasma. In Faye, come in Kafka, cause ed effetti si invertono. Taka-Maklan sembra una città destinata a scollegarsi dal resto del mondo, a prescindere dalla scelta della compagnia dei treni. Qui, l’energia dei gesti è risucchiata in una logica di entropia, palazzi e nuvole si richiudono su se stessi e i viaggiatori perdono il loro nome. “Nei sobborghi della città, si potevano vedere file di bestie da soma in cammino, cariche di qualsivoglia oggetto inutile. Si dirigevano verso l’orizzonte e svanivano in fretta”.
In Frontiere, Faye assegna all’umanità il compito di scalare un irto muro, (tr)ascendendo in direzione di una vetta nascosta agli sguardi. Il viaggiatore è scortato, di tappa in tappa, da solerti guardie, fino a scoprire che vi è un limite mai valicato da nessuno. Qualcuno suggerisce che il muro è solo un momento finito di un gioco infinito (Hegel protesterebbe), come nelle prospettive disegnate da Escher. Ogni livello è una soglia che tenta lo scalatore, combattuto tra il desiderio di accasarsi in uno dei quartieri sorti a varie altezze sul crinale e l’istinto di proseguire lungo una parete sempre più scoscesa e priva di appigli. In La spiaggia dove dorme una sirena, un monaco ortodosso del monte Athos scorge in una figura femminile arenata sulla spiaggia una possibilità di cambiamento (di salvezza?). È un dono portato dal mare, un corpo caduto da un pianeta lontanissimo. Finché l’intervento di una motovedetta fa svanire la speranza. “L’esistenza è fatta di piccole morti successive, annidate una dentro l’altra. Una telefonata a cui non rispondiamo. Una corrispondenza interrotta; una lapide su cui non portiamo più fiori. Un giorno, nella biblioteca del monastero, ho riaperto l’atlante del mondo per provare a contare le mie morti precedenti”. In Ibernazione, racconto claustrofobico quasi beckettiano, l’incedere di una giornata d’inverno, in cui non accade nulla, lascia nel protagonista l’indelebile impronta del tutto, una verità disarmante incisa tra le pieghe della coscienza.
Con Sono il guardiano del faro Faye si è aggiudicato il Prix des Deux Magots del 1998. In questa prova narrativa, connotata da una tensione all’eterno e all’universale, brilla la traballante luce di un decennio, gli anni Novanta, contrassegnato dallo smantellamento di interi sistemi politici e da un progressivo e inarrestabile riflusso nel privato. Faye ha destrutturato il tema del viaggio per collocare all’interno di un perimetro di incertezza i profili di esistenze oramai fratturate, corrose dai dubbi e incapaci di costruire il proprio futuro insieme. Lo scrittore constata anche lo smarrimento del genere maschile. Di fronte al tracollo dei luoghi comuni, Faye invoca una spettacolare inversione dei ruoli nella classica cornice del mito: “… che sia Euridice a far risalire Orfeo, per una volta… che ritornino tutte le Euridici alzatesi un giorno da una panchina per prendere un treno. Perché, in fondo al baratro, l’acqua comincia a salire e bisognerà fare in fretta. Una scala di corda! L’acqua sale e i mercanti di nostalgia fanno fagotto, il passato chiude bottega”.
 Sono il guardiano del faro
Sono il guardiano del faro
Racconti
Racconti Edizioni
Maggio 2016
148