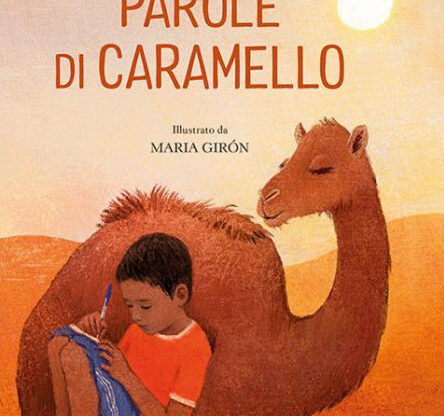L’estate muore giovane di Mirko Sabatino
Recensione di Carmine Maffei
L’altra notte ho fatto un sogno, giuro.
Ricordo che mi trovavo in una città surrealista, nella cui sconfinata area svettavano grattacieli che si stagliavano ad altezze incredibili, in maniera troppo affusolata, che oltrepassavano le nubi di un cielo plumbeo.
Nel bel mezzo di questo assurdo e inquietante panorama scorreva un torrente, serpeggiante, ed io, avvicinandomi alla sponda, sempre più realizzai il dubbio che mi attanagliava: nel letto di quel fiume correvano, saltellavano, si scontravano, fortemente frusciavano miliardi di fogli scritti a macchina e, mentre cercavo ancora una spiegazione al folle fenomeno, una carta di esse mi si stampò sul viso.
La mia curiosità ebbe la meglio, nonostante il “caso stesso della casualità”, fui tentato di leggere ciò che sopra vi era scritto e la mia espressione, credo, assunse un corruccio investigativo. Vi era questo:
La vita è ciò che ti capita tra la nascita e la morte. Tu scegli poco. Le persone e gli avvenimenti ti si impigliano addosso, ciechi, tenaci, e durante il percorso qualcosa resta, qualcosa si aggiunge, molto si perde, poi tutto.
Poi il nulla. Mi svegliai di soprassalto, ma non era ancora ora di correre a lavoro.
D’istinto accesi il piccolo lume sul comodino e…eccolo, la spiegazione al mio inconscio notturno era proprio lì dove l’avevo lasciato qualche ora prima, un libro, cioè qualcosa che ti resta, che ti coccola anche a letto e infine ti concilia il sonno.
Eureka! ho sussurrato con voce roca. Il piccolo volume era L’estate muore giovane di Mirko Sabatino (Narrativa Nottetempo) e allora lì ho realizzato che di esso presto avrei dovuto scrivere, che per esso avrei fatto qualcosa di utile, così come la suddetta frase, io avrei ricambiato, anche se in minima parte il dono che mi era stato assegnato.
Alcuni libri ti catturano già dallo scaffale di una libreria, non hanno bisogno di vetrine, né di una forte promozione mediatica; ti rapiscono e basta, quindi devi leggerli.
Ed è proprio il caso del romanzo d’esordio di Mirko Sabatino, di cui già l’inusuale titolo (chi avrebbe mai pensato che l’estate morisse giovane? Tutti? Nessuno mai?) ti invita ad allungare le dita verso di esso, a sfogliarne qualche pagina, ancora qualcun’altra, su, aspetta, aspetta qua che dice? quindi sopraffatto richiuderlo e avviarsi dritti verso l’uscita, quasi all’ultimo istante ripensandoci, per passare alla cassa e soffermarsi di nuovo sulla foto di copertina.
Ma allora questo libriccino deve essere per forza mio!
Quindi la copertina, dicevo. Vista dall’alto c’è una scogliera su cui appena si affacciano curiosi dei ragazzi in costume che osservano esterrefatti l’amico di turno, più coraggioso, che si è appena lanciato da essa, in un rocambolesco e fascinoso tuffo all’indietro, verso il blu verdastro delle acque del mare, come a far intendere che a breve il suo esile corpo sarà inghiottito, con un violento spruzzo irregolare e fragoroso, nelle sue viscere piatte, dalle onde appena percepibili.
E’ quindi già la forza dell’immagine che detta le regole, che insieme al titolo, dai caratteri neri, decisi e semplici su fondo bianco, evoca un tuffo verso l’ignoto che aspetta oltre la frizzante adolescenza, la stessa che è illuminata dal sole estivo dello scatto.
Si legge subito, alla svelta.
Estate 1963, un paesino sul Gargano, il mondo tutto intorno ad esso che si anima dei suoi avvenimenti, dei Beatles, dell’assassinio di J.F. Kennedy, ad esempio, ma nella stessa piccola realtà di provincia, appena accennata, la vita di tre ragazzini inizia a prendere una svolta che, tra un brusco tornante e un altro, li porterà presto verso la realizzazione della realtà adulta, con le sue regole, i suoi impegni, i suoi desideri e purtroppo i suoi improvvisi traumi. Troppo improvvisi.
Primo, l’io narrante, insieme a Damiano e Mimmo, dopo rocambolesche avventure che li porteranno a scontrarsi dapprima con i bulli del paese, per sottolineare la loro amicizia, più forte del termine stesso, suggellano un patto per cui nulla più potrà separarli, nelle immediate difficoltà che una giovane esistenza imparerà presto a conoscere, in cui la vicinanza con i propri compagni di viaggio di vita rappresenterà la conferma di esso, la cui regola principale è che alla prima vendetta da attuare tutti vi dovranno partecipare. Un patto reso sacro con il sangue di ognuno spillato e versato nella boccetta di acqua santa, infine bevuta, che Mimmo, designato futuro sacerdote dal desiderio di una madre cattolica fervente, porta sempre con sé, come a ricordarsi della promessa all’Altissimo.
Primo, dal suo canto, non ama frequentare le funzioni religiose del suo paese; sembrerebbe come un rifiuto di principio, perché dal momento in cui il padre è venuto a mancare, sei anni prima, la consueta messa in suffragio annuale gli sembra ogni volta un nuovo funerale, come se la morte gli venisse a far visita puntualmente.
“Sogna, Primo, fallo sempre. Ma pianta i tuoi sogni nella terra: cresceranno robusti e non voleranno via”, recita la lettera che il genitore gli ha lasciato poco prima di morire.
Per esorcizzare ciò, tra l’altro, con Viola, la dolce sorellina, si rintana in una stanza e inventa delle storielle in cui il protagonista principale è il loro papà, nelle cui trame la vita non gli si è spezzata troppo presto, anzi, gli ha regalato la notorietà, la più giusta che si possa avere, perché una voce come la sua, che usava nell’arte canora, lo avrebbe portato di sicuro lontano, in una grande città magari, a frequentare Celentano, o Modugno.
Damiano, il belloccio del gruppo, ricorda Paul Newman nei tratti somatici; resta il più coraggioso, il più temerario e figura come guida spirituale, modello da seguire.
Figlio di un’ex attrice, bellissima, venuta via da Cinecittà per amore, quasi come una Grace Kelly nostrana, che sceglie la vita monotona di un paesino per dedicarsi alla famiglia, al marito fattore, che però muore di gelosia nei suoi confronti, serrandola in casa, al riparo da sguardi indiscreti, dai commenti bisbigliati al bar in cui si enunciano episodi mai avvenuti che metterebbero in dubbio la sua serietà.
Il paese, tutto, sembra essere richiamato all’ordine, unificato nella sua rintanata identità, soltanto durante la messa, dove la forza della fede unisce e sembra sgomberare possibili rancori, donando lucidità a tutti, tranne che al padre di Mimmo, periodicamente internato al manicomio, così fuori di testa, talmente partito che alla fine resta l’unico a conservare un pensiero filosofico consone a una personalità originale, le cui massime affascinano così tanto la mente dei ragazzi, che lo credono un genio, non a torto.
Il resto è da leggere, e assolutamente.
Questo romanzo è un esempio della parabola della vita, la stessa al cui vertice metteremo sempre il periodo di massima spensieratezza, lo stesso che vivono i ragazzi della storia, una linea ascendente, che s’incurva quasi poi a formare un arco, la sommità, il senso della felicità, appunto, poi all’improvviso discendente verso l’epilogo della narrazione, che rappresenta oltremodo la fine della briosità adolescenziale, molto spesso paragonata, anzi, in questo caso, analoga alla fine dell’esistenza terrena, quella degli affanni, innanzitutto.
C’è l’adolescenza privata della sua innocenza, una Bella Estate elevata all’ennesima potenza e, lo so che ciò sembrerebbe troppo azzardato, ma oggi, nel nuovo millennio tutto è ormai paragonabile; c’è l’involuzione della Natura morta di Caravaggio, la vita rigogliosa nei colori vivi dei suoi frutti, che poi si appassiscono, si spengono, muoiono, man mano che l’occhio ammira il dipinto seguendone la curva immaginaria. C’è il richiamo a Stand by me, il racconto, così come il film ispirato.
Come non si potrebbe amare?
Ogni volta che un romanzo mi rapisce, cerco di contattare il suo autore e oggi, col miracolo (sì, avete letto bene) di Internet, dei social, in cui tutto sembra fine a sè stesso ma possibile, se utilizzato in maniera concreta, sono riuscito a realizzare un’intervista a Mirko Sabatino, che ha apprezzato l’iniziativa, colmandomi lacune che si erano formate durante la lettura e la stesura di questa recensione.
Cosa ti ha spinto a scrivere un romanzo sulla fanciullezza oltraggiata?
I bambini sono la parte meravigliosa dell’umanità. Sono una promessa, una scommessa sul futuro, adulti in miniatura, più saggi degli adulti. Vanno protetti, ma vanno anche lasciati liberi di scoprirsi e di scoprire: tra queste due esigenze, si annida il pericolo. L’oltraggio della fanciullezza ha a che fare con la violazione del sacro.
Quanto c’è della tua adolescenza, di quella briosa, furiosa, ma stipata in un piccolo paese del Sud?
Sono nato e cresciuto a Foggia, che è una città grande: ma le dinamiche della vita adolescenziale e preadolescenziale al Sud sono le stesse sia in città sia in un paesino – e secondo me non solo al Sud. Della mia adolescenza, nel libro, c’è molto, ma anche niente. Ci sono certi codici forti, il linguaggio esoterico dei dodicenni, i sapori, gli odori, l’amicizia che ha quasi più valore dei vincoli familiari: ma per fortuna questa storia non è mai accaduta, né a me né a nessuno dei miei cari, e Primo, Damiano e Mimmo sono solo personaggi, molto vivi, ma personaggi di finzione.
Nel tuo libro il tema del suicidio è molto ricorrente. Questo gesto estremo risulta, nella storia che racconti, quasi come una via di fuga da una realtà opprimente, senza via d’uscita. Non temi che così i tuoi personaggi potrebbero da eroi, tramutarsi in anti-eroi?
Una volta che decidi di scrivere una storia, non hai molto controllo su quello che avviene. Non scegli molto; i personaggi fanno e dicono quello che vogliono. Quanto al tema del suicidio, è qualcosa che mi affascina e mi sconvolge: privarsi della vita decidendolo, richiede molta disperazione e molto coraggio, in quantità tali che dovrebbero garantire l’esclusione assoluta della sua possibilità. E invece succede, è qualcosa che l’essere umano è in grado di fare.
Don Gerardo, il parroco, è un personaggio ambiguo. Hai preso già coscienza della tua responsabilità nei confronti di chi ha sempre piena fiducia nei ministri della Chiesa?
Sì. Ma ho raccontato una storia, e la mia responsabilità è unicamente nei confronti della verosimiglianza. Non ne ho altre.
Gli avvenimenti che ci racconti avvengono nell’estate del 1963. Come sarebbe stato accolto, secondo te, questo romanzo, se fosse stato pubblicato nell’anno in cui è ambientato?
Sarebbe stato censurato, immagino.
I protagonisti della tua storia pensano quasi tutti a un esodo, a come dover fuggire dalla monotona vita di un paese con poche risorse per il futuro. Credi che oggi, nel nuovo millennio, stiamo pagando, noi del Sud, l’impazienza di andar via di quei tempi che ha causato il crescente abbandono delle nostre terre d’origine?
Non mi sento di condannare chi allora, spinto dalla necessità, ha abbandonato la sua terra per andare a cercare fortuna altrove. La stessa cosa accade oggi a noi giovani e meno giovani. La responsabilità, semmai, è da collocare più in alto. Ma una ventata di speranza, forse solo una leggera brezza, comincia a filtrare dalle storie di chi, dopo anni, fa ritorno al suo paese per inventarsi qualcosa, e provare a vivere lì.
La musica di quell’epoca, nel tuo libro, fa sempre da sottofondo, come una pausa riflessiva, in primis quella di Celentano e Modugno. Quali dei due pensi sia stato più “artista maledetto”?
Credo che siano due facce della stessa ribellione. Sarebbe più facile rispondere Celentano, che apparteneva alla categoria degli urlatori, che stavano scardinando i crooner italiani – come accadde anche in America con Sinatra, che rischiò di farsi oscurare da Elvis. Ma non successe, e i due coesistettero, perché erano e sono entrambi grandissimi, entrambi ribelli, solo con stili diversi. La ribellione ha diverse forme, e spesso ugualmente efficaci.
 L'estate muore giovane
L'estate muore giovane
Narrativa
Nottetempo
2018
304