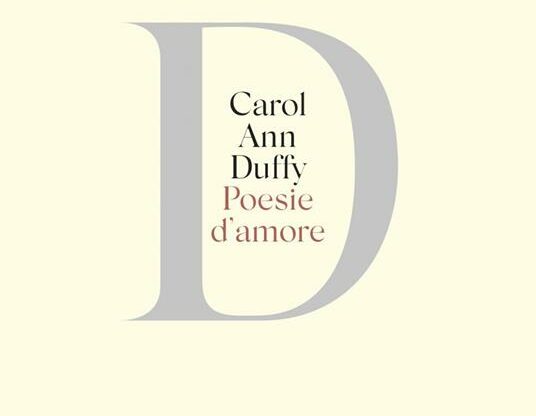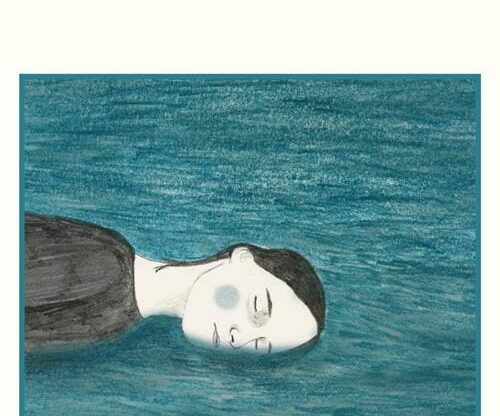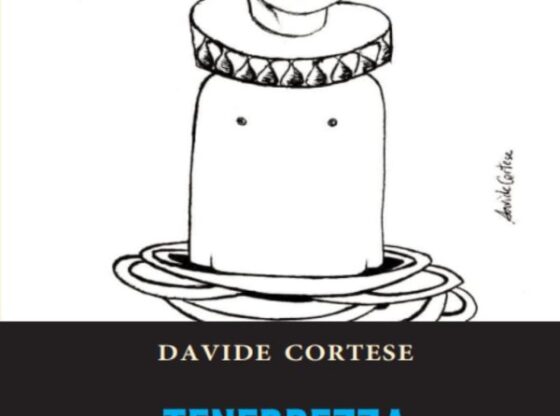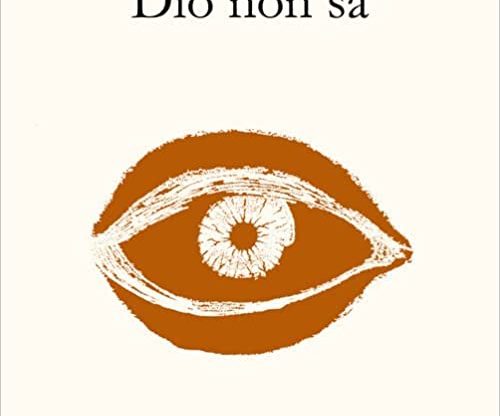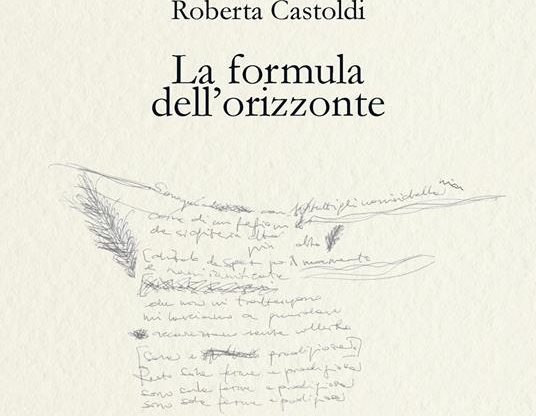“Una figura poetica d’idillio e d’inquietudine, o meglio di forzato e difficile idillio, che cerca di coprire con uno struggente sogno d’armonia una profonda inquietudine”, scrive Kuno Kohn, alias il poeta e artista Ugo Pierri, a proposito del suo compagno di scorribande letterarie Matteo Moder, alias Fabio Benes. Un gioco d’identità ci introduce alla raccolta di poesie, o meglio, di stanze aforistiche/poetiche, dal titolo “Nina” (Battello stampatore editore), opera del versatile, eclettico, geniale Moder, maestro della parola e sacerdote laico delle ultime disperanti forme di resistenza umana. Kuno Kohn, fannullone scanzonato e perverso, è il protagonista dei racconti di Alfred Lichtenstein, scrittore di scuola espressionista, morto in guerra a soli 25 anni: il funambolo triestino non poteva contare su un testimone migliore. Le composizioni di Moder, fanciullo pascoliano del XXI secolo secondo la definizione di Mary Barbara Tolusso, giornalista de Il Piccolo e lei stessa poetessa, si inquadrano infatti nel campo della dissoluzione nostalgica dei valori e delle certezze, nel flusso di un’arte poetica percorsa da malinconie mitteleuropee e innervata di citazioni dolenti.
“Nina” è suddiviso in due sezioni, la prima si intitola America o dell’intima rivoluzione femminile, la seconda Le siriane. Nina è metafora di una femminilità lacerata e sfruttata, tragico punto di arrivo di una civiltà nemica dei deboli e degli oppressi. Nina è il fantasma che si agita nelle macchine oliate del potere, è lo smascheramento ironico del grottesco, è la vita che «confina con la nuda presenza». Nina è fiore che tende i petali e spande bellezza nel suo appassire, Nina è «danza in controtempo, contro ogni cielo». Moder canta l’epopea tragica della Donna, il suo involontario martirio, i suoi sogni scaduti «in un mormorio d’assenza». Quanta innocenza sfregiata dal dolore in Nina, quanta purezza liricamente narrata, sia da un punto di vista esterno, «se fosse terra sarebbe deserto sguardo fisso nell’aperto», sia in prima persona, «io fui il coraggio, quell’insensibile stupido suono, senza scopo felice, e io, io sono». Quanti sorrisi mischiati al pianto.
Attraverso gli occhi di Nina, Moder vede un’America folle, brulicante di anime perse, archetipo del delirio politico e antropologico contemporaneo. L’autore triestino si riallaccia a una tradizione letteraria che rimanda, inevitabilmente, alle peripezie del giovane Karl Rossmann in Amerika di Kafka. Appena entrato in porto, Karl nota attorno alla Statua della Libertà una luce “d’un tratto più intensa”, mentre il braccio con la spada sembra “essersi appena alzato”. L’elezione di Donald Trump, «il Presiniente», invera le profezie contenute nella metafisica capovolta del grande praghese. L’assurdo esce dalle pagine dei profeti e diventa dettato positivo, inestricabile intreccio tra realtà e surrealtà, finzione e verità oscena. Qui, «in quest’aria che soffoca, in quest’aria cattiva», Nina trascina la sua mente e il suo corpo. Il suo incedere tra la folla massificata e indifferente avrebbe attirato l’attenzione di un altro illustre visionario, Federico Garcia Lorca, sedotto (e inorridito, ma di un orrore suadente) dai grattacieli di New York. “Giungevano i rumori della selva del vomito / con le donne vuote, con i bambini di cera calda, / con alberi fermentati e camerieri infaticabili / che servono piatti di sale sotto le arpe della saliva”. Donne vuote, come Nina, fuscelli smarriti in una nazione bulimica di ingiustizia. Era il 1929, anno di crolli… Similmente, il Duemila di Moder è ferito da altri crolli, spettacolari, iconici, spartiacque di epoche, perché «niente sarà mai come prima dei pompieri alle torri gemelle neanche questa rima appiccicata alle stelle». E quando Nina evoca un caffè deserto, dove «ogni domanda è lecita anche fuori tempo massimo anche per la donna che piscia accovacciata turca nel cesso di linoleum e carne», ritornano alla memoria anche le note di sarcasmo stese da Vladimir Majakovskij su quel crudele frutto del capitalismo chiamato disparità di classe, vergate durante il suo viaggio messicano e americano del 1925.
L’opera di Matteo Moder non può essere compresa senza pensare alla sua forma di scrittura, e all’estrema cura dimostrata nella redazione di tale struttura formale: precisa, pulita e rispondente ad un’urgenza comunicativa ultramoderna (sempre per citare Ugo Pierri). Chi conosce l’autore su Facebook, sa che il suo minuto e iperbolico lavoro narrativo si dipana quotidianamente sul social network, in post lucidi e brucianti. Nina nasce e vive, ancora oggi, su internet, e tuttavia sarebbe sbagliato considerare il testo stampato un alloggio innaturale. La scelta della carta non è un vezzo. Moder ha trasportato la sua creatura su un media classico, mantenendo inalterata l’originalità sintattica che ne contraddistingue lo statuto digitale. I tre puntini di sospensione (…) che concludono, senza chiudere, gli aforismi poetici, lasciano intendere sviluppi e digressioni, e soprattutto sollecitano l’immaginazione del lettore. Ne risulta un senso di continuità tra una stanza e l’altra, un reciproco chiamarsi delle microvicende, disegnate con rapidi schizzi impressionistici e costruite sullo scheletro di un ritmo sincopato, spezzato, rapsodico, quasi beat e jazzistico, grazie a frasi caratterizzate da una punteggiatura assoggettata ad un proprio codice e in alcuni casi abolita, revocata, per poi ricomparire, punti e virgole, a segnare il fiato della lettura, a troncare, a inchiodare il verbo. Anche qui, più che un pastiche stilistico, vince il bisogno di una libera espessione modulata sulle assonanze di valore interne, sulla vicinanza ribelle e scandalosa dei significati, nel libero schema di rime (a volte) baciate, cadenze fonetiche che ci accompagnano e ci fanno sostare nell’intrico/intrigo delle parole. Due esempi simmetrici e complementari:
«Si darà alla luna piena nel fuori scena del buio di sala nell’abito di gala un po’ sdrucito vecchio di ogni sogno non finito la luna che a sfiorarla le bastava un dito…»
«Si volta. No. Il muro la vuole a sé. I muscoli corde di inquietudine. Fissa senza guardare. Non arriva oltre la possibilità. Se ne avesse una. Voltarsi. Accettare l’aperto. Farsi chiamare. Farsi umana. Essere nel farsi. No. Non si volta. Il corpo trema. Il corpo non aspetta. Il corpo. Se è solo occhi che non vedono. Se è solo muro che. Se. Fosse implicante un sarebbe. Troppo. Era. Fu. È stata. Ma come è? Come? Il muro non si volta il muro. Dietro assassinano nomi. Dietro. Da qualche parte. Lei a dire tu. Io non le appartiene. Si volta. Muro…»
Scrittura automatica e frattura verbale, concatenamenti e terremoti sintattici: molti sono i registri adottati da Moder, e molti i nonsense, i neologismi e le ripetizioni cui si affida per drammatizzare con aulica leggerezza le disavventure di Nina: «il solito trump trump quotidiano», «un tempo Barackkato», «in questi tempi ciechi lei offre piatti di basta ai biechi». Le sostituzioni semantiche sono, spesso, le crepe da cui passa il tragico della Storia. Matteo Moder inventa una lingua per raccontare il disfacimento del mondo occidentale, confermando la sua vena di scrittore di impegno civile. L’autore triestino, utile ricordarlo ai più giovani, scriveva negli anni Novanta sul mitico Cuore – Settimanale di resistenza umana, commentando a modo suo, con versi folgoranti, la degenerazione politica seguita a Tangentopoli, il malaffare della seconda Repubblica, il degrado delle istituzioni. Ma quello fu anche il decennio delle guerre televisive e “intelligenti” promosse dal primo Bush (e non era il Bush peggiore!) e poi dall’astro del riformismo planetario Bill Clinton (che clamoroso abbaglio…), della dissoluzione della ex Jugoslavia, dell’assedio di Sarajevo e della vergogna di Srebrenica, dei massacri nel Ruanda, dell’intervento umanitario (o spacciato come tale) nel Kosovo. Moder, allora, trafiggeva le ipocrisie dei governi esportatori di democrazia con saette poetiche, come queste, radunate sotto il titolo di Infanzia: «I bambini iracheni / fanno giochi da fermi / non si muovono loro / li trasportano i vermi». E oggi, c’è la Siria…
La seconda parte di “Nina” affronta il tema della guerra siriana, il conflitto più atroce del Ventunesimo secolo, eppure sottovalutato e dimenticato dai nostri intellettuali, troppo impegnati a becchettarsi l’uno con l’altro, come i polli di Renzi, in sterili beghe di cortile. Matteo Moder dà prova di estrema sensibilità, calando i suoi aforistici versi nel caleidoscopio dell’inferno. «Lasciala andare non scuoterla più non vedi che dorme finalmente rilassata il sangue è il suo il tuo il nostro dirai un giorno fuori che questo tempo adesso devi lasciarlo andare come lei come il suo colore anche se il sangue anche se, ti puliranno il viso e berrai un po’ di tè caldo, la sirena dell’ambulanza coprirà gli ultimi spari, e quella che ricordando dirai disperazione…» È questo il campo di battaglia tra il Bene e il Male, tra l’Amore e la Morte, tra la Cura femminile e la Barbarie maschile, tra gli Oppressori e gli Oppressi. «C’è solo il vento a sfiorare la soglia la casa non c’è sono macerie le stanze. Chi viveva di questo silenzio se n’andata per un grado Richter o mille anni di pena, minato è il pane fino all’orizzonte della notte. Nessuno chiama, non ci sono interpreti del nulla…» Moder ci costringe a pensare una virgola dove brilla un’assenza, ci spinge a colmare i vuoti, a ridestarci da imbarazzanti torpori, a misurare le anomalie nel testo fino a rendere, questo esercizio, un solido pungolo morale. Il maledetto triestino rinnova la sua sfida all’attenzione cognitiva del lettore, ne stuzzica l’apatia sedimentata in cattiva coscienza. Moder è il poeta dello svanito candore, il cantore di «un bacio di polvere e addio». Ora che l’esercito di Assad è alle porte di Afrin e si prefigura un’ennesima carneficina (di curdi), il grido delle Siriane si alza lancinante, un avviso di sfratto alle nostre comodità.
Leggere Moder è come ascoltare gli ultimi Clash. Ogni canzone dei Clash pesava almeno il triplo delle canzoni dei gruppi coevi. Maggiore coerenza politica, più densità di significati, evidente preparazione ideologica tradotta in musica. Ma il loro punk degli esordi, alla fine, si era stemperato in un sound meticcio, e i testi introiettavano il languore delle battaglie sociali perdute. Possiamo dissertare all’infinito sui destini grami della sinistra e sul trionfo dei populismi. Quanti sociologi, filosofi, economisti ci vengono in soccorso… L’alternativa è aprire “Nina” di Matteo Moder, un diario di estasi, una storia di distruzione. Sentenze amaramente ironiche, piume di piombo per chi «non trova pace in questo Paese d’orbace».
 Nina
Nina
Poesia
Battello Stampatore
2017
52