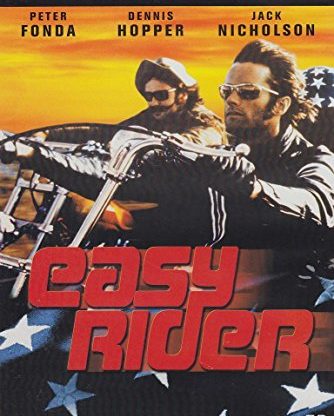Tutti i luoghi che ho visto,
che ho visitato, ora so ,
ne son certo:
non ci sono mai stato.
( “Esperienza”, di Giorgio Caproni, 1972 )
Immaginiamo di poter schematizzare il nostro pianeta per mezzo di circonferenze direzionali: ne deriverebbe chiaramente che, lungo ognuna di esse, sarebbe possibile seguire due versi, opposti, che alla fine si rincontrano e si sovrappongono. Ebbene, nelle opere letterarie di tutti i tempi è proprio lungo questi archi diversificati che si sono mossi i più significativi personaggi delle nostre narrazioni di culto; si pensi agli Achei che partono per Troia e si pensi a quanti di loro si sono poi mossi all’incontrario per poter tornare a casa. Si pensi ai clerici del medio Evo, ai crociati del Tasso, agli esploratori dei nuovi mondi, a Gulliver, a Candido di Voltaire, al Renzo manzoniano; eppure, ben prima di Gulliver e di Candido e di Renzo, nel pieno fiorire del Barocco del ‘600, mentre si codificava il genere della fiaba, in Italia con Basile, in Francia con Perrault, successe qualcosa che rese quel reticolato più complesso e carico di simbologie, per cui l’andare e il tornare lungo le strade divennero sempre più problematici e meno definibili.
La fiaba, infatti, connetteva l’andare (come era già successo nel poema di Ariosto) a una quête, a una ricerca, per altro carica di valenze sublimanti: l’andare era una sorta di prova espiativa, e il tornare rappresentava un premio latore del lieto fine. Quelle strade erano, perciò, già luogo di matrice copernicana e galileiana, e si poteva in esse avvertire spaesamento e anche smarrimento, conseguenze della perdita di quella perfezione circolare in cui ci aveva inclusi e protetti il sistema tolemaico: l’uomo copernicano era indotto a viaggi su strade il cui cielo non era più sotto la protezione di un divino firmamento, ma era un cielo mobile e infinito, estraneo e pauroso.
L’On the road nasce da tale spaesamento e disorientamento; i suoi eroi, che si chiamino Dorothy del Mago di Oz (eroina onirica di un viaggio allucinato) o Capitan America di Easy Rider, non vivono che lungo una strada: la “casa”, se l’hanno mai avuta, è lontana, un sorta di perduto miraggio tra l’infoltirsi della nebbia di una selva oscura. Non ci si meravigli, d’altra parte, del confronto tra due film lontani trent’anni: “Il Mago di Oz”, (Victor Fleming, 1939) era un’opera incredibilmente permeata da visioni di tipo psichedelico, laddove, all’inverso, la vicenda di Easy Rider è, soprattutto, una fiaba triste, una fiaba a cui è stato strappato ogni possibile lieto fine.
Wyatt (Peter Fonda), ovvero Capitan America, e Bill ( Dennis Hopper ) si lasciano alle spalle non una casa travolta da un tornado, come succede a Dorothy, ma una sorta di strana patria, la California dei figli dei fiori, la comunità hippy, che, quasi nella sua interezza aveva dato vita nel 1967, due anni prima di Woodstock e del film di Hopper, alla famosa “Summer of love” di San Francisco, a cui parteciparono ufficialmente 20.000 giovani, artisti vari ed importanti; come è noto a San Francisco non si trattò solo di un festival: l’estate dell’amore esplicitò un fenomeno particolare, forse unico, per cui una città come San Francisco, e, in particolare, alcuni suoi quartieri, divennero sede stabile, e “casa”, di gruppi di artisti, musicisti e scrittori, di giovani più o meno politicizzati, ma anche di gruppi di senza fissa dimora…San Francisco venne identificato con l’universo “hippy”, divenne una sorta di patria capovolta di questi ragazzi, per definizione apolidi; è da questi luoghi che vengono i due , Bill e Wyatt. Loro, quella “casa”, l’hanno già abbandonata e dissacrata : hanno venduto una “partita” di droga e con i proventi si sono comprati due Chopper della Harley-Davidson, ovviamente opportunamente decorati e modificati. Così, seguendo un percorso che si snoda tra i deserti del profondo sud degli Stati Uniti, i due cominciano il loro “On the road” .
Dodici anni prima era uscito il notissimo omonimo romanzo di Jack Keruack, scritto tra la fine degli anni ’40 e il 1951, ma alfine pubblicato solo nel 1957; di norma “Easy Rider” viene avvertito come una sorta di rivisitazione di tale romanzo, quasi una sceneggiatura libera di esso…ma in realtà Keruack non conosce ancora i fenomeni giovanili in cui si inseriscono le vicende di Bill e Wyatt, e poi di George. Il complesso, e stratificato, romanzo della beat generation, costruito in cinque macrosequenze, segue l’altalenante configurarsi di ribellione e ricomposizione borghese , secondo le prospettive caratteriali di Sal Paradise, pseudonimo di Jack Kerouac, che è il protagonista e narratore di una serie di viaggi in autostop, in auto e in autobus. Sal è uno studente cresciuto nell’Est che ha aspirazioni letterarie e conosce Dean Moriarty a New York, pseudonimo di Neal Cassady, che abita a Denver, nell’Ovest, uscito da un riformatorio e il cui stile di vita è in netto contrasto con la concezione borghese; tutti i personaggi del romanzo corrispondono ad amici di Kerouac: si tratta, dunque, di un romanzo autobiografico , pulsante, per altro, nella lingua originale, di un ritmo musicale jazzato, poco avvertibile nell’edizione tradotta. Compaiono, tra gli altri, con opportuni pseudonimi, Allen Ginsberg e William S. Burroughs, in un affresco grandioso di intellettuali che stavano provvedendo, con le loro opere notevoli, a una delegittimazione culturale degli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale; tra l’altro, a rendere particolarmente lontani ed estranei i due movimenti giovanili, i beat e gli hippies, occorre precisare anche che non sono ancora nati i “baby boomers” e non sono ancora morti John e Robert Kennedy e Martin Luther King… il romanzo di Kerouac, cioè, è solo un lontano antefatto di “Easy Rider”; è solo la cornice che dà un nome alle vicende, non meno di quanto dia un nome al genere il brano “On the road again” dei Canned Heat, brano pressoché coevo, del 1968, che tra blues e rock vagamente psichedelico, meglio corrisponde al film di Dennis Hopper.
In verità la Beat generation è una generazione di transizione, che influenza la letteratura e, ovviamente, anche il Cinema (si pensi a “Gioventù bruciata”, di Nicholas Ray, 1955), non conosce affatto le istanze mistiche da comunità orientaleggiante; sicché l’uscita di “Easy Rider” fu un “fatto” totalmente nuovo, che colpì l’intero universo americano, rivoluzionò il modo di concepire sia l’ultima generazione che il nuovo Cinema…, soprattutto, indicò i nuovi valori giovanili; si osservi il volto di George quando viene trasportato sul chopper: è estremamente sorridente; si guardi con attenzione alla scena di “libero amore” nella sorgente di acqua calda, che è una delle prime sequenze del film; si ripensi all’incontro dei due amici con l’avv. George in carcere…e poi alla morte di tutti e tre…ciò che colpisce è che i tre, nella loro indiscutibile non-appartenenza a quell’universo, risultano individui assetati di felicità. Sono partiti dalla California del mito, ma egualmente si sono disposti a rintracciare altrove un possibile stile di vita, di amore, una dimensione esistenziale “ludica”, nella quale gli affari, i titoli azionari, la scalata sociale, insomma i miti dell’upper-class sono disattivati totalmente.
E’ noto che George (Jack Nicholson), uscendo dal carcere ritiene di dover precisare che, grazie a lui, e all’influenza di suo padre, Bill e Wyatt non sono stati “rasati”(!)…per questa nuova tipologia di giovani conta, dunque, l’ineffabile, cioè ciò che per l’intera società americana risulta marginale. D’altronde nelle forme di abbigliamento degli Hippies è percepibile un desiderio di gioco, di travestimento, che rimarca la mutazione avvenuta: fiori, fasce nei capelli, colori stinti , tutto contribuisce a sottolineare le differenze antropologiche che stanno affiorando, anche le modalità paritarie con cui quei giovani si relazionano alle ragazze, comprese quelle del postribolo suggerito da George prime che fosse ucciso; di fatto in California si era andata delineando una nuova forma esistenziale, quasi una nuova forma evolutiva che rivendicava la gioia, il divertimento, la spensieratezza, fuori dai confini consumistici: è l’”Homo ludens”, di Johan Huizinga, 1938 “[…] la cultura sorge in forma ludica, dice Huizinga, la cultura è dapprima giocata. Nei giochi e con i giochi la vita sociale si riveste di forme sopra-biologiche che le conferiscono maggior valore. Con quei giochi la collettività esprime la sua interpretazione della vita e del mondo. Dunque ciò non significa che il gioco muta o si converte in cultura, ma piuttosto che la cultura nelle sue fasi originarie, porta il carattere di un gioco”. (Huizinga, Homo Ludens, Il Saggiatore, 1972)
Il testo di Huizinga, che venne capito e conosciuto solo vent’anni dopo la sua uscita, parte dalla considerazione che il gioco possa far emergere la capacità dell’uomo di abbandonarsi ad “ un altro mondo”, oltrepassando i limiti della mera funzione biologica e di sussistenza; il gioco, inteso come formula istintuale, si colloca all’interno della sfera spirituale che rappresenta l’altra grande dimensione necessaria dell’uomo, di cui è indispensabile elemento di ricerca.
Se esso è attività libera, disinteressata, non può che instaurare una realtà diversa da quella di tutti i giorni, e da quella a cui si abbandonano tutti gli altri; e allora non ci si deve meravigliare che i tre amici vengano uccisi: sono pericolosi assertori di una vita a cui tanti non sanno come giungere, per i quali il “gioco” è solo un ricordo vacuo e sbiadito dell’infanzia, vissuto, nel migliore dei casi, in forme codificate e controllate dagli adulti.
Immaginiamoli , allora, questi tre ragazzi che attraversano con le moto la “strada”; in verità attraversano non tanto una strada, ma il vento, l’aria, le nuvole, il cielo…i loro chopper, anche per la forma che hanno, sono “destrieri” (c’è una scena che pone in secondo piano rispetto al chopper, un cavallo che viene ferrato…), sono veri destrieri tipici dei cavalieri erranti, le cui disavventure, pur non essendo finalizzate alla ricerca di un Graal, hanno comunque qualcosa di sacrale; perché sacro è tutto ciò che risulta inattingibile ai molti: il sacro è ciò che altri non vedono e non possono neppure sfiorare, è quella dimensione spirituale di accesso all’esistenza da “Piccolo Principe”, per il quale la “libertà” è la cosa più importante, insieme all’amicizia; certo chiunque potrebbe obiettare che Bill, Wyatt e George sono soltanto spregiudicati individui avvezzi all’uso di droghe e alcool… ma va altresì sottolineato che Easy Rider è il primo film in cui non è il drogato a fare del male agli altri, piuttosto è colui che subisce, che diviene vittima della sua estraneità; nell’ esile trama del film, nel giro di pochi episodi, confezionati per mezzo di un montaggio a singhiozzo, certo rivoluzionario, e caratterizzato da dialoghi improvvisati, ci ritroviamo ben presto di fronte ai tre cavalieri che vengono uccisi e si accasciano accanto ai loro destrieri: il chopper, a cui si accostano morendo, era ciò che di più somigliava ad una casa, era, al contempo, lo spazio vitale delle loro pulsioni ludiche, e la rappresentazione di un mezzo che percorresse le loro fantasie fiorite e colorate, una dimensione da cui guardare il resto del mondo, avvertendone la distanza e, insieme, era una strana abitazione mobile, che riprendeva, da un lato, lo spirito pionieristico, dall’altro, la cifra della loro identità.
Tutto questo fa di Easy Rider un film ben diverso, per esempio da “Zabriskie Point” (Michelangelo Antonioni, 1970), dove il Road Movie si delinea in termini civili e politici: i due giovani fuggono, infatti, da qualcosa: lui è addirittura rincorso dalle forze dell’ordine: la ragazza in auto e lui con un piccolo aereo, fuggono da una realtà sentita come persecutoria e pericolosa; anche lei fugge, deve raggiungere il suo datore di lavoro e immagina un’esplosione apocalittica nella quale la Casa dove si sta dirigendo prende fuoco: è la visione di Antonioni che si fa estremamente dura e profetica nella condanna di tutto il sistema americano. In verità i due splendidi ragazzi di “Zabriskie Point” non cercano, se non in sottotraccia, una dimensione esistenziale ludico-spirituale: la loro storia è un tipico road movie nel quale il viaggio è “funzione” di contrapposizione e rivolta. In effetti il collaudato genere del Road movie è spesso riferibile trasversalmente a film di avventura, a thriller, a polizieschi (la commedia “Accadde una notte”, …), così come nella storia della letteratura di tutti i tempi il “viaggio” si presenta in forme tra loro diverse e, a volte perfino contrastanti. Gli antichi eroi partivano per guerre interminabili e tornavano, quando tornavano, lungo gli accidentati percorsi del nostos; già Dante sottrasse Odisseo al ritorno problematico ad Itaca e lo avviò di nuovo al Mare, dove avrebbe incontrato la montagna bruna che tutto seppellì.
Enea, a sua volta, lascia la casa e la patria e va incontro alle peripezie ben note; Roland non richiama Carlo Magno a Roncisvalle e non tornerà mai più dalla sua Alda; Petrarca non potrà più risiedere ad Avignone, alla quale cercherà per sempre un’alternativa, ma invano… tutto questo fino ai nostri giorni, dove l’allontanamento dalla casa è ora nostalgia pascoliana, ora satira cinematografica alla maniera de “Il sorpasso” di Dino Risi, che in America fu distribuito con il titolo “Easy life” ( piacque a Dennis Hopper e, sicuramente lo influenzò ). Così come è indiscutibile che i famosissimi brani musicali abbiano in qualche misura condotto per la loro strada i tre protagonisti: la prima traccia, già nel titolo , per esempio, spiega da dove vengono e cosa hanno fatto Wyatt e Bill, si tratta di The Pusher, di Steppenwolf, l’altra, sempre eseguita da Steppenwolf, “Born to be Wild”, è considerata da molti un’anticipazione dell’Heavy metal, nonché una sorta di inno dei motociclisti. E poi c’è la notissima “The Weight“, eseguita dagli Smith, anche se il pezzo era in realtà dei The Band. E molte altre, al punto che le varie tracce sono diventate un album di grande pregio: era l’anno di Woodstock e la produzione non solo era qualitativamente notevole, ma si attagliava perfettamente ai vissuti giovanili.
E se è vero che di quei vissuti Woodstock rivelò soprattutto l’aspetto più aspro e drammatico, se è vero che lo sforzo onirico- ludico e, con esso, la stessa ricerca della felicità non è sempre percepibile nelle varie opere di quei tempi, nelle quali la superficie è quella della trasgressione e dello sbandamento comportamentale, il concentrarsi dei giovani in un luogo o il percorrere lo stesso viaggio, il cercare le stesse destinazioni evidenziava, ed evidenzia, che quei tragitti direzionali, di cui si parlava in apertura, hanno delineato, in forma definitiva, l’esistenza di comunità giovanili, spesso anche confuse e disomogenee, ma che si autoriconoscono e, lungo quei tragitti, si cercano: questa aspetto, che ha modificato lo status sociale del ‘900, non si è più perso, al punto che anche i ragazzi di oggi si riconoscono ancora in Bill e Wyatt e George, nel loro viaggiare lungo i tragitti che hanno per tetto un cielo, per dimora una moto, e, come rifugio estremo alla crudeltà umana, la loro indefettibile amicizia.
E ciò continuerà ad esserci, in contrasto con tutto la folta letteratura del cinismo generazionale sui giovani, continuerà sicuramente ad esserci
“ …infin che ‘l mar fu sopra noi rinchiuso”
( canto XXVI dell’Inferno di Dante Alighieri)
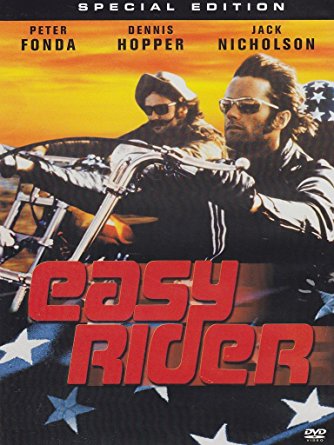 Easy Rider
Easy Rider
On the road
1969