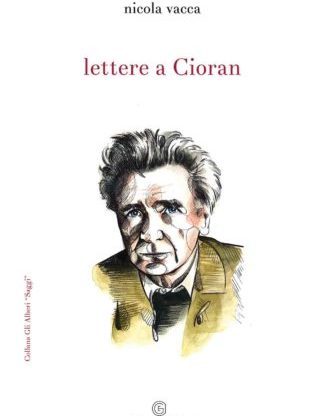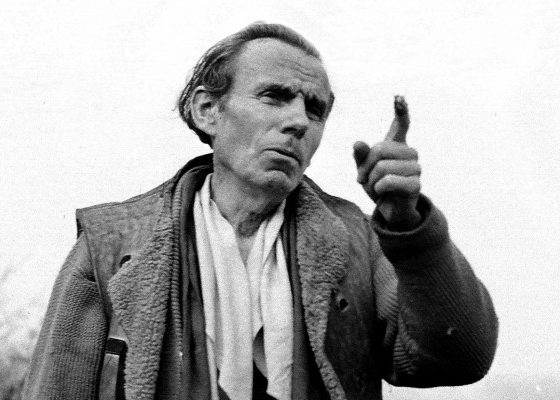Profonde ed intime queste Lettere a Cioran di Nicola Vacca, che declina la dimensione del paradosso inserendo necessariamente Cioran nel suo tempo anche se l’autentico Cioran è fuori dal tempo.
Più propriamente, cogliendo la direzione del suo percorso dalla “caduta nel tempo” alla “caduta dal tempo”.
E allora, se tanto postume quanto vere, sono queste lettere, perché non potrebbe essere lecita anche un’altra domanda? Proprio nel contesto intellettuale di quel tempo, a proposito di lettere: si sarebbero mai scritti, Emil Cioran e Walter Benjamin?
Non avremo, ovviamente, una risposta a quest’interrogativo, anche se veramente stimolante. Perché se è vero che questi due uomini quasi sicuramente non si incontrarono mai in quella Parigi che pure avevano scelto e, al contempo, era loro toccata come seconda patria, avrebbero avuto non solo moltissimo da dirsi ma, ancor prima, da condividere. Questi due straordinari intellettuali dell’Occidente, letteralmente spazzati in Francia dal turbine degli eventi del Novecento, vissero Parigi non solo come il luogo fisico che li aveva provvisoriamente e benignamente accolti sull’orlo del baratro, ma la trasfigurarono intellettualmente trasformandone i boulevards, l’aria, le tombe, nel grimaldello per scardinare nuclei di senso baluginanti nel più totale non senso.
Ecco, questo, appunto, il primo e capitale ponte tra i loro pensieri: frammenti dolenti, cocci acuminati, detriti putridi, corpi infermi, che, simmetricamente, si innalzano sulle “macerie” benjaminiane e sprofondano nelle “cadute nel tempo” cioraniane che il medesimo “angelus novus” fissa inesorabilmente nel suo volo sulla storia. Tenendo d’occhio i passages ridotti da epifania dell’espressione artistica e tecnica umana a rovine, superbi anticipatori dei nostri centri commerciali e quella Tour Eiffel pateticamente bruciata e consumata come un cero di sego nei mesti riti della borghesia cittadina.
Due necessari pensatori del frammentario che hanno camminato su zolle di pensiero galleggianti nel mare del non senso, ma le loro grida sembrano appena un flebile contrappunto ai megafoni delle grandi narrazioni rigonfianti le schiere degli eserciti che si preparavano alla mattanza della II guerra mondiale. Nicola Vacca ripercorre con passione e rigore quelle strade intersecando i crocevia di pensieri che disegnarono una cartografia intellettuale del Novecento che scelse proprio Parigi come mappa fisica e simbolica ad un tempo Una straordinaria densità intellettuale, una vera metropoli anche da questo punto di vista, ereditante degnamente il ruolo di Capitale del XIX secolo.
Le notti insonni di Cioran avvertono l’odore acre ma inebriante del medesimo eloquentissimo silenzio del Nome archetipico benjaminiano, mentre la degenerazione nella parola pretende di inchiodare nella definizione l’univocità del senso come un “assassino gentile” secondo il pensatore rumeno.
Perché per Cioran, il paradiso è il luogo in cui non si parla, l’universo prima del peccato, prima del commento ma gli fa eco Benjamin per il quale la lingua è andata incontro, nel corso della storia, ad una lenta corruzione rispetto ad un momento originario in cui essa fa tutt’uno con la verità.
Solo nell’ambito dell’esperienza paradisiaca l’uomo è in grado di usare il linguaggio in senso pienamente spirituale, ossia in analogia al linguaggio divino che crea le cose nominandole.
Due privatdenker che possono e vogliono parlare della loro esperienza umana, partire da essa, “pensatori privati” che nel rovescio dell’ordito della storia, nel silenzio dei vinti, come “Giobbe sul suo letamaio”, colgono l’unico, autentico momento rivoluzionario, una seconda possibilità.
Visione radicalmente antistoricistica e disincantata contro la gran cassa della sedicente marcia univoca del progresso e la dialettica positiva di stampo hegeliano.
Entrambi eredi, a proprio modo, del pensiero nietzschiano, se ne distaccano nella riflessione sul tempo:se Nietzsche pensa nella ciclicità ad un mondo futuro e Benjamin al Jetztzeit, il tempo-ora con lo sguardo dell’angelus rivolto al passato, Cioran combatte il tempo stesso, il tempo tout-court, che lo conduce dalla “caduta nel tempo” alla “caduta dal tempo”. “Ogni gesto è un evento, quasi un dramma in sé”, direbbe Benjamin ma questa caduta nel tempo non è definitiva per Cioran.
Questi due uomini conobbero la solitudine come amica e confidente, vissuta da Cioran “in quell’angosciosa malinconia che egli chiama cafard” come scrive Nicola Vacca, riallacciandosi alle parole del pensatore rumeno che annota nei Quaderni, elevandolo a cifra di questa Terra: “In Francia non si conosce la nostalgia, si conosce solo il cafard” e aggiungendo, oltre:“Di positivo in me c’è soltanto un bisogno di solitudine. Tutto il resto è menzogna e tradimento, infedeltà a me stesso”.
Benjamin, pur avendo vissuto profonde ma contrastate amicizie:Bertold Brecht, Gershom Scholem, Hannah Arendt e soprattutto, il controverso rapporto intellettuale con Theodor Adorno, è, di fatto, vissuto come un solitario, respinto, per un verso, dal mondo accademico universitario e politico e, per l’altro, combattuto internamente, egli stesso, nell’indecisione di una scelta tra due prospettive diverse:la Palestina e gli Stati Uniti.
Nella titubanza si attarda in terra di Francia firmando, di fatto, il suo tragico destino. Apolidi metafisici, erranti senza patria ed eredi di quell’esilio della parola che li accomuna nella condivisione di quella tradizione veterotestamentaria che non pretende una medesima genealogia ebraica di sangue ma di scrittura, di pensiero.
“Portare un nome è rivendicare un modo esatto di crollare” sostiene Cioran in quanto il nome intercetta il nucleo autentico di ciascuno, come riflette Benjamin.
Se lo scetticismo per Cioran è addirittura “un atto politico” come afferma Nicola Vacca, non di meno Benjamin preferisce alla corrispondenza biunivoca del simbolo, la dimensione spiazzante dell’allegoria.
Sottrarci alla pretesa della definizione univoca, della ineluttabile saldatura simbolica attraverso quel “parlare d’altro”, quel differimento eterno di un epitaffio ultimo.
Cioran aggiungerà: “Io sono un essere per metafora“, più propriamente “una metafora che metaforizza”. Questo il motivo della predilezione, da parte di Benjamin, del Barocco, epitome del frammentario, summa di incrostazioni di senso.
Quella predilezione incompresa invece, da una cultura malata di sistematicità ed ordine, forse, proprio di quella malattia della ragione nella pretesa di essere l’unico metro del reale, come ritenevano i Francofortesi con cui Benjamin ebbe un tormentato rapporto intellettuale.
Scavando nelle sublimi macerie di riflessione di questi due grandi, si potrebbe ricostruire una civiltà di pensiero sepolta dall’ossessione della lettura univoca delle accademie, un’archeologia di tesori che partono dal passato per proiettarsi profeticamente nel futuro.
Passato che essi, in primis, hanno saputo interrogare ed ascoltare in una visione “in cui, quasi proustianamente il presente ed il passato si uniscono in una singolare costellazione” come scrive Giulio Schiavoni nel suo saggio Walter Benjamin Il figlio della felicità.
Nell’opera di scavo troveremmo, sicuramente, ulteriori nodi di consonanza tra queste due figure e non meno quelli di frizione che, ci piace pensare, loro stessi avrebbero approfondito e condiviso, se si fossero realmente incontrati.
Quanto a noi, da ultimo, l’eredità della quale dovremmo essere all’altezza, come questi due intellettuali hanno insegnato, consisterebbe, nietzschianamente, nel saper tramontare per essere autenticamente il senso della terra, ma, forse, l’Occidente, distratto da se stesso, non sa o non vuole cogliere il nucleo più intimo e tragico proprio nel suo Nome.
Del resto somos los que se van.
Paolo Fiore
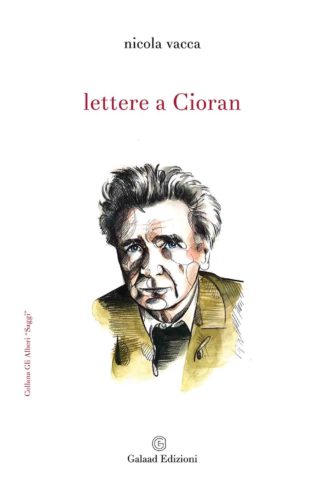 Lettere a Cioran
Lettere a Cioran
Critica letteraria
Galaad Edizioni
2017
104