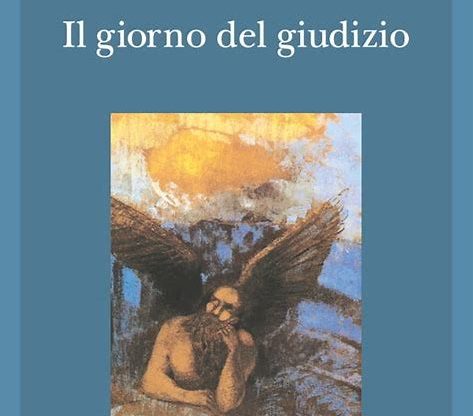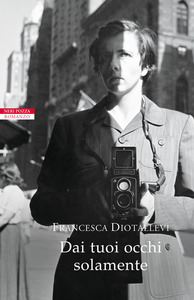Gianluca Garrapa: Gimmo, in piedi sotto la veranda, non riconobbe subito suo padre alla guida. Né poté farlo Michele, accovacciato su una sdraio cadente qualche metro più in là, visto che era poco più che un poppante la notte in cui i lampeggianti vennero a portarsi via l’uomo. (pag.11)
Il romanzo si apre tre giorni dopo la morte del nonno di Gimmo e Michele. Intorno alle vicende dei due fratelli si snodano le storie di un Salento arcaico, ipermoderno, arretrato, selvaggio. La morte. Il vuoto. Le suore, il divino, il misticismo e la vendetta. La polvere. Per la tua scrittura si sono usate etichette come western, gotico, noir, ecc. ecc. a me non piace, seppure torni comodo, incasellare in generi i romanzi de-generi. E le opere. Intendo che questo romanzo è innanzitutto una scrittura del desiderio. L’autore è un soggetto desiderante che dalla propria storia cerca una risposta. L’attende, in silenzio, sparendo dietro personaggi che incarnano sempre una relazione con l’Altro. Con il desiderio dell’altro: i due fratelli, eccoli. I figli. Siamo tutti figli, e capiamo bene cosa significhi abbandono. A questa coppia si oppone in diametro opposto quella degli adulti Carmine Capumalata e Tore Della Cucchiara (il padre dei due fratelli). Non si svelerà in che modo. E non lo si farà per altri snodi che scioccano la lettura in però non facili colpi di scena. Il mordente dell’estraneo nel familiare, l’anamorfico apparire del perturbante in una terra straniante di suo, Èrumu frati, farfugliò Carmine in un colpo di tosse (pag. 201): nella lingua, innanzitutto. Italiano alto, non rari i termini desueti, e dialetto, che pure la sua difficoltà ce la ha a essere riscritto. Lingua dei padri, della legge e della grammatica e lalangue materna della Terra. Le donne vi appaiono velate, fuori dalla storia, quasi, ma fulcro della vicenda: abbandono, morte, spregiudicata bellezza che cattura e denuncia. Anche di questo non si dirà troppo. Per ora solo capire l’epidermide del romanzo, la lingua: come hai lavorato nell’imbastire termini desueti, colti, toscanismi, e termini dialettali? E l’orchestrazione del fraseggio, che della voce narrante è sinfonica e ben aggettivata, calibrata su una ricchezza che sfiora l’esuberanza barocca senza manierismo alcuno, e dei discorsi parlati dai personaggi è locuzione locale, turpiloquace, passami il termine, botta e risposta, colloquio: quali i tuoi riferimenti, o i tuoi maestri? (se ce ne sono stati?)
Omar Di Monopoli: Penso di poter dichiarare senza rischio di fraintendimento (che a toccare i mostri sacri si fa peccato) quanto la mia pagina sia il frutto di una sedimentazione sperimentale che affonda le sue radici nel “sensazionalismo” espressionista di matrice faulkneriana. E infatti proprio dal grande bardo del Mississippi ho spudoratamente saccheggiato e fatto miei una prospettiva, un’ottica nonché un lavoro sulla lingua che mi hanno spalancato un mondo, consegnando nuove coordinate letterarie al mio lavoro: ho cominciato a rielaborare la mia terra, la Puglia, come un posto non troppo dissimile dall’America dei grandi romanzi southern-gothic ed è proprio grazie alla scoperta dell’opera di William Faulkner che ho potuto risalire la foce delle grandi penne del sud nostrano: Verga, De Roberto e Capuana prima, D’Arrigo, Consolo e Bufalino poi (con sguardo rivolto al lavoro anche della Ortese, di Landolfi e dell’inarrivabile Fenoglio) fino ad arrivare agli scrittori della porta accanto, quelli pugliesi, meno noti forse, eppure amatissimi: Bodini, Verri e Bene solo per fare qualche esempio. Certo è paradossale – e probabilmente paradigmatico – che tutto ciò che la scuola mi aveva insegnato a tenere lontano l’abbia riscoperto in seguito grazie agli scrittori d’oltreoceano, ma questo è stato il mio cammino e sono lieto che attraverso di esso la mia “voce” sia riuscita a convogliare tutte le istanze che la sorreggono in un unico, personalissimo afflato narrativo.
G.G: I lineamenti contraffatti dall’uomo solo ora pienamente rivolti alla telecamera, assorbiti da un accidentale appello: Antonia, bambina mia, perché mi stai facendo questo? Sangue del mio sangue, cuore mio, perché? supplica rivolto al vuoto onnivoro della televisione, e l’empio sussurro di commozione contenuto nel suo respiro sembra per un solo singolo istante in grado di travalicare i confini dello schermo, smascherare l’immonda, patetica e spregevole messinscena con cui ogni uomo cerca sin dalla notte dei tempi di fottere il suo eterno qui-e-ora. (pp. 131-132)
Dopo. Prima. Dopo. Prima. Dopo. Prima: è questo l’andamento binario, l’alternanza dei capitoli il cui presente è sempre dopo, o prima. Poi c’è la televisione, quell’unico inserto che si ripete tre volte, in carattere corsivo ogni spazio che gli pertiene, in cui sembra la parola catodica galleggiare in presente eterno, che tutto risucchia. Occhio alla Notizia: e senza svelare il perché e svelare la trama a quei pochi che ancora non ti hanno letto, dico solo che nel ‘vuoto onnivoro della televisione’ vedo apparire quel vuoto del godimento scopico della Cosa, La Chose, di lacaniana memoria e in generale, a parte il, per me, sottotesto pasoliniano ancora attualissimo, della feroce banalità della televisione, vuoto percepibile, grande presenza alternata alla vuotezza degli sterminati paesaggi, viva presenza del vuoto. Da un lato il rigoglio di una scrittura colma di sangue, carne e, per citare Perniola, del tuo caratteristico ‘splendore del realismo odierno’, e all’opposto il nulla, perché davvero l’altro sembra non esserci, non sembra esserci desiderio, né progetto. Un vuoto che non è causativo di alcunché: tutta sta terra abbandonata serve solo a coprire il letame cancerogeno, il criminale inquinamento, è davvero la terra quel godimento mortifero delle mafie, delle estati immense che durano quattro mesi di opulenza magnifica, di ostentazione affannosa e poi… di nuovo il nulla: Malinconia e degrado, come una patina di polvere imperitura, offuscavano l’aria, le piazze, le piante e i sogni di chi laggiù era costretto ad abitarci. Non c’erano cinema né teatri, a Rocca Bardata. (p. 45), la polvere rossa del marziano pianeta autistico della siderurgia che sta sterminando il mondo. Dio non c’è. Siamo soli. Viviamo come capita e poi tutto finisce. Non c’è altro. (p. 162) La tua scrittura che rapporto ha con certa filmografia? come lavori, a partire dalle immagini e dal linguaggio, intorno a questo ‘silenzio di Dio’ a questo vuoto umano e omertoso: Questa la regola di voi uomini duri ète: mai una parola con nessuno, ogni cosa un segreto è… Ciài fatto avvelenare il sangue, alla mamma, co ste stronzate tue da camburrista… (p. 135)? Cosa o come dovrebbe scrivere uno scrittore quando affronta la questione di questo inquinamento tumorale e morale dell’ambiente salentino? È anche una metonimia, lo spazio salentino, di una situazione più generale?
ODM: Ovviamente non può che trattarsi di uno spazio metonimico, altrimenti si fa solo letteratura d’evasione (la quale, tra l’altro, non ritengo essere necessariamente più debole e illegittima di quella ritenuta, a torto o a ragione, ‘maggiore’), ma la differenza credo stia nel modo di porsi, nell’affrontare una terra disgraziata cercando di farne l’epitome di tutte le terre marginali e sconsiderate: il sud come campo di battaglia omerico in cui tutte le cose – dalle più truci alle più maestose – accadono. E poi c’è la volontà di celebrare un èpos (e forse anche un ethos), quello della provincia popolata dagli ultimi e dai reietti, per scorticare la realtà di un mondo barbaro attraverso l’esagerazione e l’iperbole. Una sfida, forse, che non può che concludersi con una capitolazione, ma l’arte deve provare a farsi carico della distonia per cercare di decodificare la realtà, se no è solo aria fritta. Sull’impronta cinematografica dirò che un certo immaginario fa parte da sempre del mio background (ero, o cercavo di essere, un fumettista, all’università!) e sono cresciuto a suon di pistole fumanti e «trielli». Sergio Leone veniva addirittura veramente in Puglia a prendere le belle facce da peones per i suoi film, e, per dire, un ottuagenario di Manduria, cittadina in cui vivo, aveva un ruolo importante ne Il buono, il brutto e il cattivo, nella scena in cui impiccano Tuco.
G.G: Stava issando una sfilza di galleggianti gremiti di cozze nella sua minuscola imbarcazione di legno laccato, quando improvvise girandole di luce fosforica screziarono l’alba sprigionandosi dalle smagliature tra le brume ai bordi del cielo.
Nell’enfasi dei suoi ultimi sermoni, mentre il male gli scavava un buco nello stomaco e la sordità l’aveva reso distante e imperiale come un re dimenticato, mbà Nuzzo era solito riferirsi a quel piovoso mattino di quarant’anni prima come al Giorno della Rivelazione. (p. 17)
La psicosi irrompe non come rifiuto del reale ma come un buco nel simbolico. L’irruzione del totalmente altro, che però è profondamente interiore, ma che nel simbolico del linguaggio non è stato catturato, assimilato. Di psicosi alcuni parlavano, di forclusione inconscia del Nome del Padre, di castrazione, di vuoto che viene espulso, in questa terra del rimorso, molti etnopischiatri la vedevano in questo modo la questione della Taranta. E l’immagine del nonno santone è, a mio avviso, un tutt’uno con la tua scrittura ma per contrasto: laddove le maglie del simbolico, del linguaggio, non riescono a reggere le cose, la parola scritta si adegua alle cose stesse, I cardini emisero un fonema graffiante (p. 192), oppure al dialetto, insomma. Ma in realtà la domanda è un’altra: che rapporto hai col divino e in che modo credi che una scrittura possa parlarne?
ODM: Sono un incrollabile ateo, purtroppo, ma tento di pormi nei confronti del divino alla maniera di Flannery O’Connor, cercando quindi non rappresentazioni realistiche della scena sociale in cui i miei personaggi sguazzano ma insufflando visioni di Dio come esso appare a chi abbia una concezione antropocentrica del mondo: nei racconti della grandissima scrittrice statunitense i personaggi vivono la presenza divina come una violenza e un’offesa, un intervento distruttivo che sconvolge l’equilibrio del loro mondo. A tal punto che la visione religiosa che si ricava tra le sue pagine è spesso opprimente. Ma d’altra parte morte, sofferenza e disordine sono i mezzi attraverso i quali un personaggio passa da una comprensione meschina (e superficiale) dell’esistenza al mistero nel quale l’uomo vive e muore. Ecco, arrivare a questa sintesi, anche solo rasentarla, sarebbe per me fonte di immensa soddisfazione.
G.G: E forse il silenzio con cui sembra vi stia punendo altro non è che il tentativo di rimodulare il proprio presente senza il peso dei nodi irrisolti del passato. La vita in quella parte dell’Africa può essere parecchio complicata, sapete? (p. 154), dice la badessa al signor Bordin riferendosi a sua figlia Gemma, (anche qui ritorna il legame con il padre, ma dal punto di vista di una donna, la badessa Narcissa, che con gli uomini ha un rapporto molto particolare, e di Gemma: figure speculari quanto a corpo e sessualità… molto legate, se si vuole e non si vuole svelare null’altro). Ecco, si diceva del religioso e del rimorso e del passato: credi che la storia del mezzogiorno sia ancora una storia del passato? viva ancora una dimensione nevrotica e patriarcale (il nome del padre può ordinare il desiderio e salvarci, ma può anche operare la deriva verso il godimento mortifero: in questo senso la tua è una scrittura che modula legge e desiderio, l’io autoriale sparisce dalla malattia e dal disastro dei personaggi e della terra. L’io che narra non è egocentrico, non utilizza la terapia della parola, non allucina le proprie abbacinanti realtà traumatizzate)? e credi che il passato, proustianamente, possa riavvolgere un senso nuovo e uno sguardo più puro sul mondo del presente anche quando sembra tornare quasi per inerzia a quell’isolamento arcano e selvaggio che caratterizzava quelle lande fin dai tempi dei Borbone (p. 45)?
ODM: Non è generalmente un problema che mi pongo in questi termini, giacché trasporto sulla carta istanze che probabilmente di portano appresso un certo modo genuinamente problematico di fare i conti col passato. Le terre che descrivo sono spesso terre senza tempo, luoghi più o meno metaforici in cui passato e presente si fondono in una giustapposizione che però finisce inevitabilmente per stridere. Nei miei interventi pubblici sono solito fare riferimento alla coesistenza, nei luoghi in cui vivo, del wi-fi e della “maciara”, quasi a dire insomma che tradizione e progresso sono facce di una medesima medaglia oppure sono la necessaria scintilla che produce non di rado un attrito sì doloroso, ma al tempo stesso fondamentale per creare le storie (e quindi, forse, la vita).
G.G: Porccoddio, si lasciò andare Gimmo, mesmerizzato da quello spettacolo di rovinosa bellezza, mentre dalla scatola scoperchiata tra le su dita, piegata a mezz’aria, ruzzolava ai loro piedi la massa sferica e semicava di un teschio (p. 146). Non sveliamo quale sia questo spettacolo, e nemmeno di chi sia il teschio. Ma interessante sarebbe capire, per restare all’epidermide della storia, perché il romanzo abbia scelto questa alternanza di prima e dopo e, infine, che rapporto hai con i luoghi che descrivi, con le situazioni che racconti? quando Michele tirò fuori la rana dalla tasca e la impiccò a un amo libero poco sopra alla sua testa (p. 70) e poco prima, nella stessa pagina: una segreta, silenziosa carneficina occultata nella selvatica cupezza della natura in cui il bambino stava scontando la sua infanzia, quando scriveva questo in che modo ritornava, se ritornava, la propria infanzia, per voce narrante?
ODM: Il vissuto di un autore filtra inesorabilmente nelle pagine di un romanzo, anche se sono abbastanza convinto che uno scrittore scopra di essere diventato uno scrittore (e non più uno scrivente) nel momento in cui riesce a mettere la giusta distanza tra la propria biografia e la prosa di cui è artefice. Naturalmente è ovvio che alcuni lacerti di vita personale fuoriescano a dispetto della volontà dell’autore. Per esempio in questo libro c’è una marcata ricerca della figura paterna, talvolta addirittura sfacciatamente manifesta, e questo perché durante la stesura ho davvero perso mio di padre e quindi il tentativo (vano) di carpire una qualche spiegazione alla sua assenza è venuto fuori nonostante il mio intento di celare quello che è a tutti gli effetti un fronte eminentemente privato. Come quando scrivevo la Legge di Fonzi e raccontavo di un protagonista che aveva la mamma legata al letto per i troppi chili e io in quel momento avevo mia madre allettata per una malattia debilitante che poi me la portò via. Ribadisco: la biografia vuoi o non vuoi viene sempre fuori, magari in forme diverse, traslate, ma alla lunga esplode. Soprattutto il teatro in cui faccio accadere le cose somiglia a quello che abitualmente vivo, così come è evidente che miasmi cancerosi dell’Ilva li conosco a menadito anch’io, proprio come i protagonisti di Nella perfida terra di Dio.
G.G: In lontananza, velati dalla caligine, i cupi boccagli delle ciminiere dell’impianto siderurgico striavano il cielo con plumbee volute di fumo. (p. 15) Oppure: Il sole stava sporgendosi dall’estremo lembo del creato come un occhio che sbircia da dietro un muricciolo, eppure ogni promessa di luce annegava a tradimento in una distesa mobile di nuvolaglia scura (p. 19), oppure: L’aria, ancora calda come un braciere, si smembrava e precipitava svagando ovunque sentori di ozono e argilla bagnata (p. 133) e anche: Sbuffi di fluido elettrico continuavano a irrorare il cielo come mute saldature incandescenti (p. 141) e anche: a quell’ora il sole accendeva la bruma all’orizzonte addensandola in un sudario color salmone contro cui gli alberi si stagliavano gracili come trine bruciate. (p. 107)
Poetiche. Le descrizioni. Molto, spesso. Lo sguardo è poetico, ironico e il poetico, con il comico, è l’aspetto fondante del desiderio perché soggettiva il linguaggio nella parola dell’individuo unico e irripetibile che siamo. Che rapporto hai con la poesia, ne leggi, ne hai scritta? Ti interessa?
ODM: Non sono un grande consumatore di poesia, ahimè, per quanto quella poca che mi passa tra le mani sia per me fonte di inesauribile pungolo e sollecitazione, sia creativa che esistenziale. Sono però convinto che le due forme espressive, poesia e prosa, giochino due campionati completamente diversi, non migliore né peggiore, solo diversi, e ognuno deve fare ciò che sa fare, per farlo nella migliore delle maniere. Quando mi capita di leggere poeti italiani, soprattutto i contemporanei più accreditati, mi rendo conto della incredibile fatica che fanno sulla parola, e questo mi incoraggia, al tempo stesso la profondità di un verso, la sua capacità di toccare corde nascoste del mio animo è un mistero cui guardo con invidia e ammirazione: ho sempre l’impressione che un romanzo, per quanto “lirico” e approfondito, resti materia grossolana, volutamente dozzinale.
G.G: … l’uomo, al pari d’un vitello marchiato a fuoco, s’abbandonò a un lungo e terribile urlo che non sembrò minimamente scuotere né glorificare la squassata fissità di quel microscopico lembo della perfida terra di Dio. Rimase tutto tale e quale, e alla fine il silenzio senza peso del tempo calò unanime e indifferente a riguadagnare il proscenio. (p. 173)
Grazie!
 Nella perfida terra di Dio
Nella perfida terra di Dio
Letteratura italiana
Adelphi
2017
205