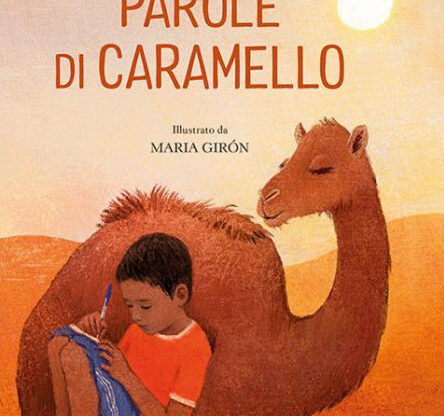Con il rigore della giornalista d’inchiesta e lo sguardo misericordioso privo di retorica dei migliori scrittori, Majgull Axelsson con il suo Io non mi chiamo Miriam, ci regala una prospettiva nuova e rischiosa sull’universo dei campi di sterminio. Un libro di due anni fa che non smette, purtroppo di essere attuale. Perché non smette di essere attuale la barbarie e l’orrore. Riproporne la lettura, in questi giorni in cui questo paese sembra tornato cupo, rancoroso e livoroso, risponde all’urgenza di tenere alta l’attenzione rispetto a tutte le derive xenofobe e razziste che rappresentano la facile tentazione di vivere semplificando.
Io non mi chiamo Miriam è un libro che entra sotto la pelle e non lascia scampo. Perché, in un certo senso, parla di ciascuno di noi e a ciascuno di noi. Miriam, la protagonista, era poco più che ragazzina quando la follia e l’insensatezza del nazismo stavano cominciando a spargere la loro mefitica ombra sull’Europa. Ma, all’epoca, Miriam si chiamava ancora Malika ed era una rom. Persa la sua famiglia, persa la sua vita, Malika perderà anche la sua identità, per salvarsi. Durante il viaggio da Auschwitz a Ravensbruck Malika sottrarrà i vestiti di una compagna di viaggio, morta, e ne assumerà identità, numero di matricola e, forse, storia. E qui ecco il primo scossone ai tabù che hanno sempre circondato la letteratura concentrazionaria: nessuno, come il popolo ebraico, ha attraversato un inferno come quello predisposto per lui nei campi di sterminio. Eppure, in queste pagine, ci viene raccontato di una donna che, per “salvarsi”, si finge ebrea. Una salvezza, certo, che entra più nel campo di un’ipotesi teologica e identitaria ma che, indubbiamente rappresenta una rottura e una scelta difficile per l’autrice.
Un gioco rischioso il suo perché, come scrive puntualmente Bjorn Larsson nella postfazione, la Axelsson riesce a camminare sul filo sottile che divide testimonianza e letteratura. Mantenendosi in equilibrio, etico oltre che narrativo, tra il dire che c’era un popolo, il popolo rom, disprezzato forse ancor più degli ebrei (e dagli ebrei stessi) ma, nello stesso tempo, raccontandoci con precisione e spavento, ciò che accadeva agli ebrei nei campi di sterminio. Non è dunque, il suo, uno schierarsi, inutile e dannoso, ma semmai un richiamo, davvero, a non dimenticare.
È un libro feroce, crudele, che incorre anche in quello che, quasi all’unanimità, è stato considerato un diritto esclusivo, quello di rendere possibile e accettabile solo il racconto dei veri sopravvissuti. Come si può muovere, la letteratura, nel campo minato dell’indicibile, di ciò che non è stato creduto possibile per molto tempo, di ciò che può essere raccontato solo da chi lo ha vissuto? Altri libri hanno raccontato il nazismo e le persecuzioni, altri romanzi. Ma questo è entrato, a gamba tesa, dentro i campi di sterminio e lo ha fatto con la letteratura. Prendendosi il diritto, e forse l’arbitrio, di dare alla letteratura il suo valore di testimonianza. Comunque. Alla letteratura non si può e non si deve chiedere di essere “vera”, ma le si deve concedere la possibilità e la responsabilità di essere verosimile. Non c’è nulla di inventato, eppure tutto lo è. Ma solo per questo è meno vero? Io non mi chiamo Miriam scuote con le armi della letteratura e della sua capacità di “tradire” e di tradurre la realtà storica, con la capacità di emozionare che è della narrativa. Altri testi, imprescindibili e terribili, come quelli di Levi, si muovevano su un altro versante, costringendoci a metterci in gioco su altri piani. Questo, proprio perché è letteratura, smuove altri livelli e ci fa sentire (quasi come una vertigine) tutta la paura, lo sgomento, il terrore, il freddo, la fame, la morte.
Io non mi chiamo Miriam è un libro sull’identità e sulla perdita di essa, sulla volontaria perdita dell’identità, sul nascondimento di essa e, in un certo senso, sul rinnegarla. Miriam vivrà tutto il resto della sua vita nascondendo la sua identità rom, continuando a fingersi ebrea in una Svezia che, per ripulirsi la coscienza, accoglierà gli ebrei ma continuerà a disprezzare i rom. Miriam/Malika perpetuerà la violenza del nazismo cancellando ciò che è, a partire dalla sua lingua. La sua straordinaria capacità di imparare altre lingue sembra un feroce contrappasso del suo non poter più parlare la sua, quel romanès che non può più farsi voce. E allora scava, impedendole di dimenticare e di dimenticarsi.
Non è un libro che voglia stabilire un privilegio negativo. Raccontare la storia di una donna rom è però il modo per raccontare la storia di un popolo perseguitato perché considerato criminale, un popolo di ladri di oggetti e di bambini altrui (sì, lo si è sempre detto, non è pregiudizio nuovo). Un popolo odiato, perseguitato e disprezzato perché il suo nomadismo era metafora del suo essere fuori dalle regole, fuori dalle leggi, fuori dal controllo. Capace, come nessun altro, di ribellarsi addirittura alle SS che dovranno, ad Auschwitz, abbandonare l’idea di entrare in una delle loro baracche, difesa con i denti e con l’orgoglio. I nazisti avevano paura dei rom, al punto tale che, a differenza di quanto facevano con altre etnie e altri gruppi, non dividevano le famiglie. Perché sapevano che non lo avrebbero mai accettato e si sarebbero ribellati. Miriam, rinunciando a tutto ciò, rinunciando a Malika, forse si salverà. Ma a che prezzo?
Forse allo stesso prezzo pagato, ancora adesso, dal popolo rom. È un romanzo, questo, di malintesi, di giochi di specchi, di pregiudizi e di non detto. Che sono poi il terreno più fertile per la nascita, o rinascita, di ogni razzismo. E se la finzione letteraria ha consentito la realizzazione di un libro come questo, allora sarà la letteratura, ancora e sempre, a rappresentare la prima forma di resistenza ad ogni caduta nella “disumanità”.
 Io non mi chiamo Miriam
Io non mi chiamo Miriam
Letteratura
Iperborea
2016
562