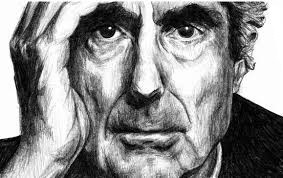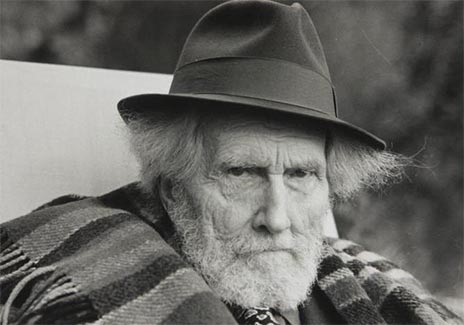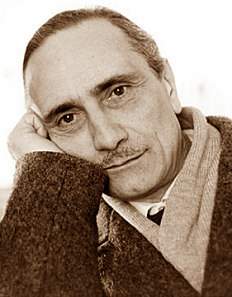1) Leggere ascoltando
E’ difficile spiegare cosa accende, nella mente di chi legge, il desiderio di ascoltare, contemporaneamente, questo o quel brano musicale, soprattutto quando si è musicalmente onnivori, quando, cioè, una tipologia musicale prevale sulle altre quasi casualmente. Ad esempio “I wish I knew how it would feel to be free” è una cover Jazz che ha un’infinità di versioni ed interpretazioni: divenuta popolare negli anni ’60 con le lotte per i Diritti Civili degli Afroamericani, è stata scritta nel 1954 da Billy Taylor: l’ho ascoltata nella versione di Nina Simone che la incluse nell’album “Silk & Soul” del 1967 (per ascoltare il brano clicca qui)
e l’ascolto è diventato quasi compulsivo proprio durante la lettura/rilettura di “Portnoy’s complaint” di Philip Roth…certo non è difficile affermare che un noto pezzo, quasi un gospel, interpretato magistralmente da un’artista come la Simone, e il famoso ( o famigerato?) romanzo di un ebreo bianco come Roth (pare, amasse, tutt’al più, lo swing), non abbiano niente in comune.
Eppure credo, in verità, che il legame ci sia, invece, per altro forte, evidente, quasi esplicito e sia rintracciabile nell’impianto libertario ed antiautoritario proprio della composizione di Billy Taylor, ma anche del romanzo di Roth.
Nel brano la voce di Nina Simone riesce a trasmettere, nei sincopati jazz, il senso di una denuncia sociale che, in genere, è espressa musicalmente soprattutto dai canti gospel; il brano affida, infatti, le attese libertarie, tipiche dei canti di protesta, ad un’atmosfera raffinata da improvvisazione Jazz; d’altra parte, il testo stesso rinvia al canto di un uccellino in gabbia che vorrebbe conoscere la libertà e costruisce un vero e proprio epicedio classicheggiante, che sfiora il genere del ϑρῆνος greco o del planh provenzale:
“E vorrei sapere cosa si proverebbe/Ad essere liberi/Vorrei poter spezzare/Tutte le catene che mi trattengono…/E vorrei che voi poteste sapere/Cosa vuol dire essere me/Allora vedreste e sareste d’accordo che/Ogni uomo dovrebbe essere libero…/Vorrei poter essere come un uccello alto nel cielo/Come sarebbe dolce/Se scoprissi di poter volare/Così agogna la mia canzone/E guardare in basso sopra il mare…”
E la libertà è proprio ciò che Alex Portnoy cercava affannosamente, rifiutando il mondo delle regole e dei pregiudizi dell’universo a cui apparteneva. E fu questo che noi avvertimmo nei primi anni ’70, quando leggemmo il romanzo di Roth per la prima volta.
2) Leggere e rileggere
Perché si rilegge un libro come questo? Si tratta, in fondo, di un romanzo quasi spiacevole, soprattutto se lo confrontiamo, ad esempio, con romanzi come quelli di Jane Austen, o con quelli delle sorelle Brontë, o con tutti quei libri che, pur nella loro veritiera tensione drammatica, sublimano con evocazioni epico-romantiche i flagelli della nostra quotidianità; no!, in effetti “Portnoy’s complaint” è un libro anticonsolatorio e scomodo, un romanzo senza storie né avventure, in cui i “flagelli della nostra quotidianità” sono proprio loro i veri protagonisti; è, cioè, un romanzo di tradizione kafkiana, dove gli incubi dell’esistenza umana escono dai meandri più nascosti delle nostre coscienze, s’incamminano tra le pieghe domestiche, prendono posizione tra gli oggetti che ci circondano, e danno ai nostri occhi la stessa dilatazione che vediamo nel disegno del volto di Roth sopra riprodotto. Certo bisogna essere lui, o simile a lui, o almeno lettori consapevoli di lui, per guardare il mondo in quel modo.
Va detto, dunque, che quando il 22 maggio 2018 Philip Roth è morto non solo si è chiusa, ahimè!, l’annosa e polemica attesa del Nobel all’autore di “Pastorale Americana” (suo indiscusso capolavoro), ma abbiamo ovviamente assodato che quello sguardo percettivo e inquietante non avrebbe più monitorato il nostro universo: si perdeva con lui la letteratura di indagine rivolta alla coscienza umana e alle sue molteplici, e mostruose, e invisibili gabbie.
La sua sprucida solerzia d’artista avrebbe, così, taciuto per sempre, favorendo l’illusoria semplificazione del vivere, la rapida stupidità dei soli valori del progresso, il dogmatico e multiforme travestimento dell’autoritarismo.
E’ per questo che dobbiamo ri-leggere, o leggere, “Lamento di Portnoy” che non è, forse, il romanzo più alto e vorticoso di Roth (oltre “Pastorale americana” anche “Il teatro di Sabbath” è tra i testi irrinunciabili della seconda metà del ‘900), ma è sicuramente il più utile, perché è una sorta di autobiografia con cui avvicinarsi agli altri suoi libri, ed è inoltre quel romanzo che ha segnato il suo destino di scrittore e la sua fortuna.
Il 22 marzo 1970 uscì su La Stampa una recensione di Natalia Ginsburg su “Lamento di Portnoy”, nella quale la scrittrice riprende, a sua volta una recensione di Cassola sullo stesso romanzo, recensione di cui non condivide il giudizio di totale “esecrazione” e, pur tuttavia, sostiene:
“Il romanzo è essenzialmente la storia di un’insofferenza: l’insofferenza dei figli verso i genitori. Tutti abbiamo provato, da ragazzi, questa insofferenza. Adulti, la superiamo, andiamo oltre, guardiamo a quell’antica sofferenza, alle nostre servitù antiche, e a noi stessi, con ironia…ma Philip Roth ha continuato a guardare alla madre con lo sguardo acuto e torvo del ragazzo e del servo. L’ha guardata con l’intelligenza velenosa, con l’antipatia penetrante del ragazzo che guarda e condanna i genitori senza sapersene staccare di un passo. Ne è nato un ritratto vitale, lampante, pieno di forza, ma impietoso”…
In verità il romanzo inizia davvero con un’immagine “impietosa” della madre: “Era incastonata così profondamente nella mia coscienza che penso di aver creduto, durante tutto il primo anno di scuola, che ognuna delle insegnanti fosse mia madre sotto altre spoglie”.
E il piccolo Alex Portnoy correva subito, perciò, al suono della campanella, correva a casa per riuscire a scorgere la madre mentre si liberava dal travestimento di maestra! D’altra parte il primo capitolo è intitolato “Il personaggio più indimenticabile che abbia mai conosciuto”. Ed è la madre a intessere il suo destino di adolescente ossessionato dal sesso: “rossa di capelli, con un lungo naso ebreo, essa occupa l’universo di Portnoy e vi infuria con la sua loquela, con la sua ossessiva, infernale e insieme innocente persecuzione materna. Innocente perché, pur provocando disastri, non saprà mai e non capirà mai di averli provocati. È troppo assorta nell’elogio di sé, nell’esaltazione verbosa della sua efficienza e abnegazione” (N. Ginsburg); come poteva, dunque, sfuggire al controllo di una madre perfetta e onnipresente, al suo cibo yiddish, ai suoi rituali domestici, alle sue virtù di massaia e tutrice delle tradizioni, se non con l’insostenibile grevità di un pansessessismo onanistico?
Alex passa, così, il tempo della sua infanzia in casa, ma chiuso nel bagno, luogo privilegiato per le sue pratiche solipsistiche, mentre la drammatica stitichezza paterna lo invocava ad uscirne nella speranza di quelle evacuazioni di cui tutta la famiglia aspettava la realizzazione; poi Alex ha provato insistentemente la pratica masturbatoria tra i sedili degli autobus, per le strade e i loro vari anfratti,tra i banchi, anche sotto il tavolo da pranzo…insomma il mondo intero era il destinatario del suo sconcertante continuo ossessivo masturbarsi; poi sono arrivati gli anni delle prime ragazzine e poi quelli delle ragazze vere e grandi: un intero capitolo, o quasi, il più lungo del romanzo, è dedicato alla “Langur” che addirittura cerca di sposarselo, minacciando cose terribili di fronte ad un diniego di Alex.
Di fatto il romanzo non ha né un intreccio né una fabula credibile: è un lungo confuso monologo, come dice la Ginsburg, in cui l’assenza di una cronologia qualsiasi è giustificata in parte per il carattere di confessione di un paziente come Alex sul lettino di uno psicanalista; la citazione sveviana de “La coscienza di Zeno” è,dunque, d’obbligo; ma Zeno Cosini, pur nella discronia delle esternazioni al medico e nella sovrapposizione temporale delle vicende, riesce, tuttavia,a darci più di mezzo secolo prima il filo della sua vicissitudine. Nel caso di Zeno, autore del disorientamento è un padre vitalissimo e opprimente per la sua rilevanza fisica e psichica e Zeno, nel riconoscersi lontano e poco affine a lui, riesce tuttavia a rintracciare un’identità, non fosse altro che per negazione ed opposizione. Alex Portnoy non è neanche Franz Kafka che si suicida ne “La metamorfosi” sotto sembianza di un orribile insettaccio; Alex ha dinanzi a sé una madre e un clan, potente e invasivo, quello ebreo e la rinuncia alle norme veicolate dalla madre lo rigettano fuori dal clan, in un universo americano che in quegli anni era connotato da un’indistinta mescolanza di culture. E’ qui, in questa difficoltà ad identificarsi e riconoscersi, che Alex scopre nel sesso compulsivo e ossessivo una possibile strada di auto-cognizione: “sono ciò che ho tra le mani, non sono mia madre né mio padre, né nessun altro degli ebrei del clan; ma non sono neanche un goym, un bianco, ma sono questa mia appendice e sono libero di pensarlo ed affermarlo…”
Il romanzo non è, dunque, una tarda riproduzione sveviana, né un’opera fedelmente kafkiana, è l’espressione di chi, nel 1969, cerca una via di fuga da stereotipi e pregiudizi razziali e culturali; la denuncia di come i gruppi etno-culturali si possano, dopo aver subito le peggiori nefandezze della Storia, auto-infliggere la più potente delle prigionie, possano chiudersi, cioè, nella più ineludibile delle gabbie, quella costruita dalla propria mente, incapace di accusarsi di tirannia, anzi esperta nell’autoassolversi, costruendo per i propri simili, per i propri figli tante simili splendide gabbiette.
Perciò il romanzo si intitola “Portnoy’s complaint”, il “compianto di Portnoy: Alex non si auto-commisera, neanche quando invoca il dottore che dovrà metterlo in terapia; il “compianto”a cui fa riferimento il titolo non è un atteggiamento patetico casuale, ma un genere letterario di antica memoria che, radicato nella lirica europea grazie ai grandi trovatori provenzali, presente in componimenti come “Ahi lasso, or è stagion di doler tanto” di Guittone d’Arezzo, maestro di Dante Alighieri, presente nella stessa Commedia, utilizzato nelle più note invettive ( “Ahi, serva Italia”…) , diviene, poi, formula stereotipata negli scritti romantici
(“Il sacrificio della Patria nostra è consumato”, dice Ortis-Foscolo); di fatto il Planh, o compianto, in inglese, appunto, “complaint”,era un motivo ricorrente delle esternazioni dei profeti biblici ed infatti Verdi lo utilizza nel Nabucco, dove il coro canta :”Arpa d’or dei fatidici vati, perché muta dal salice pendi?” , immagine che sarà ripresa dal Quasimodo di “Alle fronde dei salici”. Presente, per altro, nella lirica greca dove è chiamato “ ϑρῆνος ” e in quella latina, dove è assunto come “planctus” (pianto funebre o pianto infantile), il “compianto” arriva a Roth e si presenta nella forma di una volutamente piagnucolosa confessione al dottor Spielvogel, fantasma freudiano che compare davvero solo nell’ultimo rigo del romanzo, dopo una lunga e sonora risata di Alex, risata che esprime tutto lo scollamento con un mondo capace di minacciare pene e castighi per le colpe più assurde, ad esempio per aver staccato un’etichetta da un materasso; l’etichetta recita così: “In caso di rimozione di questa etichetta incorrerete nelle sanzioni previste dalla legge”; sembrerebbe scritta dalla madre di Alex e, al contempo, sembra di risentire il piccolo Alex, in una bella pagina del romanzo, chiederle il permesso per ogni piccola, o grande, cosa:“Mamma, noi crediamo all’inverno?”, dice il piccolo Portnoy mentre osserva una nevicata… ed era la sua prima neve!
Ed è in questo senso che va capito l’excipit del romanzo, l’ultima battuta, quando Roth fa dire al dottore:
“Dunque (disse il dottore). Adesso noi possiamo cominciare. Sì?”
E intravediamo la testa rossa della mamma di Alex Portnoy far capolino dietro il lettino dove è disteso il figlio, pronta a dire, ancora una volta, la sua.
3) Leggere da spettatori
Qualcuno, anzi molti, hanno detto che il “Compianto di Portnoy” potrebbe tranquillamente essere la sceneggiatura di un film di Woody Allen…e forse non sanno
che tra i due ci sono stati momenti di grande ostile tensione.
Fu rivelato ad Allen, durante un’intervista ad un mensile francese, “Lire”, agli inizi degli anni’70, che Philip Roth aveva detto di lui : “Quello là è il peggiore di tutti, Woody Allen non esiste che grazie all’ingenuità europea… I suoi film sono vuoti, puerili. Non c’è il minimo embrione di pensiero né di invenzione. La sua visione dell’ambiente intellettuale è di una convenzionalità risibile. Lui stesso non è un intellettuale, ma un consumatore culturale… Non sa niente della società che racconta… un caricaturista”. E Woody Allen: “… Sono d’accordo su un punto: niente di ciò che ho fatto testimonia di un travaglio intellettuale, io non ho niente dell’ intellettuale e non ho mai tentato di esserlo… (Sono) un comico di night club divenuto cineasta… Quando Roth dice che (i miei personaggi) non vivono la vera vita, forse ha ragione. Quando scrivo dei film, mi sforzo di essere bizzarro e non di riprodurre il vero stile di vita della gente…Lo rispetto troppo per smentirlo su due piedi… “
E’ evidente che Allen soffre il confronto con uno dei più grandi scrittori del ‘900, ma è altrettanto evidente che conosce bene e apprezza molto Roth; si pensi, tra l’altro, che una delle mogli di Philip Roth, l’attrice Claire Bloom (indimenticata protagonista di Luci della ribalta, di Charlie Chaplin, 1952) è stata tra le protagoniste di due film di Allen, “Crimini e misfatti” e “La Dea dell’amore”, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, ovvero negli anni del burrascoso legame tra Roth e l’attrice. E’ altresì evidente che la presenza della psicanalisi nella vita e nel cinema di Allen è di matrice rothiana e che Allen riproduce in diversi film il tema della frantumazione della coscienza (si pensi a “Harry a pezzi”, 1997) nonché il tema, davvero predominante in tutti i suoi film, delle patologie ambientali e familiari. Insomma Roth e Allen, per altro coetanei ( il primo del 1933, il secondo del 1935) ovviamente entrambi di formazione ebraica, entrambi agnostici, quanto meno, se non atei, ma che comunque esprimono evidenti problemi di sghemba comunicazione con il divino, condividono di mala grazia uno spazio-tempo complicato, nel quale incontrarsi davvero sarebbe stato difficile e avrebbe dato vita a ulteriori problemi di identificazione e differenziazione. Pur tuttavia vedere i film di Allen può giovare a chi legge Roth: è come cercare nella proliferazione di immagini, da camera degli specchi, un archetipo vero, scovare tra i “crimini e i misfatti” del cineasta, il colpevole indiscusso nel grande scrittore.
Così, se è vero, come dice Harold Bloom (il campione dei critici letterari, che aveva inserito Roth nel canone Occidentale, il top della Letteratura di ogni tempo) se è vero che Roth ha il merito di chiudere i conti con il vecchio Freud e, dunque, con i residui dell’Ottocento positivista, è altrettanto vero che vera prova della sua forza espressiva, nonché della sua futuribile permanenza nei canoni che verranno, sta proprio nel suo essere riproducibile all’infinito anche nel Cinema, come in un quadro della Pop Art.
La sua “falsificabilità”, direbbe il talvolta popperiano Umberto Eco, è la riprova della sua grandezza.
Brunella Sacchetti