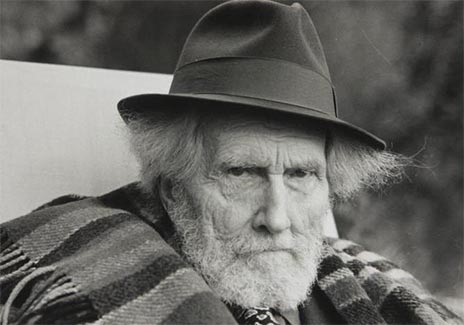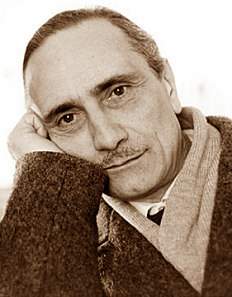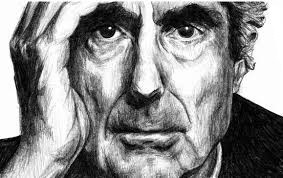“nel suo profondo vidi che s’interna legato con amore in un volume.
ciò che per l’universo si squaderna…”
(canto XXXIII del Paradiso, vv.85/87 La Divina Commedia, Dante Alighieri)
Leggere e ascoltare
Come entrare nell’universo di Borges? Non è uno scrittore privo di complessità…e la sua terra, l’Argentina, non somiglia a nessun altro luogo del nostro occidente; inoltre gli anni in cui Borges è vissuto sono stati anni di guerre, crisi, rivoluzioni; certo la Storia tutta è Storia di guerre, crisi, rivoluzioni, ma il XX secolo non è un secolo già compreso e risolto, anzi, è, al contrario, un secolo di una ancor viva contemporaneità, rispetto alla quale siamo perplessi ed inquieti, e dolenti, perché le ferite che ci ha inferto sono tuttora vive e scoperte. Borges, intanto, il’900 ha dovuto attraversarlo tutto, e lo ha attraversato con l’acutezza straordinaria di una mente geniale, e lo ha affrontato, a volte assimilato, altre volte subito e, sebbene il piano della sua narrativa appaia ai più “fantastico” (termine con cui ci si libera sbrigativamente di opere la cui collocazione risulta non semplice!), dovremmo, invece, propendere per definizioni meno scontate, che esprimano la sostanza storica dell’approccio dello scrittore argentino a quel mondo che egli vuole rappresentare.
Quando si parla di Storia in riferimento alla letteratura si pensa ai romanzi storici, quelli che nati nell’800, e che si sono affermati anche nel ‘900; essi avevano le loro radici nell’essere stesso del Romanzo, ma anche nell’antica funzione dei grandi poemi epici; come potrebbe, d’altra parte, la letteratura non mutuare sempre, indipendentemente dai suoi generi,sollecitazioni e ispirazioni dalle vicende tutte dell’uomo, dalle vicissitudini civili e politiche che ci hanno nei secoli coinvolti e stravolti…pur tuttavia non è questa la Storia di Borges; Borges accede, infatti, ad un piano diverso, profondo e sotteso della Storia, quello del Mito e dei suoi racconti ancestrali e la Storia “ufficiale” gli si presenta con delle istanze che coinvolgono soprattutto il piano emotivo-subliminale della nostra coscienza, per cui nelle sue “storie” compaiono personaggi minori o sconosciuti, alcuni immaginari, per lo più estranei al piano della fama e della gloria, nonché fatti laterali e impliciti. Sicché la Storia di Borges si delinea in dimensioni oniriche e inconcluse, lungo argini di indeterminate biforcazioni, privi di indicazioni magniloquenti e stentoree: è per questo che prima ci chiedevamo come entrare nel suo universo! Possiamo, forse, provare con un codice semplice, e popolare e, comunque, molto borgesiano: il Tango.
Ascoltiamo i tanghi, ascoltiamoli senza pregiudizi…ad esempio ascoltiamo i celebri tanghi cantati da Carlos Gardel (per chi non sapesse chi è, c’è la sua statua al cimitero di Buonos Aires: la sigaretta che ha tra le dita di marmo è vera e i suoi fans provvedono ad accenderla costantemente!) .
Ascoltiamo, inoltre, il “Cambalache”, (clicca sul titolo per ascoltare) un famosissimo tango degli anni ’30, composto da Enrique Santos Discepolo, negli anni del “decennio infame”, durante i quali si succedettero ben quattro “presidenti”; se ne possono proporre almeno due versioni, quella dello stesso Discepolo, nell’album “Tangonostalgias” che imprime la sua splendida e malinconica voce ad un testo pieno di rabbia civile, espressa in buona misura con il lunfardo (sorta di dialetto dei portuali di Buenos Aires, una “mescla” di elementi italiani, meglio!, genovesi, e creoli, che ha avuto risvolti anche estremamente intellettualistici, come sottolinea Borges nell’introduzione a “Il manoscritto di Brodie”)
El Cambalache ( Il robivecchi)
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé,
en el quinientos seis y en el dos mil también;
que siempre ha habido chorros,
maquiavelos y estafaos,
contentos y amargaos, valores y dublés…..
Che il mondo sia stato è sarà una porcheria lo so bene…
Nel cinquecentosei e anche nel Duemila.
Che sempre ci siano stati ladri,
ingannatori e truffati,
contenti e avviliti, valori e imitazioni…
Ma che il secolo venti sia un orizzonte
di male insolente, non c’è più nessuno che lo neghi.
Viviamo travolti in una baraonda
e in ugual fango tutti impastati…
Ed è lo stesso oggi esser retto o traditore !…
Ignorante, saggio, ladro, generoso o truffatore !
E’ tutto uguale ! Niente è migliore !
Lo stesso un asino che un grande professore !
Non ci sono bocciati ne’ graduatoria,
gli immorali ci hanno uguagliato.
Se uno vive nell’impostura
e un altro ruba per ambizione,
è lo stesso che sia prete,
materassaio, re di bastoni,
imprudente o clandestino !…
Che mancanza di rispetto, che assalto alla ragione!
Chiunque è un signore ! Chiunque è un ladro !
Va Don Bosco con Stavisky e “La Mignon”,
Don Chicho e Napoleone, Carnera e San Martìn…
Come la vetrina irrispettosa
dei robivecchi si mischia la vita
e ferita da una lama senza filo
vedi piangere la Bibbia accanto allo scaldabagno…
Secolo ventesimo disordinato problematico e febbrile!…
Chi non piange non poppa e chi non ruba è un fesso !
Dacci dentro dai ! Dai che tutto va bene !
Che tanto ci incontreremo laggiù all’inferno !
Non pensarci su, stattene da parte,
che a nessuno importa se sei un uomo d’onore !
Lo stesso chi fatica notte e giorno, come un bue,
e chi vive degli altri, chi uccide, chi guarisce
o sta fuori della legge…
E ascoltiamo il Cambalache (clicca sul titolo per ascoltare) nella versione di Astor Piazzolla, in “Astor Piazzolla & Jorge Luis Borges — El Tango (1965) con Luis Medina Castro” qui la contaminazione Jazz risolve eventuali compiacimenti folkloristici e riesce pienamente a traslare la complessità degli articolati piani ritmo-musicali, che in lunghi decenni avevano “costruito” il tango (ritmi indii, ispanici, creoli, habanere…), sulle tastiere della contemporaneità, così come avviene per i racconti di lame e di duelli che Borges sposta dalla piattaforma delle leggende “criolle” alla dimensione astratto-concettuale della sua prosa.
Ascoltiamo, ma soprattutto “guardiamo” il Tango, e se non sappiamo ballarlo, osserviamo i passi dei ballerini argentini; la cosiddetta “salida” è, per esempio, un insieme di vari passi: il ballerino sposta il piede destro indietro, poi il piede sinistro laterale a sinistra e ancora il piede destro avanti esterno alla donna e il piede sinistro avanti…il gioco dell’abbraccio sospinge i due, che si appoggiano l’un l’altro soprattutto con le loro teste, a costruire una geometria con i loro corpi, un triangolo per lo più, mentre i piedi scivolano e ruotano, creando forme meandriche con le quali i due danzatori segnano e controllano la superficie su cui si muovono e sembrano in grado di avvertire dei percorsi segreti, noti solo a loro, percorsi che rinviano ad un’antica ritualità . Chi guarda rimane come incantato dalla maestria espressa nel controllo dello spazio.
La foto che riportiamo è una foto di scena di “Scent of a woman” ( Martin Brest, 1992), la versione americana di “Profumo di Donna” (Dino Risi, 1974); Il tango di Al Pacino si muove sulle note di “Por una cabeza”, celeberrimo brano interpretato da tanti e da Carlos Gardel in maniera sublime.
Al Pacino è, nel film, un alto militare divenuto cieco; in questa scena il personaggio da lui interpretato dà prova soprattutto della sua capacità di saper attraversare lo spazio pur non vedendo, si fa assistere dal suo aiutante che gli comunica rapidamente le coordinate spaziali minime e guida la ballerina nella sala, con spostamenti controllati e logici, per i quali non serve la vista sensoriale comune, ma la vista interiore … e, attenzione!, non quella dell’intuito, ma quella della mente razionale, che sa essere veggente e profetica senza affidarsi a risoluzioni magico-esoteriche; la bravura di Pacino sta nel rappresentarci la possibilità di affrontare il caos che ci circonda e che, a volte, ci sommerge, delimitandolo in strutture segmentate e razionali: un tango può, dunque, affrontare una superficie vuota di indicazioni e segnali, disegnando con i piedi su di essa delle linee che la definiscano e la caratterizzino, così che anche altri potranno poi rintracciarle e muoversi, e capire, così da impedire la paralisi del corpo e della mente, così, forse, da uscirne e riappropriarsi di ciò che ci circonda, soprattutto così da non averne paura di uno spazio, di un vuoto. Non era questo lo scopo dei graffiti incisi nelle caverne?
Borges fa questo. La sua scrittura è un antidoto alla paura.
Leggere e raccontare
C’è, nella raccolta “L’Aleph”(1949), un racconto, intitolato “Storia del guerriero e della prigioniera”, che si presta bene a rappresentare la tortuosità delle varie tipologie di esistenza dell’uomo delle quali Jorge Luis Borges è indiscutibilmente un osservatore acutissimo; si tratta di un doppio racconto, una sorta di dittico narrativo, i cui ritratti sono per altro riferiti a due personaggi lontani nello spazio e nel tempo: un longobardo del VI secolo d.C., Droctulft, e un’inglese, coeva della nonna di Borges. Le due narrazioni nascono da situazioni egualmente molto lontane: di Droctulft Borges ha saputo leggendo l’opera di Benedetto Croce “La Poesia”, dove viene riportato un epitaffio che Croce aveva rintracciato in Paolo Diacono; l’epitaffio ricordava la straordinaria conversione del longobardo che, giunto in Italia dal Nord con l’esercito barbarico, si incanta alla vista di Ravenna e da invasore si trasforma in eroico difensore della città così da meritare un epitaffio che sottolineava il contrasto tra l’aspetto pauroso del guerriero e il suo cuore generoso e fraterno; al contrario il racconto dell’inglese era un apologo familiare, narrato dalla nonna di Borges che aveva conosciuto la donna dai colori e tratti anglosassoni, ma abbigliata da india e ormai incapace di utilizzare correttamente l’inglese: morti i genitori era stata rapita dagli indios ed era diventata moglie e madre; la nonna di Borges l’aveva scongiurata di ritornare nella comunità dei bianchi, le aveva promesso che con lei sarebbero stati salvati i figli; ma l’india scomparve e non si vide più nel villaggio. Anzi il racconto della nonna si chiudeva con il ricordo di un unico ultimo incontro tra le due donne: l’india si fece vedere china a terra, a suggere il sangue caldo di una pecora appena sgozzata.
Per Borges la scrittura è geometria e gli eventi narrati si muovono lungo linee precise, procedendo in andirivieni spesso inattesi, a volte fatalmente determinati, comunque mai scontatamente leggibili; così un barbaro feroce diviene paladino di una città sconosciuta e una cittadina inglese si trasforma in una fiera primitiva assetata di sangue, annullando ogni ipotesi relativa alle sedimentazioni della Storia e della Cultura. I due così lontani si ritrovano faccia a faccia, nel mezzo di un reticolato di vicende antropologiche, ben decisi a proseguire a ritroso, o a balzi, nel reticolato della storia, e comunque in contrasto rispetto a quanto determinato dalla genetica e da ogni comune aspettativa.
Molti dei racconti dell “Aleph” riproducono questo schema: ne “I teologi” un ortodosso e un eretico dell’alto Medio Evo sono di fronte a Dio la stessa persona; ne “Il morto” il giovane e ambizioso Benjamin Otalora era già morto quando ancora tramava in segreto per prendere il posto di Bandeira, il capo; Otto Dietrich zur Linde di “Deutsches requiem” sarà giustiziato come assassino e torturatore nazista, ma rappresenta la sua colpevolezza attraverso un percorso culturale straordinario, che, tuttavia, si inabissa nella necessità di “ammazzare” la pietà, ogni forma di pietà, giudaica o cristiana, a cui è necessario sostituire la violenza e la fede nella spada. Per il tedesco di “Deutsches requiem”, infatti, si può, o si deve morire, nella labirintica struttura della Storia affinché si realizzi la Storia stessa, e si delinei la vittoria dell’ingiustizia, anche incarnata in una potenza che non sia la Germania, purché in grado di “redimerci” dal servilismo cristiano. Per i molti personaggi dell’”Aleph” la storia nella sua crudeltà è già scritta, ma quello che comunemente chiamiamo destino non esonera da errori e colpe, anzi!, ontologizza errori e colpe.
E’ dunque anche la Storia una perversa geometria, nella quale i segmenti della rete riportano trascritte le possibilità del destino dei singoli, possibilità che si sfiorano e si coagulano, come ne “L’altra morte”, dove Pedro Damiàn muore paradossalmente due volte, una volta, nel 1904, coraggiosamente in battaglia, l’altra volta, nel 1946, da vigliacco e anonimamente … è la “Storia” nella quale Asterione il Minotauro va incontro gioioso al suo redentore-assassino Teseo nella casa-labirinto, dove aveva consumato pasti feroci insieme ad una solitudine abissale…
La geometria di Borges è, ovviamente, soprattutto un metodo di rappresentazione con cui lo scrittore cerca riparo al caos del reale ( Il primo significato di “caos” è “vuoto”); essa è una sorta di piano cartesiano illimitato i cui punti configurati sulla superficie non solo sono mobili, ma si scontrano e si urtano e non permangono quasi mai in superficie, si inabissano, o riescono a cercare dimensioni inverse e diverse. Cosa essenziale per l’opera di Borges, lo scrittore riesce a intravedere di tale complesso poliedrico le improvvise lacerazioni: dove i gangli di raccordo non tengono, dove si spezzano i segmenti della rete, la rete stessa diviene un percorso meandrico, fatto di angoli aperti, ma segreti, che sembrano promettere fughe e possibili fuoriuscite dal sistema; chi si muove in tali complessità spezzate finisce a volte, altresì, con il percepire in un luogo dello spazio o della memoria, o in un attimo particolare o, anche, in un oggetto banale, un aggregato di senso, ma sfuggente ed ossessivo, come ne “Lo zahir”, che dà vita ad uno dei racconti più inquietanti de “L’Aleph”: lo “zahir” è una monetina di nichel da 20 centesimi, insignificante e comune, che Borges riceve come resto di un pagamento. Diviene un’ossessione vorticosa, deve pensarla e guardarla di continuo, così da sospingerlo a consultare uno psichiatra, ovviamente senza alcun risultato; quella monetina non era legata ad alcuna patologia, ma era una sconnessione del sistema di riferimento dell’universo dove è, per altro, incredibilmente possibile che anche le macchie di un giaguaro “scrivano” il mistero della nostra esistenza ( “La scrittura del dio”).
Anche l’Aleph stesso è un luogo di questo spazio combinatorio ed interconnesso: è una sfera, una goccia dell’universo dove tutto è contenuto, un “effetto Droste” che si estende illimitatamente; si tenga presente che l’effetto “droste” è un banale riferimento ad una famosa immagine pubblicitaria dove un’angelica suora porta, forse ad un convalescente, una calda cioccolata su di un vassoio dove è posta la scatola del cacao “droste” che ha come immagine quella della stessa suora con lo stesso vassoio e la stessa cioccolata calda…immagini che si rinviano e si incorniciano l’un l’altra, determinando un abisso cognitivo; ciò che Borges vede nell’Aleph del racconto omonimo è il frutto di una “mise en abyme”, ovvero di una dissociata procedura cognitiva con cui la mente percorre spirali labirintiche fino a raggiungere un indefinibile buco nero delle nostre coscienze .
Sicché il tentativo di contenimento del caos entropico, all’interno di una rete complessa e illimitata, si traduce nella marcata utilizzazione di percorsi labirintici e di specchi illusori, in altri casi in occasioni percettive di strane aggregazioni materiali dai significati inaccessibili ed ossessivi, dentro punti minuscoli, ma densamente insondabili, autentici “nevi” dell’epidermide dell’Universo.
Sta di fatto che man mano che ci si addentra nella lettura di Borges ci accorgiamo che lo scrittore argentino ci fa procedere in una danza dai passi inattesi verso la sua stessa mente, che diviene il nostro Aleph e, guardandovi dentro, vi rintracciamo i percorsi che lui stesso ci indica; si delinea l’immagine de “La Biblioteca di Babele” , scritto che precede di gran lunga L’Aleph, ma che ne costituisce lo scheletro esplicativo.
Quando Borges pubblicò “La Biblioteca di Babele” aveva già quarantadue anni e questo strano anomalo racconto, uno dei suoi più famosi, uscì nel 1941 nella raccolta “Il giardino dei sentieri che si biforcano” e poi, tre anni dopo, in “Finzioni”; Borges aveva già chiaro il suo sistema narrativo, anche se qui non l’utilizza del tutto: in una cornice “fantastica”, quella di questa strana incredibile biblioteca, Borges descrive in un linguaggio piano e geometrico uno spazio surreale che, come apprendiamo dall’incipit, è l’universo stesso, l’unico di cui possiamo parlare. Indefinito e, forse, illimitato, tale spazio si delinea come un susseguirsi di corridoi esagonali, che si presentano tutti eguali, interrotti da ballatoi che si diramano in alto e in basso, forniti di pozzi e di camerini di servizio; intorno, sui cinque lati utili, ci sono solo scaffali di libri secondo una fissa maniacale ripetitività numerica relativa ai volumi, alle pagine dei volumi, al numero di righe, di parole e di caratteri. Nella biblioteca vivono e viaggiano gli uomini, bibliotecari che hanno una vita, ahimè!, limitata e, per tanto, cercano di capire il loro destino, carpire il senso nascosto della loro condizione, agitandosi, lottando, finendo in avventure dolorose e mortali; l’io narrante, Borges ovviamente, rivela alcuni aspetti di questo mondo: in esso si dice che esista uno spazio circolare con un volume infinito (Dio!), si sa che un uomo avrebbe letto un libro che conteneva tutti gli altri, e che tale libro sarebbe addirittura comprensibile e riguarderebbe l’analisi combinatoria; il bibliotecario che l’avrebbe letto sarebbe divenuto simile ad un dio . Molti lo hanno cercato, ma invano; nella biblioteca si sarebbero perciò susseguiti momenti di speranza e tensione , di lotte e ricerche, di proibizioni e repressioni feroci; intanto gli innumerevoli libri fondati sulle possibili combinazioni di 25 segni rappresentano quella rete più o meno lacerata di cui si parlava e su cui sono scritti i racconti de “L’Aleph”, ma anche tutti i libri di Borges, anche di quelli volutamente “realistici” de “Il manoscritto di Brodie”: è tutto scritto nella dimensione geometrico-combinatoria, per cui i libri della Biblioteca di Babele non sono solo libri, ma l’insieme infinito di tutti i possibili libri del mondo; con la combinazione di 25 simboli si delinea un infinito logico all’interno del quale la Storia umana trova necessariamente le sue possibili alterazioni, distorsioni disordinate e distopie cognitive che ci consentono di riconoscerci nell’attimo dell’impasse, dove si agglutina un sovrappiù impensato di senso.
Borges è stato, dunque, un cacciatore di senso, come il luogotenente romano dell’esercito di Diocleziano, protagonista de “L’immortale”; si chiamava Marco Flaminio Rufo e da alcuni prigionieri aveva sentito parlare di un fiume egizio che dava l’immortalità e di una città degli immortali, e prese a “bruciare” dal desiderio di conoscere quei luoghi; ne nasce una storia straordinaria nella quale questo romano, feroce seviziatore di prigionieri e disertori, riesce nel suo intento, rintraccia il fiume e la città e il popolo degli immortali, diviene immortale egli stesso, ma vivrà nei secoli solo per poter riacquistare la mortalità: tra i trogloditi che vivevano a ridosso della città degli immortali, trogloditi che erano essi stessi gli immortali, Flaminio Rufo aveva riconosciuto Omero , ormai quasi privo della parola e, soprattutto, quasi del tutto privo della memoria della sua grandezza di Poeta.
La Poesia che in Dante , Petrarca, Orazio, Foscolo, Shakespeare è stata sempre funzione di immortalità, nella realizzazione della stessa immortalità, appare come una vaga sembianza di un mondo scolorito, calata nelle tombe di un’esistenza accidiosa e inutile, percorsa dai fremiti di una sensorialità primitiva che si accende solo se una pioggia sonora scroscia e bagna quei poveri corpi di analfabeti afasici e primitivi. L’immortale è, perciò, il testamento di Borges: la morte è paradossalmente il vero antidoto all’oblio: con essa gli individui riescono a fissarsi nei gangli significativi della rete labirintica che tiene il controllo del caos; la lezione di Seneca, e del Cristianesimo e del Confucianesimo, e, anche, se non soprattutto, la lezione lucreziana di un infinito increato che contiene, “magnum in parvo”, sequenze finite di possibile senso, con cui vincere la paura.
Leggere la Storia
Ma che paura è quella a cui la scrittura di Borges contrappone il raziocinio geometrico di un metodo rappresentativo del reale? È innanzitutto la paura della non possibile rappresentabilità del mondo; ad un cieco, figlio e nipote di ciechi, interessa che al suo non vedere corrisponda almeno il vedere degli altri, che possano rappresentare ( il termine è esattamente quello di Shopenhauer) il reale, e che quest’ultimo possa essere conchiuso e definito, quindi trasmesso e spiegato.
La paura dell’irrazionalismo del XIX E XX secolo inietta in Borges il terrore della barbarie cognitiva, i suoi modelli letterari, da Dante a Cervantes, da Dickens a Tolstoj, da Hugo a Flaubert, gli indicano una strada nella quale il fantastico diviene funzione di realismo e la verità è l’indispensabile “terminus ad quem” , così che la scrittura possa contenere la Storia per mezzo dell’Immaginazione, così che il deserto sia attraversato da sentieri e linee-guida, tortuose e meandriche, ma egualmente chiare e semplici. D’altra parte come può un inglese ( in famiglia Jorge era per tutti Georgie ) affrontare il suolo argentino che si estende dal torrido tropicale al freddo polare, e che ospita un numero notevole di popoli e culture diverse, varie, atipiche? Come può un inglese riconoscere i percorsi politici giusti di un paese senza passato di misura europea, lui che veniva dalla patria di Locke e Stuart Mill?
Mario Vargas Llosa racconta che nei primi anni ’60 , a chi gli chiedeva cosa fosse la politica, Borges rispose : «es una de las formas del tedio» ; ed è questa la sua unica, e vera, dichiarazione politica, quella di un anarchico, di un teorico dell’individualismo, anzi di un esplicito solipsismo ; in un paese senza passato politico, non si può fare politica, se non “sbagliando”. E Borges sbagliò, e molto, e non glielo perdonarono: gli fu negato il Nobel, ma soprattutto gli costruirono un profilo non solo di conservatore, quale di fatto era, ma di reazionario asservito al regime di Pinochet, e amico di Videla.

Borges a sinistra con Videla e a destra con Pinochet
Borges era stato soprattutto antiperonista, fortemente antiperonista; Peron aveva incarcerato la madre e la sorella e nella sua formazione di atavico “caballero” ciò era inconcepibile; Pinochet gli sembrò capace di invertire il regime populista di Peron che Borges ha sempre chiamato “la carogna”, ma la sua mente, pur così lucida, lo tradì: semplicemente una carogna prendeva il posto di un’altra carogna; Borges nel 1980 scrisse su “La Prensa” una lettera aperta al regime, sui desaparecidos, e disse: “Confesso che ho sbagliato”; si unirà, quindi, alle Madri degli stessi e, piangendo, dirà che vuole farsi ammazzare anche lui.
Borges manifestò, in forma certo letteraria, un sincero doloroso sgomento per quella che non era una vita civile: i fatti argentini, le varie tirannidi argentine, non erano ai suoi occhi né comprensibili né definibili, erano un orrore che non poteva essere ascritto a quel mondo di combattimenti feroci, ma leali, dove i Caballeros che lo scrittore continuava a sognare andavano incontro alla morte in battaglia con sprucida provocazione: c’era solo disonore, in quel momento, nel suo paese. Potrà mai tornare un novello Teseo a liberare dalla prigionia, e dal tedio di una vita senza eroismo, il mostro dalla testa di Toro, rinchiuso nel labirinto?
Intanto tutta l’America latina era percorsa da lotte civili e da feroci contrapposizioni politiche e un eroe argentino, munito di lama, e di armi da fuoco, di determinazione e anche di ferocia libertaria, Ernesto “Che” Guevara, si presenta al mondo nella complessità tortuosa del suo mito; sembra uscito dalle pagine di uno dei libri della Biblioteca di Babele: troverà la morte come uno dei tanti personaggi borgesiani, come Benjamin Otalora, come Tadeo Isidoro Cruz, come Martin Fierro, come Pedro Damiàn, come tanti altri; quando in Bolivia presero e uccisero il Che ( 9/10/1967), e lo composero per fotografarlo, nessuno tra i militari e gli agenti segreti che lo avevano alfine proditoriamente intrappolato, nessuno di loro pensò che aveva catturato e ucciso non solo un corpo, ma soprattutto un personaggio letterario, e che quella salma sarebbe diventata la “rappresentazione” trasversale di ogni speranza di libertà; era un argentino che come Borges aveva capito quanto tedio, e quanta ignominia, ci fosse nella politica: mentre il mito si definiva e componeva, con i suoi corollari di inverosimiglianza e paradosso, con i suoi meandrici percorsi, le ferite, che erano vere e numerose e mortali, lasciavano sgorgare tutto il suo sangue, così, all’infinito, e quel sangue riusciva a permeare e segnare nel profondo il deserto pauroso della nostra terra.
Intanto, in un angolo del quartiere Palermo di Buonos Aires, qualcuno, accompagnandosi con un bandaneon, intonava El Cambalache :Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé…
Brunella Sacchetti
 Jorge Luis Borges: labirinti letterari per vincere la paura
Jorge Luis Borges: labirinti letterari per vincere la paura