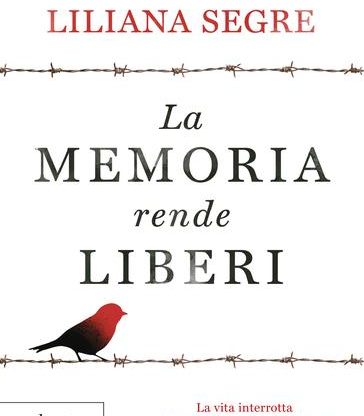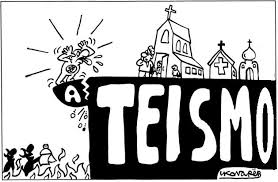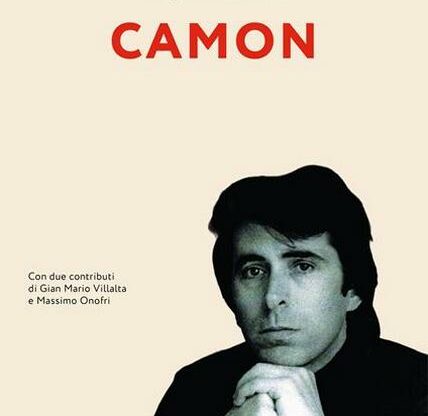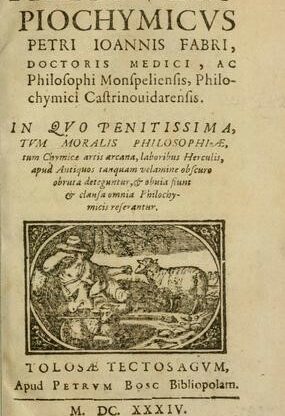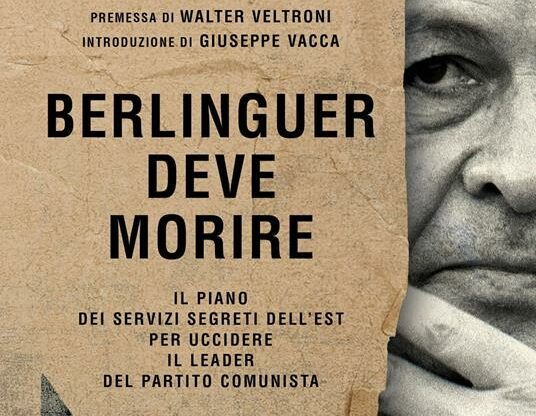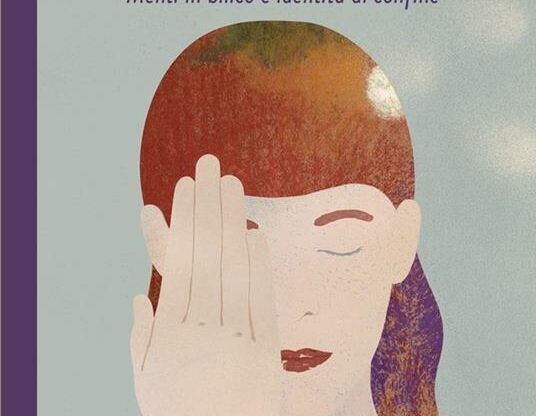La memoria rende liberi, il libro che Liliana Segre ha scritto insieme ad Enrico Mentana, è di quelli che richiedono una doppia lettura. Cosa necessaria per riflettere, proprio a partire dal titolo. Forse perché esso rappresenta, non solo la summa di una vita ma perché, in certa misura, si può arrivare a dire che la prigionia di Liliana Segre non è finita realmente. E se lo è ha cominciato ad esserlo nel momento in cui Liliana Segre ha aperto il suo cuore, dolorosamente rivivendo e condividendo, senza omissioni, la sua storia.
“Il 5 settembre 1938 ho smesso di essere una bambina come le altre”. Questo è l’incipit agghiacciante della narrazione, vedere la propria condizione di spensieratezza infantile mutata in quella di un essere fragile ed inconsapevole proiettato in un mondo disumano, incomprensibile, inspiegabile. Compagne della sua esistenza, fino a quel momento serena, divennero emarginazione, declassamento, divieti, restrizioni, perquisizioni, trasferimenti. Infine, l’estremo tentativo di salvezza fu riposto, dal padre di Liliana, nella fuga per varcare i confini italiani e raggiungere la Svizzera. Padre e figlia furono respinti, dopo aver varcato la frontiera, con pretesti infondati, subirono l’arresto al confine con tanto di verbale, schedatura, requisizione di valori e contanti, finché per loro si aprirono le porte del carcere. “Una donna mi strattonò violentemente […] sapeva che non ero una ladra nè un’assassina ma solo una bambina col fiocchetto nei capelli”. Tre detenzioni: Varese e Como prima, infine Milano per quaranta giorni, in un gelido dicembre e fino al 30 gennaio del 1944, giorno in cui una lunga colonna ammutolita e silente fu condotta al tristemente noto binario ventuno dove avvenne la trasformazione da esseri umani in “stucke”. “Il colpo più duro fu quando capimmo che i più zelanti fra i nostri aguzzini non erano i nazisti. Erano gli italiani”. Dopo sette giorni nei famigerati vagoni piombati, la discesa all’inferno. Stupore, disperazione, solitudine, violenza, annullamento, sono parole che scaturiscono da ogni riga e scatenano nella nostra coscienza turbini di emozioni impossibili da celare e reprimere. Paradossalmente, in questo processo di disumanizzazione, in cui l’unico istinto immediato che teneva attaccati alla vita era quello della ricerca di nutrimento, talvolta negli sguardi e in poche parole pronunciate di nascosto tra prigionieri, nascevano attimi di condivisione, fratellanza, quasi amore: ciò nell’anima pura della giovanissima Liliana, offrì un barlume, seppur tenue, di consolazione. E dopo il lager arrivò un’altra terribile prova per un corpo emaciato, sfinito e allo stremo delle forze: la marcia della morte dopo l’abbandono del lager. Sarebbe troppo lungo descrivere con minuzia le sofferenze ineffabili provate per il distacco dal padre, le atrocità della prigionia, il freddo, gli stenti, il lavoro estenuante in fabbrica, la marcia della morte, ognuno di noi sa cosa sia stato, chiunque si sia doviziosamente documentato sa già tutto, però c’è qualcosa che fa inorridire più di tutta questa parte, cioè il rientro a casa di Liliana.
Nel lager, le violenze perpetrate con le modalità più aberranti, le malvagità, l’orrore, tutte quante apparivano normali, connaturate all’essenza mostruosa e disumana del luogo, per dirla con la famosa espressione di Hannah Arendt vigeva la banalità del male. Cosa trovò Liliana al suo rientro in Italia? Soltanto indifferenza, convenzioni borghesi cui uniformarsi, che sembravano vanificare quel suo eroico istinto di sopravvivenza che l’aveva spinta a superare tante terrificanti prove fisiche e inaudite violenze psicologiche. Fu pervasa da un senso di inutilità, la quotidianità da libera cittadina si stava dimostrando vuota e priva di valori a cui ancorarsi: l’animo devastato, l’assenza di una spiritualità religiosa, la mancanza delle conoscenze che si acquisiscono con lo studio, la carenza di amore e di una casa che sostituisse la mera ospitalità cortese e formale degli zii. La premura più urgente dei suoi parenti non fu di conoscere le atroci sofferenze vissute, ma di sapere se fosse stata stuprata, preoccupazione volta a presentare la ragazza in società come rispettabile signorina, oppure di coprire quello strano tatuaggio, marchio disdicevole, con un braccialetto o rimproverarla di essere ingrassata, di amare la solitudine, di non imparare a diventare una donna di casa. Paradossalmente si sentiva sola ed emarginata proprio quando avrebbe dovuto/potuto sentirsi finalmente libera, addirittura costretta a compatire, pur di mostrarsi socievole, le afflizioni patite da altre persone, che, a causa della guerra, avevano subito ristrettezze, carenze alimentari o perdite materiali. Divenne sempre più difficile parlare della prigionia, nessuno voleva più ascoltare storie di guerra, tanto che alla fine Liliana s’impose il silenzio. La maggior parte delle persone desiderava solo dimenticare, divertirsi, ballare, organizzare feste, Liliana no, lei voleva riscattarsi dalle sue sofferenze, riempire quell’incolmabile abisso che si era creato in lei con lo studio, per riappropriarsi della propria esistenza per diventare giornalista. Studiò in maniera indefessa, grazie ai consigli delle suore Marcelline, presso cui già aveva studiato dopo l’emanazione delle leggi razziali, animata da un insopprimibile ardore che le consentì di recuperare le scuole medie, affrontare gli esami di quinta ginnasio da privatista per poter frequentare il liceo classico nel medesimo istituto della sua infanzia. L’inizio della sua liberazione vera avvenne solo quando lasciò la casa degli zii, andò a vivere con i nonni materni e, durante una vacanza al mare, conobbe il futuro marito, anch’egli reduce da una prigionia ma non in un lager. Riconobbe subito il tatuaggio col numero e capì che lei non era una ragazza come le altre perché sapeva cosa significasse quel segno indelebile. Finalmente Liliana riuscì ad aprirsi: “Cominciammo a parlare e non ci fermammo più, smettemmo solo qualche giorno prima che morisse”, sunto di un’unione improntata ad un dialogo profondo. Nonostante una vita serena, sentimentalmente felice, agiata, il lager era ancora lì a perseguitarla, sia nei segni lasciati nella salute fisica minata, nelle fobie nate da molti traumi vissuti, ma soprattutto in una grave depressione che si manifestò più tardi da cui gradualmente guarì. Forse, da quanto emerge da alcuni carteggi di cui parla, avvenuti tra lei e Primo Levi, fu la stessa avvilente tensione psichica che lo portò al suicidio, generata dall’incomprensione del mondo di fronte all’evidenza e dal senso di colpa per essere stato un salvato e non un sommerso. E fu proprio in questo frangente che in lei emerse una diversa consapevolezza: non aver fatto il proprio dovere di ricordare e di far conoscere a tutti la sua vita, che fece maturare in lei la volontà di iniziare una nuova missione. Dapprima collaborò con il Centro di documentazione ebraica di Milano, poi iniziò gli incontri nelle scuole per esporre la propria testimonianza: “Non ho mai esposto la mia storia per creare divisioni. Ho sempre parlato in modo semplice, con un linguaggio piano e pacato, senza mai predicare l’odio, mai. Non intendo trasmettere un messaggio negativo ai ragazzi: di odio, di vendetta, di disperazione assoluta, perché sono il contrario della vita. Quel che conta per me è far passare un messaggio d’amore e di speranza. E’ questa la mia missione e mi dispiace di non averla intrapresa prima”
Termino con un’altra sua frase scritta nel memoriale della Shoah di Milano presso il binario ventuno:
“Indifferenza: gli orrori di ieri, di oggi e di domani fioriscono all’ombra di quella parola”.
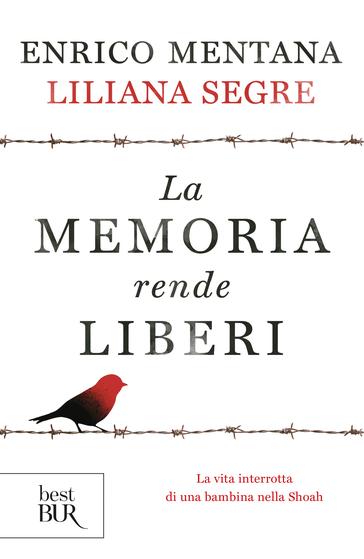 La memoria rende liberi
La memoria rende liberi
Saggistica, memorie
Rizzoli
2015
225