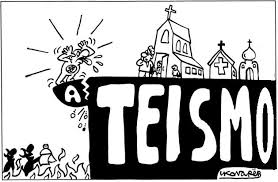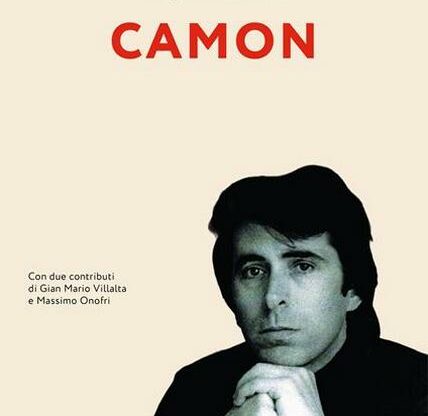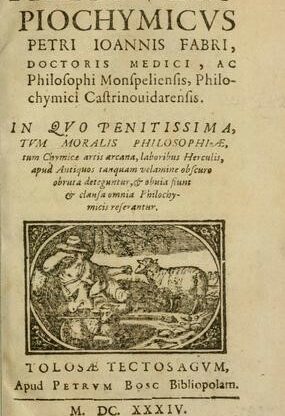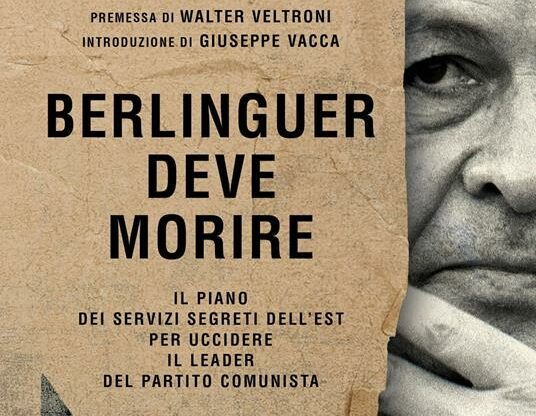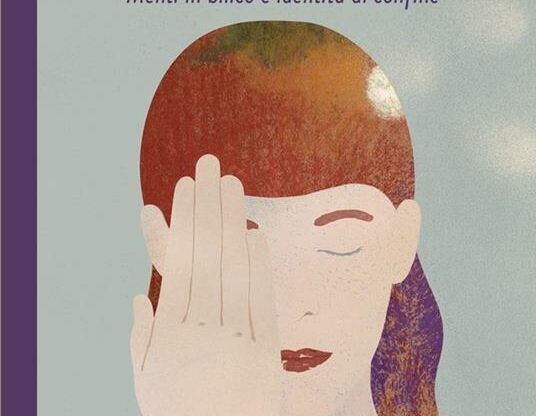Bella mia narra una vicenda per cui si prova subito empatia, nella lettura si diviene un tutt’uno con le emozioni dei personaggi di cui si percepiscono dolori, speranze, impotenza, voglia di rincominciare, nonostante tutto. Ma prevale il dolore, sopra ogni cosa, ce n’è tanto, scarno, intenso, privo di patetismo.
Sono passati più due anni, all’inizio della narrazione, dal sei aprile 2009, giorno del terremoto che ha sconvolto le vite dei protagonisti della vicenda; ora vivono nelle C.A.S.E., acronimo di altisonanti parole: Complessi Antisimici Sostenibili ed Ecocompatibili. La vicenda si dipana su due piani narrativi paralleli in cui si intrecciano e si compenetrano il presente e la vita precedente al terremoto, filtrati dal punto di vista di Caterina, la protagonista, che rievoca via via episodi dell’infanzia, dell’adolescenza e della prima giovinezza ma che ora si ritrova con la responsabilità, condivisa con l’anziana madre, di crescere un nipote adolescente, figlio dell’amata sorella gemella morta nel crollo della loro casa. Le loro vite sembrano sospese in un’atmosfera irreale, la signora anziana non riesce ad accettare l’alloggio “con la puzza di nuovo” che comunque cura e rassetta con dedizione e a poco a poco impregna dei profumi della sua cucina per farlo suo; il ragazzo, Marco, dalla vita domestica solitaria ed umbratile è ribelle ed insofferente a scuola e nei rapporti col padre da cui la madre si era separata prima della morte. Nonostante l’amore di nonna e zia non può dimenticare quella notte in cui la madre non era uscita di casa alle spalle sue e della zia in tempo per evitare il crollo.
“E’ morta del suo ritardo. Il frastuono si era attenuato, reso elastico dal moto ora ondulatorio della casa che non sussultava più….. Il terremoto doveva essersi fermato, continuavamo ad oscillare per inerzia….Prendo solo due cose ed arrivo”, vai con Marco. Il nome del figlio è stata la sua ultima parola”.
E dopo la tragedia, il vuoto improvviso, il nulla, un campo allestito per i senzatetto che si ritrovano a dover condividere le loro vite nella forzata inerzia della disperazione e dell’incredulità che acuisce la solitudine interiore di chi acquista l’amara ed inaccettabile consapevolezza di aver perso tutto. Nessuno vuole andar via dalla città, perdere la speranza di rientrare nella propria dimora, lasciare le tombe dei cari appena persi. Lacerazioni impossibili da allontanare turbano e devastano gli animi degli sfollati, come se il terremoto continuasse ad albergare dentro di loro e li scuotesse violentemente nelle notti spesso insonni in cui le mani, in uno spasmo doloroso, stringono al corpo le coperte in cerca di protezione.
“Nel campo eravamo deportati di lusso, venivano cuochi famosi a cucinare per il nostro scarso appetito e i politici a visitarci, con i vestiti sportivi adatti alla circostanza e le facce atteggiate alla solidarietà. Le telecamere li filmavano mentre prendevano impegni per una pronta rinascita dell’area colpita dal sisma e lodavano il coraggio e la dignità della popolazione cosi duramente provata”.
E poi finalmente l’assegnazione degli alloggi, un nuovo inizio per tutti. Caterina, nonostante i divieti, si reca nella “Zona rossa” della città: la prima volta vuole rivedere il suo laboratorio di ceramista, immerso nella polverosa penombra e in cui rimangono le vestigia delle bottiglie messe ad asciugare, dei piatti pronti per la cottura, gli oggetti caduti dalle mensole e frantumati, il lavoro di mesi, insomma; la seconda volta nevica fitto e Caterina visita la casa della sorella e del nipote: nel silenzioso e ovattato candore nivale si accorge che qualcuno è entrato, le impronte sembrano quelle dei piedoni del nipote adolescente. Ancora, in un filo per il bucato pende una felpa, ormai logora, del ragazzo che sventola tristemente al vento gelido. Questa desolazione invernale si presenta agli occhi di Caterina: “Ci saranno altri crolli allo scioglimento della neve, credo. Di notte l’acqua penetrata nelle lesioni gela aumentando di volume e i muri imbevuti di ghiaccio crepano lungo le fenditure allargate. L’Aquila è fradicia e gonfia, dopo tutto questo tempo. Le piogge l’hanno impregnata fino alle fondamenta, passando tra mattone e mattone. Marco non dovrebbe venire qui, è pericoloso, domani cambierò il lucchetto”
Ma nel seguito della narrazione, nonostante il lucchetto sostituito, Marco prova l’impulso irrefrenabile di tornare più volte nella sua casa abbandonata, noncurante del rischio, per cercare di preservare e riordinare oggetti ed arredi rimasti nel tentativo di dare forma ad un dolore troppo grande da metabolizzare per la sua giovane età. Ed anche la protagonista alla fine acquista una sua nuova dimensione ritrovando se stessa e seguendo i moti del proprio cuore.
Bella mia e’ dunque L’Aquila colpita dal terremoto, il dramma di chi improvvisamente si sente svuotato, lacerato, sballottato dalla sorte in una vita che non e’ più la sua: come tristi arabe fenici, i protagonisti cercano di rinascere, mettono insieme i brandelli che restano, nonostante il loro cuore in parte sia sepolto insieme a chi non c’è più e, in parte, dimori nei muri pieni di crepe della propria casa abbandonata che vanno a visitare, appunto, di nascosto per elaborare il lutto attraverso la vista di oggetti e mobili polverosi, frammenti di ricordi della vita precedente, quella vera. Ma nonostante il dramma vissuto riescono a poco a poco a ritrovare, seppur faticosamente, un barlume di fiducia nella propria esistenza attraverso i legami parentali o di amicizia e la riscoperta di piccole gioie quotidiane per lungo tempo sopite dall’urgenza di ritrovare prima almeno l’istinto primordiale della sopravvivenza.
 Bella mia
Bella mia
Super ET
Memorie, autobiografia
Einaudi
2018
192