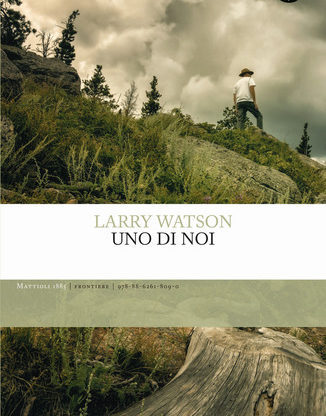Considera la balena
Ragazzi, non avete idea di quante cose si possano dire sulle balene e sulle baleniere!
Alcune opere sono più grandi di altre, e certe sono proprio gigantesche, al punto che provare a commentarle potrebbe risultare, a seconda dei casi, superfluo o addirittura presuntuoso. Comincerò dicendo, allora, che la traduzione di Pavese è meravigliosa e che l’attacco ampio del romanzo – le prime cento pagine, grossomodo – è uno dei migliori che mi sia mai capitato di leggere. Melville getta immediatamente il lettore tra le acque del proprio romanzo, cullandolo con una necessaria e curatissima vaghezza. Non è importante, quindi, il nome del narratore, ma quello che rappresenta, così come non è importante quando i fatti siano accaduti, ma che si siano consumati e che siano raccontati. Di Ismaele sapremo solo l’indispensabile, e cioè che è di New York e che ha l’abitudine di andare in mare per “scacciare la malinconia”, e soprattutto che è sopravvissuto per raccontarcelo.
Giochiamo per un attimo a unire sacro e profano. In un episodio della quindicesima stagione de I Simpson, Lisa ammonisce Homer ricordandogli che “non ci si può vendicare di un animale: è questa la chiave di Moby Dick“. Ora, sicuramente questa semplificazione fa parte dell’umorismo di Groening ed è funzionale alle vicende narrative della puntata, ma ha comunque un fondo di verità. Per poterci arrivare, però, occorre fare un passo indietro. Dopo aver presentato – magistralmente – tutti i personaggi e averli fatti imbarcare sul Pequod, il romanzo attraversa una lunghissima fase di stasi narrativa, entro la quale Melville ci racconta praticamente tutto quel che è possibile raccontare circa le balene e le baleniere. Le pagine ripercorrono aneddoti e leggende, ma hanno il più delle volte un carattere puramente enciclopedico a cui si lega sovente un simbolismo esplicito o solo celato (ma comunque piuttosto chiaro).
L’espediente ha una doppia efficacia: sospeso in questo limbo didascalico, il lettore aspetta l’azione fino a bramarla con spasmo; ma, d’altra parte, tutto questo parlare delle balene (e di “quella” Balena) contribuisce al processo di mistificazione dell’animale, che, a discrezione del lettore, viene dunque immaginato con naturale rispetto, devozione, o, appunto, un’ossessione almeno simile a quella del capitano Achab. Ma la verità è che possiamo attribuire a un animale – e potremmo dire la stessa cosa dell’intera natura – tutti i significati che vogliamo, e questo rimarrà, nonostante tutto, soltanto un animale, estraneo a noi e al nostro mondo. Perché spesso rassegnarci a noi stessi – ai nostri errori, alle nostre paure, ai nostri limiti, all’insignificanza di questo Assoluto – risulta insostenibile, ed ecco allora che ci troviamo a caricare di un certo valore un qualcosa che invece ne è privo. La ricerca del senso delle cose ci spinge disgraziatamente a proiettarlo laddove proprio non c’è ragione che possa esserci. L’apparente sfrontatezza di Moby Dick, che è incurante di Achab proprio perché ne ignora l’esistenza, diventa il simbolo dell’indifferenza del mondo alla vita e alla morte degli uomini. A prescindere dal fatto che questi siano stati piccoli o grandi, il mondo sopravvivrà alla loro perdita e il mare tornerà a “stendersi come si stendeva cinquemila anni fa“.
Ma l’avventura del Pequod diventa metafora anche della sempiterna lotta tra uomo e uomo – e tra sé e sé. L’ambizione assurda di Achab seduce un intero equipaggio che, anche a fronte della sicura sconfitta, lo accompagna fino agli ultimi istanti scanditi da una serie di ammonimenti che sono consapevolmente vani. Il conflitto interiore del capitano si consuma senza tregua, il “sentire” annebbia il pensiero, così come l’ideale ha sconfitto la vita, abbandonata sulla terra oltre quaranta anni prima. Eppure, a tratti incostanti, si riaccende un barlume di lucidità, simbolo forse non di un equilibrio ritrovabile ma di una umana e istintiva bramosia della felicità (“amara beffa dei capelli grigi; ho forse provato abbastanza gioia da dovervi portare, e sembrare e sentirmi tanto insopportabilmente vecchio?“). Anche, in questa ricerca dell’ignoto che si vuole acchiappare (e vincere), in questo cammino verso Dio o l’Assoluto o il Trascendente, la scoperta (o semplice riscoperta) della bellezza di ciò che è evidente, terreno, che condivide con noi lo stesso spazio e lo stesso tempo (in un’estensione diversa, qualche volta) ed è quindi prigioniero dello stesso destino del dover vivere e del dover perire. “Fammi guardare un occhio umano; è meglio che guardare nel mare o in cielo; è meglio che guardare in Dio.”
C’è così tanto per cui vale la pena vivere, su questa terra, ben al di là di questa assurda e forse inutile ricerca. Come anche scriveva Dostoevskij ne I Fratelli Karamazov, occorre amare la vita prima del senso della vita, e solo allora se ne coglierà il significato. Il dialogo finale tra Achab e Starbuck, che suona come le memorie che i due non potranno mai vergare al fronte di una fine ormai inevitabile, raccoglie la summa di questo pensiero. “Con quanta allegria, con quanta gioia, capitano, faremo la corsa per rivedere la vecchia Nantecket! Credo, signore, che ci siano altre dolci giornate azzurre come queste, a Nantucket.”
Ci saranno per chi resta: loro due sono ormai perduti. Ci saranno per Ismaele, che si fa “avanti perché è sopravvissuto alla distruzione“. Ci saranno per chi rimane, benedetto dalla sorte o dalla fortuna, a godere delle meraviglie e delle disgrazie della Vita e a chiedersi chi (o che cosa) le ha volute.
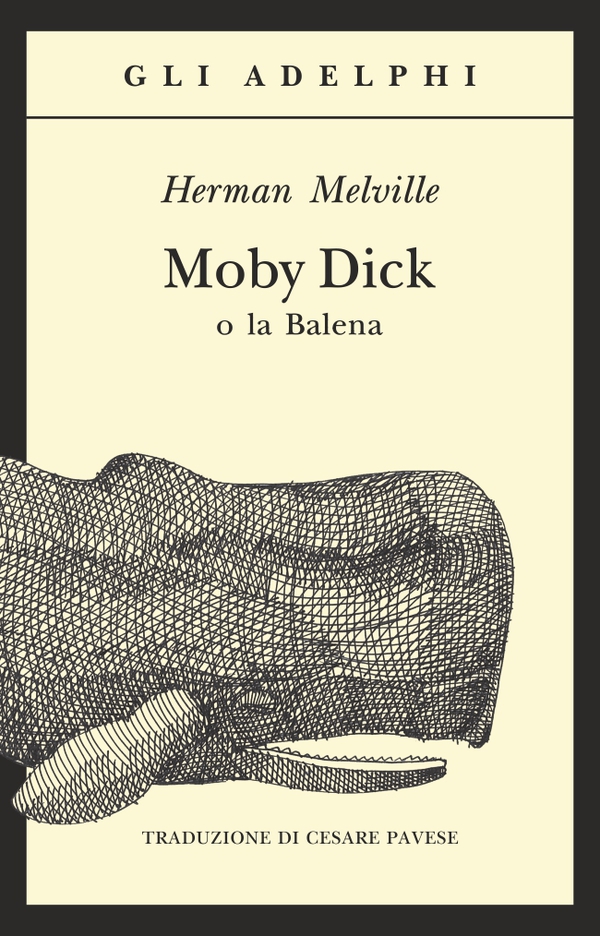 Moby Dick o la Balena
Moby Dick o la Balena
Letteratura nordamericana
Adelphi
1994
588