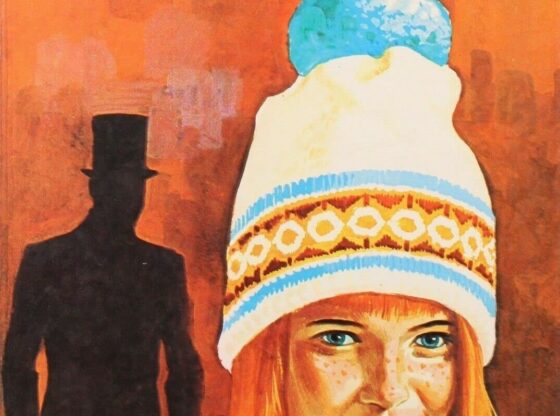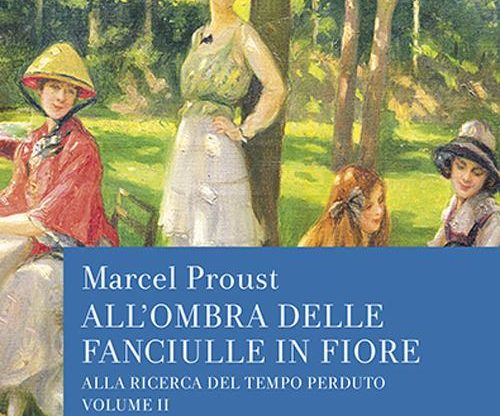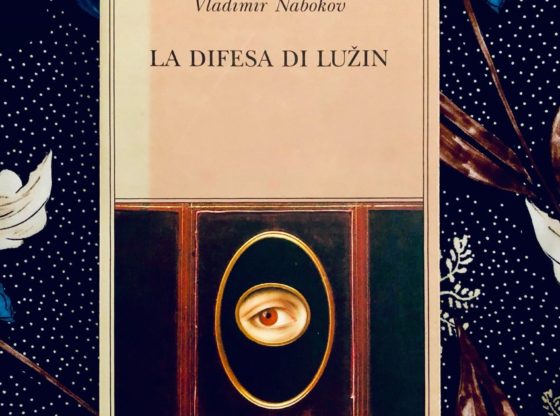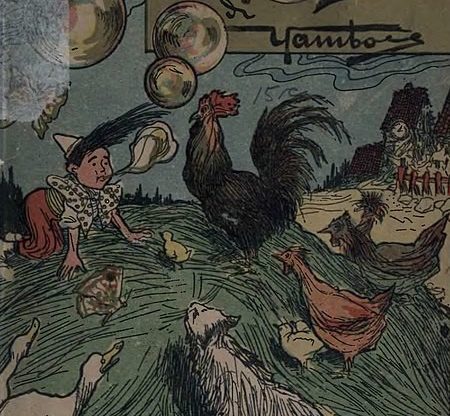Forse ci si accosta con diffidenza al romanzo di De Roberto “I Viceré“, ma ben presto il lettore viene conquistato dal ritratto realistico e spietato di una nobile famiglia borbonica nel passaggio all’unita d’Italia, tratteggiato dall’autore con una dissacrante ironia che rende l’opera avvincente e godibile fin dalle prime pagine.
Il romanzo ha una trama abbastanza complessa e ricca di personaggi, descritti con i loro vizi e, a tratti, con le loro caratteristiche più prosaiche volte ad evidenziare i conflitti familiari e le ambizioni spesso frustrate. Vengono narrate le vicende della nobile famiglia Uzeda, (discendente da coloro che erano stati viceré di Sicilia dal diciassettesimo secolo), in un lasso di tempo che va dalla metà dell’Ottocento fino al 1882, vicende caratterizzate da feroci e aspri contrasti tra i suoi vari esponenti, che palesano l’avidità e l’attaccamento morboso al potere. La vicenda si apre con la morte della principessa Teresa Uzeda di Francalanza, accorta e oculata amministratrice del patrimonio familiare, (dopo la morte prematura del marito Consalvo VII), che crea un senso di smarrimento e sconvolgimento nella famiglia, già lacerata da conflitti interni. Si organizza un sontuoso funerale “degno di un papa”, per seguire alla lettera le disposizioni della defunta, viene allestito in chiesa un barocco catafalco e organizzata una cerimonia funebre per accompagnare la salma con un variegato corteo di valletti in divisa, musicisti, cantori, prefiche, stuoli di orfanelle compunte, vecchi indigenti dell’ospizio Uzeda, operai della solfatara di proprietà della famiglia, frati cappuccini, e, a seguire, infine, le carrozze dei parenti e degli altri nobili. In un tripudio di ceri, fiori, Requiem e Dies irae, in mezzo ad una babelica confusione di gente accalcata, si svolge la cerimonia con la lettura di enfatici epitaffi sulla defunta. In tutta questa ostentazione si levano le voci malevole dei compaesani che criticano gli sprechi e l’inutile pompa del funerale e della servitù che deplora l’avarizia e l’intima spilorceria di quella famiglia dedita ad ostentare il lusso più sfrenato.
“Ed i curiosi stipati nella chiesa, continuando a parlar della morta, si rivolgevano insistentemente una domanda e si proponevano una questione: “chi sarà l’erede?…” Nobili e plebei, ricchi e poveri, tutti volevano sapere che direbbe il testamento, come se la morta avesse potuto lasciare qualcosa a tutti i suoi concittadini”.
Ed effettivamente la scaltra principessa, da precisa diplomatica, riesce a spartire l’eredità in maniera da non scontentare nessuno, in apparenza, ma gli eventi precipitano con l’avvento dell’Unità d’Italia. Come in ogni famiglia principesca, gli Uzeda hanno il loro figli cadetti, esclusi, costretti alla monacazione forzata, di manzoniana memoria, indotta con raggiri e violenze psicologiche, Ludovico e Angiolina, figli della principessa defunta, comunque si rassegnano alla vita monastica e addirittura il primo riesce a costruirsi una carriera straordinaria divenendo cardinale, ancora, il cognato della principessa, don Blasco, monaco libertino, dissoluto, astioso ed invelenito, che dopo la lettura del testamento si tormenta e non ha altri strumenti di vendetta se non aizzare i suoi parenti l’uno contro l’altro. “Trasformista” per eccellenza, prima borbonico sfegatato, poi liberale ed anticlericale approfitterà, più avanti nel corso della vicenda, della soppressione dei conventi per arricchirsi e gettare la tonaca alle ortiche.
E, nonostante gli odi e le continue liti, gli Uzeda sono uniti quando devono difendere gli interessi ed i privilegi della famiglia e non lesinano a ricorrere alla corruzione pur di tutelarli anche in un momento storico cruciale, il passaggio al nuovo stato italiano; perciò sono disposti a qualunque compromesso pur di conservare il loro dominio sociale ed economico. E’ amaro il sarcasmo con cui i personaggi sono tratteggiati, tutti quanti portatori di vizi e psicosi, che rasentano il grottesco, tesi a conservare i loro privilegi, a manifestare il loro spirito di sopraffazione in seno alla famiglia ed al parentado, le loro bizzarre follie e fissazioni maniacali, l’orgoglio di appartenere ad una razza eccelsa ma allo stesso tempo la consapevolezza che a poco a poco essa si sta corrompendo in un processo di degenerazione irreversibile. Palese ed emblematica dimostrazione è il mostruoso feto partorito da Chiara, una delle figlie della principessa, ossessionata dalla maternità, che viene conservato in un boccione sotto spirito:
“Anche gli altri a poco a poco se ne andarono, lasciando Chiara sola col marito a guardar soddisfatta quel pezzo anatomico, il prodotto più fresco della razza dei Vicerè”.
Nella seconda parte del romanzo emerge la figura di Consalvo, nipote della principessa, educato in un convento benedettino, che appena uscito vive una giovinezza dissoluta e debosciata, salvo poi prendere la decisione di intraprendere la carriera politica, per riscattare il suo sentimento di presunta superiorità intrinseco negli Uzeda. Prende esempio dallo zio, don Gaspare, duca d’Oragua, il primo Uzeda che approfitta della situazione, che si fa eleggere parlamentare del nuovo stato unitario, si crea una fortuna economica lucrando sui fondi pubblici, acquistando terreni e fabbricati e fondando una banca a Catania. E’ proprio lui a parafrasare il celebre motto di d’Azeglio, coniandone uno suo:
“Ora che l’Italia e’ fatta, dobbiamo fare gli affari nostri”.
Consalvo riesce a diventare prima sindaco, costruendosi l’immagine di principe colto e perfetto amministratore:
“La popolarità essendo tutta sua, egli faceva degli assessori ciò che voleva; se manifestavasi qualche velleità di contraddizione, la sedava suscitando gli uni contro gli altri coloro che s’accordavano nell’opposizione; oppure quando la faccenda era più seria, minacciando di andarsene. Allora tutti si chetavano. E di quel che riusciva bene egli aveva tutto il merito; di quel che non otteneva l’approvazione del popolo rigettava la colpa sulla giunta”.
Consalvo ha però mire più alte, vuole essere eletto deputato, colpisce il suo passaggio dalla condizione di aristocratico reazionario a liberale per poi barcamenarsi tra idee di sinistra senza però disdegnare quelle di destra pur di perseguire il suo tornaconto. Dopo una febbrile campagna elettorale, manifesti come lenzuoli col suo nome a caratteri cubitali, arringhe dal tono tribunizio, infarcite di citazioni, egli, consumato istrione, raggiunge il suo agognato obiettivo e, alla fine del romanzo, erede del titolo e delle fortune della famiglia, riesce a farsi eleggere al parlamento e afferma:
“La storia e’ una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi”
ovvero mutano le condizioni esterne ma non i detentori del potere. Consalvo fa sua anche la lezione del padre, che in occasione dell’elezione di don Gaspare, aveva pronunciato questa frase:
“Quando c’erano i viceré, gli Uzeda erano viceré , ora che abbiamo i deputati, lo zio va in Parlamento”.
La storia viene vista dunque come ripetizione ciclica che non annovera cambiamenti e progressi, infatti nonostante i mutamenti radicali in ambito politico persiste l’immobilismo e soprattutto il riproporsi delle stesse persone a detenere il potere. Il passaggio all’unita d’Italia e’ solo apparente, in realtà nulla cambia
La morale rimane che la “vecchia razza” degli Uzeda e’ capace di compiere una metamorfosi per assicurarsi, in una sorta di darwiniano adattamento, un posto d’onore nel nuovo ambiente storico-politico a simboleggiare l’eterno trasformismo del potere.
Graziella Enna
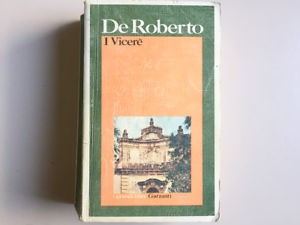 I Vicerè
I Vicerè
I Grandi Libri
Letteratura italiana
Garzanti
688