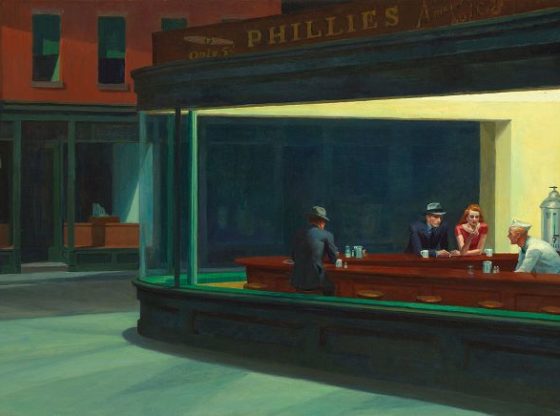Racconti di sabbia – Com’è che si fa questa fine?
Eccoci al consueto rilancio domenicale di un pezzo dei cugini de L’Arenone
La rubrica di racconti brevi di Angelo Deiana per L’Arenone. Pillole da mandar giù in pochi minuti, una tantum, per spezzare il tran tran della quotidianità.
Filippo non lo vedevo da almeno un anno.
Quando mi ha chiamato, sul cellulare non è nemmeno apparso il suo nome: aveva cambiato numero da un po’ e non l’avevo saputo. Ho risposto distrattamente, pensando fosse la solita rottura di palle di lavoro.
“Sì, pronto”.
“Mik, sono io”.
Non poteva che essere lui. Nessun altro mi chiama Mik. Solo una mia ex aveva provato a chiamarmi Miky: la storia durò pochissimo. Era evidentemente partita con il piede sbagliato.
“Che bello risentirti, ma che fine hai fatto? Come stai? È successo qualcosa?”.
Lo inondai di domande in quattro secondi. Perché effettivamente vissi questa vertigine emotiva: la felicità di risentirlo, la rabbia per non esserci più incontrati, la voglia di sapere come stesse, ma, soprattutto, la paura: perché quando una persona, un amico, che non senti da tanto tempo ti richiama così, dal nulla, non è mai per dirti che lo hanno promosso a lavoro o che è diventato padre, ma è solo per annunciarti una tragedia.
“Ti va se ci vediamo una di queste sere?”.
Appunto.
“Certo, anche domani se vuoi”.
E fissammo subito l’incontro. Era troppa la voglia di rivederci, anche se mi costò insulti inqualificabili da parte della mia cricca del calcetto: quel mercoledì giocarono in cinque contro quattro, e solo chi gioca a calcetto sa cosa voglia dire. Non esiste frustrazione più grande, non esiste sensazione di rabbia e insoddisfazione pari a chi si ritrova in una partita di calcetto con un giocatore in meno, perché parti già con la consapevolezza che non ti divertirai, che stai facendo una cosa totalmente priva di senso. Ma sapevo che prima o poi sarebbe arrivato anche per ognuno di loro il giorno in cui avrebbero dovuto dare buca all’ultimo minuto, lasciando gli altri in nove. Non ottenni grande comprensione, ma almeno gli concessi la gratuità di un bonus da spendere in futuro.
“Mi dispiace, poi vi spiego”, dissi troncando la conversazione sull’originalissimo gruppo Whatsapp dal nome Quelli del calcetto.
Ma non mi dispiaceva affatto, sentivo che ne valeva la pena.

Con Filippo ci incontrammo dalla Brigida, la trattoria dove andavamo sempre dai tempi dell’università, si spendeva poco e si mangiava molto: il giusto compromesso per ogni studente che si rispetti. Altrimenti non avremmo frequentato economia…
Devo essere sincero, la prima cosa che ho pensato quando l’ho visto è stata: Cazzo, ma io sono così vecchio?
Tanto che entrando mi sono subito guardato allo specchio. Ma non mi trovai malandato… Sì, è vero: il calcetto, la palestra, l’ora di yoga il lunedì per iniziare bene la settimana, niente figli, solo Rambo da portare a spasso la sera… Sicuramente tutto questo mi aiutava a “mantenermi bene”. Filippo invece si era ingrigito (non lo ricordavo), aveva un’aria trasandata e delle occhiaie così vistose da far pensare a una scazzottata.
Eppure, da ragazzi, era lui il più bello. Non c’era verso di riuscire con una ragazza se c’era lui nei paraggi: appena spuntava, ecco che quella ti salutava e se ne andava da lui. Gli cadevano tra le braccia, nemmeno doveva andare a cercarsele. Quanto lo invidiavo per questo… E allora giù a lavorare di mestiere e simpatia, di fascinazioni e pippe mentali pseudointellettuali. Certo, col tempo poi le cose sono cambiate: lui si era perdutamente innamorato di Luisa, e io che non avevo battuto chiodo per tanti, troppi anni, non riuscivo a stare con una ragazza per più di tre mesi. Quella, ad esempio, la lasciai solo perché mi chiamava Micky… E alle altre non toccò miglior sorte. Entrai così, quasi senza rendermene conto in una sorta ci circolo vizioso.
Ma adesso avevo una paura fottuta che Filippo dovesse mettermi di fronte al fallimento della sua vita: ce l’aveva scritto in faccia, o meglio, nelle occhiaie, che gli stava andando (o gli era già andato) tutto a puttane.
“Com’è che si fa questa fine?”.
Me lo chiese così, dopo che la cameriera grassottella ci prese le ordinazioni di due antipasti, due amatriciane e una brocca di vino della casa. Il solito schifo.
Apprezzai il fatto che mi guardò negli occhi. Lo interpretai come un atto di fiducia nei miei confronti, e quindi come il segno evidente che, nonostante tutto, quando ci si è voluti bene per tanto tempo, anche se poi salti qualche turno senza nemmeno passare dal via, poi almeno quella, la fiducia, dico, resta immutata, insieme all’affetto.
“Che fine, Filippo? Qualcosa non va con Luisa? Vi state lasciando?”.
“Macché, no: peggio. Ci stiamo non-lasciando”.
“Spiegati”.
E intanto un vassoio ricolmo di bruschette, formaggi e affettati si piazzò tra di noi.

“Tu non puoi capirlo perché non sei mai stato con una persona per più di due giorni… Ma la vita di coppia è una cosa complessa, si gioca tutto su una serie di equilibri che poi, se vengono a mancare, fanno crollare tutto. Praticamente non ci parliamo più, viviamo nella stessa casa ma comunichiamo solo per quello che riguarda Giada e Luca. Non ci fossero loro non ci rivolgeremmo nemmeno la parola. Da due mesi lei dorme in una stanza e io in un’altra. La notte, però, entriamo in camera insieme, così i bambini continuano a pensare che vada tutto bene. Poi quando si sono addormentati, io sloggio. E così accade la mattina: mi sveglio sempre prima, perché non vorrei che mi ritrovino nell’altra stanza. È successo una volta: Giada si è alzata di notte perché non si sentiva bene, è entrata in camera nostra e non mi ha trovato. Ci è toccato dirle che avevo un forte raffreddore e russavo troppo, e mamma non riusciva a dormire; cosa grave perché poi avrebbe dovuto lavorare tutto il giorno… Si è messa a ridere e ha fatto il verso di uno che russa come un trombone. Ma non può andare avanti a lungo. Giada, soprattutto, è sveglia e qualcosa l’ha già capita…”.
La cameriera ci portò via i piatti, facendo cadere una forchetta a terra. La presi io, per non metterla in imbarazzo: ci scambiammo un sorriso.
“Adesso pure con queste ci provi? Io non mi ricordo nemmeno cosa c’hanno in mezzo alle gambe”.
“Che coglione che sei. Continua, mister padre di famiglia, sono tutto orecchie”.
“C’è poco da continuare… Non so che cazzo fare. Ogni mattina mi sveglio e mi chiedo che senso abbia tutto questo”.
“Ma tu la ami ancora?”.
Arrivarono le due amatriciane.
“Non lo so. Penso di sì. Voglio dire: non riesco a immaginare un’altra vita, non riesco a vedermi senza lei, senza la nostra casa – che quella poi ce l’abbiamo cointestata, il mutuo lo prendemmo insieme – e non riesco a vedermi senza Giada e Luca che mi stanno tra i piedi: e papà qui e papà lì… Ma tu non puoi capire neanche questo… Ti saprà ora di metter su famiglia? Quando vuoi dartela una sistemata? Aspetti la pensione?”.
“Cioè, dopo tutto quello che mi hai detto, mi chiedi anche perché non mi faccia una famiglia? Mi avessi fatto il ritratto alla Mulino Bianco, avrei anche potuto dirti che ci avrei pensato… Ma insomma, non sei stato un buon promoter”.
“Sì, ma che c’entra. Ogni storia è a sé”.
“E la tua a che sé è in questo momento?”.
“È al sé di una cosa bellissima che forse è arrivata alla fine. E si deve trovare il coraggio di cambiare. Come dice quella canzone? ‘Si muore un po’ per poter vivere’, no?”.
“Non mi sembri tanto convinto”.
“Non lo sono, infatti”.
Seguì una pausa. Io non aggiunsi nulla, aspettai. E nel mentre pensavo, però, che non potendo dare risposte ai suoi problemi, la cosa migliore fosse fare una domanda.

“Com’è che si fa questa fine?”.
Sospirò, mandando giù un altro bicchiere di rosso.
“Che fine, Mik? Guarda come stai bene, sei il ritratto della serenità. Ti sei stufato di fare il latin lover?”.
In realtà, parlando con lui, mi resi conto che tutto l’apparato di menzogne che mi stavo raccontando da un po’ non reggeva più: non stavo bene. E alla mia casa in ordine, ma vuota, forse preferivo la sua incasinata, coi marmocchi a sporcare le pareti con i pennarelli. Alle mie serate da eterno ragazzo, preferivo un tranquillo momento di pace seduto a un tavolino: con me a leggere un giornale, e lei a pigiare le dita su un pianoforte.
“Forse sì. Insomma, mi manca la quotidianità con qualcuno, andare al cinema, prenotare una stanza per due non per una sola notte ma per una settimana intera, magari. Sento il desiderio di condividere. Mi sono accorto di non bastarmi più”.
“Non mi sembri convinto”.
“Non lo sono, infatti”.
Altra pausa. Gli occhi nei resti del sugo.
“Volete un dolce?”.
“Mi sa di sì”, rispondemmo in coro.
“Non mi sembrate tanto convinti”, disse la ragazza grassottella.
Scoppiammo in una fragorosa risata. Lei ci guardò male, pensò subito che la stessimo prendendo in giro. Invece, stavamo semplicemente prendendo in giro la vita, e noi con lei.
Ordinammo due tiramisù.
“Tanto va sempre così: iniziano col tiramisù, poi ti tirano fuori altri cinque o sei dolci, ma tu te li scordi e alla fine prendi sempre quello, il tiramisù”.
Ce li portò poco dopo, li mangiammo in silenzio.
Pensai che Filippo aveva ragione: non ci avevo mai pensato. Forse aveva anche a che fare con il modo in cui si fanno determinate scelte nella vita.
Il cacao mi si attaccò al palato.
All’uscita, ci abbracciamo davanti alle macchine, promettendoci di rivederci presto.
Ci rendemmo conto, senza dircelo, che eravamo felici per esserci ritrovati: due vecchi amici che si sono sempre voluti bene e che avevano smesso di confessarsi i reciproci fallimenti chissà per quale timore.
Abbattere il totem dell’idea di fallimento fu la nostra più grande conquista. Tutti e due stavamo fallendo: dircelo ci serviva per ripartire. Ognuno a modo suo.
Ovviamente, ci risentimmo l’indomani, e nei giorni a venire.
Una settimana dopo uscii con una ragazza.
Dopo la cena, fuori dal ristorante, mi disse che voleva essere riaccompagnata a casa: “Mi fanno tristezza quelli che prendono il tartufo nero come dolce. Sei triste”. Così, disse.
Scoppiai a ridere, poi la abbracciai: non ero mai stato così felice per un due di picche. Forse mi prese per pazzo, ma lei non poteva sapere che dopo aver parlato con Filippo mi ero ripromesso di non fermarmi più alla prima possibilità.
Per questo ripiegai sull’ultima. Quando chiedi cosa ci sia per dolce, i camerieri lasciano sempre il tartufo nero in fondo alla lista.
Fu il mio personalissimo modo per dare una svolta alla vita.
Per leggere L’Arenone clicca su www.arenone.it