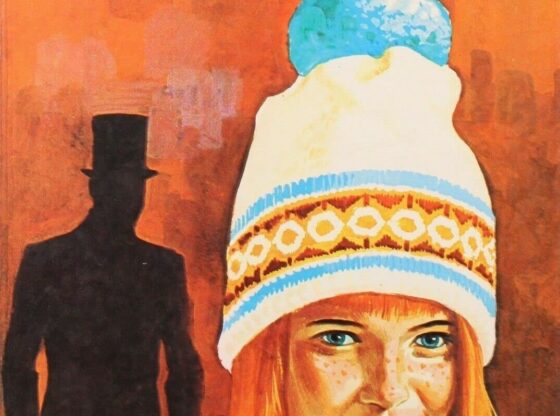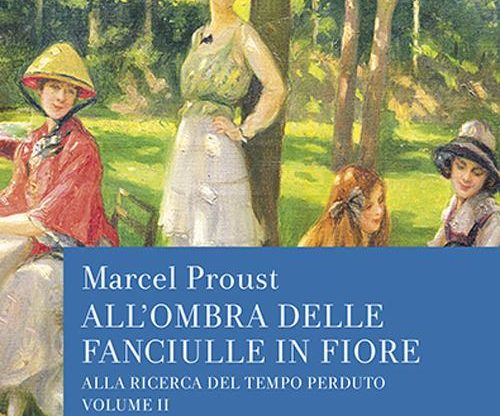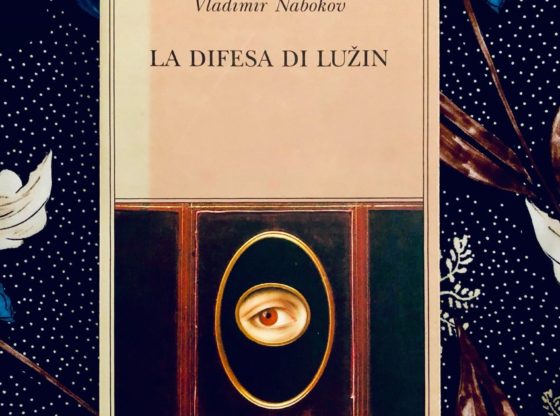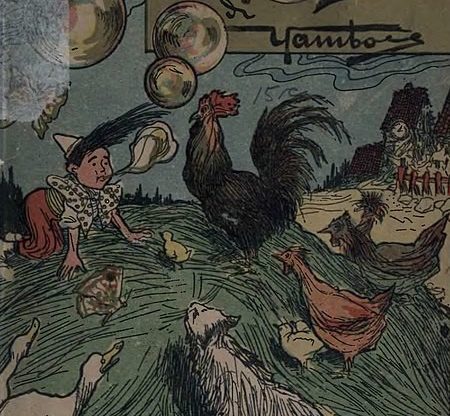“Gli zii di Sicilia” è un libro che si legge per meditare su problemi ancora vivi nella nostra coscienza, per comprendere come siano stati recepiti e vissuti eventi storici epocali e ideologie dominanti, in contesti per natura isolati e economicamente meno progrediti. Sciascia scrive quattro racconti a sfondo storico (pubblicati prima nel 1958 e poi nel 1960 con l’aggiunta dell’ultimo racconto) ambientati in Sicilia, uno nel 1848, gli altri tre prima e dopo la seconda guerra mondiale, presentando al lettore una prospettiva ingenua, che mette in luce la distanza che separa la realtà effettiva da chi narra e osserva il dipanarsi degli accadimenti con una visione mistificata a volte carica di illusioni e aspettative mal riposte. Il punto di vista della narrazione proviene infatti dalle “basse sfere”, di verghiana memoria, ovvero da una realtà sociale lontana dall’irruzione della storia, che, pur subendone le conseguenze, è immersa nell’immobilismo atavico della Sicilia. “Gli zii di Sicilia” è il titolo emblematico che indica, in due dei quattro racconti, la figura del personaggio chiave, oggetto della narrazione, negli altri due, eventi ritenuti forieri di cambiamenti e miglioramenti, su cui si incentrano le speranze dei protagonisti delle vicende che spesso ne ricevono in cambio inganni e delusioni. Il tutto viene raccontato in modo oggettivo, lucido, disincantato e venato di sapiente ironia che non sfugge ad un lettore attento.
Il primo racconto, “La zia d’America”, ha come voce narrante un ragazzo, che, tra scorribande con gli amici, vede e osserva, con ingenuità ed acutezza, il suo piccolo borgo rurale diviso tra fautori e detrattori di Mussolini, in un momento cruciale della storia del Novecento: la fine della guerra, la partenza dei tedeschi e l’agognato arrivo degli Americani, visti come emblema della libertà e della prosperità economica. Grazie ai racconti dei soldati di passaggio nel paese che descrivono il benessere materiale in cui si vive oltreoceano, fatto di automobili, dollari, sigarette e altri beni voluttuari, gli abitanti del paesino si improvvisano filoamericani per convenienza. Tutto ciò è acuito dalla corrispondenza della madre del protagonista con la sorella, la zia d’America, che alimenta il mito americano con le descrizioni della condizione di agiatezza raggiunta con la sua attività commerciale, lo “storo”, cui si aggiunge l’attesa quasi messianica dei pacchi dono ai suoi parenti e ai suoi compaesani che finalmente giungeranno loro a guerra conclusa. Ma il momento culmine della storia è l’arrivo in paese della zia (accompagnata da marito e figli), con bauli e masserizie al seguito, che assume tratti grotteschi con la sua opulenza fisica, gli abiti di colori vistosi, gli occhiali d’oro, elementi che accentuano i caratteri della villana rifatta. L’ostentazione di ammennicoli moderni e i ridicoli termini in inglese storpiato, con cui la zia si riempie la bocca per stupire gli ingenui compaesani, ne fanno un personaggio caricaturale.
“La delusione di mia zia aveva due facce; noi parenti non eravamo morti di fame come dall’America ci immaginava, lei si aspettava di trovarci nudi bruchi, rimpannucciati con i suoi vestiti e nutriti con le sue scatole di conserve vitaminizzate”.
Ferisce e umilia parenti e amici l’atteggiamento pietistico e di commiserazione adottato dalla zia nel donare capi di vestiario di fogge strampalate, carabattole americane, dollari elargiti come portafortuna, ma non a persone in ristrettezze economiche, viste come potenziali approfittatori: tutto ciò evidenzia la fasulla ed ipocrita generosità e cela invece la meschinità e grettezza d’animo che la donna manifesterà alla fine della vicenda dimostrando che non fa niente per niente ma persegue dei secondi fini, non ultimo quello, precedente al suo arrivo, di indottrinare amici e parenti su posizioni politiche filoamericane in Italia (da concretizzare in sede di elezioni), conditio sine qua non, se avessero voluto ancora ricevere i suoi pacchi. Allo stesso tempo emerge anche la rabbia della zia nel vedere che i suoi parenti alla fine conducono un’esistenza, sì umile e modesta, tra polvere e mosche, ma decorosa. Si palesa così all’occhio critico del protagonista l’illusorietà del mito americano alimentato per anni dall’immaginario collettivo paesano.
Il secondo racconto, “La morte di Stalin”, ambientato a Regalpetra, (rappresentazione letteraria di Racalmuto, luogo di nascita di Sciascia), nel 1948, viene narrato in prima persona da Calogero Schirò, negoziante, fervente comunista e reduce dal confino a Lampedusa nel ’40: anche lui ha il suo “zio di Sicilia”, infatti ha riposto tutte le sue speranze nella figura di Stalin:
-Lo zio di tutti, il protettore dei poveri e dei deboli, l’uomo che aveva nel cuore la giustizia. Calogero chiudeva ogni ragionamento sulle cose storte di Regalpetra e del mondo indicando il ritratto: ci penserà “lu zi’Peppi”-
Proprio il giorno delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, il 18 aprile del 48, don Calogero (convinto di poter parlare con Stalin come se fosse la sua coscienza), fa un sogno in cui gli appare il suo idolo, che, con volto truce, gli preannuncia la sconfitta elettorale del comunismo, che di fatto, in quell’occasione, fu netta. Si apre un’analessi in cui il protagonista ripercorre le vicende belliche del secondo conflitto mondiale dal suo punto di vista ideologico, da cui emergono le illusioni e le speranze che don Calogero negli anni ha alimentato credendo il dittatore una sorta di salvatore dell’umanità. Quando, alcuni anni dopo le elezioni, nel 53, don Calogero apprende la notizia della morte di Stalin, tutto sembra crollargli addosso, ma poi iniziano a circolare voci sui presunti errori del suo mito e gradualmente venne fuori la verità: egli, tramite quotidiani e riviste conosce tutte le nefandezze e le atrocità della dittatura staliniana che inizialmente crede fantasie degli americani:
“fosse stato vero c’era da sudar freddo, ma tutto inventato era”.
E capisce infine, durante una conversazione col suo amico e compagno deputato, che Stalin, né più né meno era come Hitler. Tuttavia usa frode alla sua coscienza e lo giustifica, per non dare soddisfazione al suo acerrimo nemico, l’arciprete, adducendo come pretesto che Stalin era diventato strambo a furia di fare del bene e provando per lui l’umana compassione dovuta a qualunque defunto.
Il terzo racconto intitolato “Il Quarantotto”, riporta il lettore agli avvenimenti ed ai disordini del 1848 in Sicilia, questa volta il narratore è il giovane figlio del giardiniere e cocchiere del barone Garziano, che illustra le vicende che si dipanano prima e durante il 1848 e giungono fino all’Unità d’Italia, seguendone la sua crescita e maturazione. E’ forse il racconto più dissacrante e più vicino a quel “proteismo” dei Siciliani di cui Sciascia parla anche in un suo saggio “Sicilia e sicilitudine”, (contenuto nella raccolta “La corda pazza”): vuole insomma dimostrare il trasformismo della vecchia nobiltà baronale di stampo borbonico, pronta ad adattarsi a qualunque nuova realtà politica pur di non perdere i propri privilegi. Per fare un parallelo si potrebbe associare questa posizione a De Roberto, Tomasi di Lampedusa, Verga, esempi eclatanti di scrittori che hanno trattato questo tema. Il barone Garziano, di cui viene descritta, in modo ironico e impietoso, la vita dedita al libertinaggio, spalleggiata dalla chiesa, è disposto a qualsiasi forma di corruzione per tutelare i suoi interessi e dimostra nel corso della narrazione di essere sempre pronto ad incensare il potente in auge di turno. Ruotano intorno a lui altri personaggi che subiscono le sue angherie e assistono impotenti alle sue manovre: moglie, figli, amante, servitù. Fieramente avverso ai moti rivoluzionari, si preoccupa di far sparire tutti coloro che possono costituire una minaccia per gli aristocratici, ma quando si accorge che i rivoluzionari hanno avuto la meglio e giungono i garibaldini, attua un voltafaccia plateale che fa inorridire, in primis, la moglie, che nei decenni aveva sempre disprezzato l’atteggiamento ruffiano, lascivo e meschino del marito, tanto da non rivolgergli direttamente la parola se non per interposta persona. Ecco la reazione del barone alla notizia della vittoria di Garibaldi a Calatafimi portatagli dal genero:
“dapprima aveva reagito con violenza […] Subito aveva cominciato a mettere sottosopra la casa, a far rimuovere ritratti e stampe del re e della real famiglia, una serie di stampe sulla visita di Ferdinando in Sicilia ed un ritratto di Pio IX […] Il barone rispose alla moglie che il generale Garibaldi stava arrivando a Castro e bisognava preparare la casa per riceverlo degnamente.”
Il barone, come ultimo atto della sua ipocrisia, apre la sua casa ai nuovi vincitori offrendo loro ospitalità ed onori con uno stucchevole e affettato servilismo. E’ esilarante il finale della vicenda in particolar modo lo scambio di battute tra Garibaldi e Ippolito Nievo che comprendono bene la falsa euforia del trasformismo del barone, sempre a pronto a salire sul carro del vincitore.
Il quarto racconto, “L’antimonio”, venne inserito in un secondo momento nella raccolta “Gli zii di Sicilia”, e, si configura quasi come un romanzo incompiuto. Il protagonista della vicenda, che si apre in medias res, vive un vero e proprio percorso di formazione: egli si trova in Spagna e combatte con l’esercito franchista, ma cosa può averlo spinto ad arruolarsi e rischiare la vita per una guerra di cui non conosce il significato? Questo è l’inquietante interrogativo che si affaccia alla mente del lettore, che intuisce la risposta solo a narrazione inoltrata, quando scopre che l’antimonio, (il letale gas delle miniere altrimenti noto come grisou), è il movente della vicenda e capisce quale sia il nesso che lo lega alla vita del protagonista: egli, era scampato per miracolo, con una fuga precipitosa nei cunicoli bui della miniera, alla repentina e violenta fiammata generata dal terribile gas.
“Sempre avevo avuto spavento dell’antimonio, perché sapevo che bruciava le viscere, così mio padre era morto, conoscevo molti che per l’antimonio erano ciechi. Decisi che mai più sarei tornato alla zolfara, Sapevo che c’era una guerra in Spagna, molti erano andati a quella d’Africa e avevano fatto i soldi. .[…]. Mi arruolarono. Mia madre e mia moglie piansero. Io partii col cuore in pace: la zolfara mi faceva paura, al confronto la guerra in Spagna mi pareva una scampagnata”.
Così il nostro protagonista si improvvisa soldato ma, paradossalmente, solo lontano da casa riesce a capire finalmente il mondo in cui aveva fino ad allora vissuto, inconsapevolmente, seguendo quell’ “ideale dell’ostrica” verghiano. L’osservazione distaccata del suo mondo, gliene offrirà, nel corso della narrazione, finalmente un’oggettiva conoscenza.
“Fino all’arrivo in Spagna non capivo niente del fascismo, per me era come se non ci fosse, mio padre aveva lavorato nella zolfara, e anche mio nonno, e come loro io nella zolfara lavoravo: leggevo il giornale, l’Italia era grande e rispettata, aveva conquistato l’impero. Mussolini faceva dei discorsi che era un piacere sentirli.”
In Spagna è il commilitone Ventura ad aprirgli gli occhi e a svelargli la triste realtà di quella guerra orribile, capisce infatti il significato di essere di destra (credeva che fosse un’usanza o un complimento spagnolo) e di sinistra, la brutalità della giustizia sommaria e delle fucilazioni. Nella battaglia di Guadalajara avviene un’altra presa di coscienza, poichè attraverso gli altoparlanti vengono diffusi inni dei lavoratori e si spiega esplicitamente agli Italiani che stavano combattendo per impedire a contadini e operai di vivere liberamente: ciò svela l’inganno del fascismo nella mente del protagonista,
“in ogni soldato la guerra muoveva dei pensieri che rivelavano la faccia del fascismo: la pazzia di un uomo che col consiglio di vigliacchi e di buffoni guidava il destino di milioni di italiani, e chissà a quale precipizio li portava”,
gli palesa inoltre la miseria di ogni guerra, facendogli capire che gli uomini sono soltanto uomini, senza bandiere ed etichette come fascismo o comunismo. Vedere poi tutte le città spagnole, teatro di altri combattimenti lo spinge ad un confronto continuo con le città siciliane, a paragonarvi il proprio modo di vivere, a riflettere sul fatto che la morte in miniera e quella in guerra alla fine sono la stessa cosa. La guerra lo spinge anche ad acquisire una nuova consapevolezza di sè stesso e dei rapporti umani, a mettere in discussione il suo matrimonio forse contratto con leggerezza, senza veramente capire che l’amore e’ un percorso condiviso di scoperte atto ad affrontare le difficoltà della vita. Torna a casa, alla fine, il nostro protagonista, con una pensione che suscita la gioia dei suoi familiari, ma niente più è come prima per lui, minato nel corpo e nello spirito, non ha visto certo l’immagine della Spagna che i suoi compaesani hanno, fatta di chitarre, flamenco, fastose processioni religiose e altre immagini folkloristiche. Questa è invece la profonda riflessione del protagonista che elimina ogni mistificazione e mette di fronte al lettore la cruda realtà:
“Tante persone studiano, diventano ottimi professionisti [….], a queste io vorrei chiedere: -sapete cos’è stata la guerra di Spagna? Se non lo sapete, non capirete mai quel che sotto i vostri occhi oggi accade, non capirete niente del fascismo, del comunismo, della religione dell’uomo, niente di niente capirete mai: perché tutti gli errori e speranze del mondo sono concentrate in quella guerra […]. Io sono andato in Spagna che sapevo appena leggere e sono tornato che mi pare di poter leggere le cose più ardue che un uomo può pensare e scrivere-”.
E così si evince dalla vicenda che solo attraverso l’esperienza conoscitiva data dal dolore, un siciliano ignaro del mondo diventa esperto “de li vizi umani e del valore”, capisce la sua terra mentre le sta lontano, attraverso il confronto con altre realtà, così gli eventi vissuti diventano un paradigma universale per dimostrare l’inganno delle ideologie politiche imposte in maniera coatta.
Graziella Enna
 Gli zii di Sicilia
Gli zii di Sicilia
Gli Adelphi
Letteratura italiana, racconti
Adelphi
1992
247