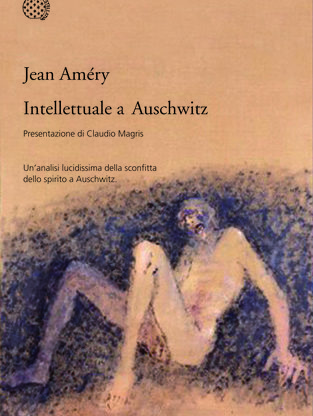Per introdurre la sconvolgente e unica testimonianza di Shlomo Venezia, risultano estremamente incisive le riflessioni di Primo Levi ne “I sommersi ed i salvati”, quando parla del rimorso vissuto dai superstiti dei campi di sterminio: attanagliati dal senso di colpa e di impotenza per non aver potuto aiutare i loro compagni di sofferenza, si sono portati dentro per sempre il dolore di essere rimasti vivi. Ancora più tormentosa, fu la condizione di coloro che furono costretti a essere complici in modo coatto dei loro carnefici nelle cosiddette “unità speciali”, i Sondekommandos. Questa sorte infausta toccò a Shlomo Venezia che ne fece parte, ma è aberrante pensare alla mostruosa e perversa perfidia da parte delle SS nel costringere i prigionieri, in massima parte Ebrei, a piegarsi a ogni umiliazione e degrado ordinando loro di distruggere materialmente altri Ebrei e, moralmente, se stessi, come immediata conseguenza. Le “squadre o unità speciali”, lungi dall’avere presunti privilegi, se non qualche pagnotta o gamella di zuppa in più, subivano lo stesso destino degli altri internati, anzi uno peggiore, perché era messa ogni cura e diligenza nell’eliminarli, affinché nessuno di loro, portatore di tremendi segreti, potesse vivere e divulgarli.
Shlomo Venezia, miracolosamente scampato, ha iniziato a narrare le sue vicende solo nel 1992, ben quarantasette anni dopo la sua liberazione. Deliberatamente prese questa decisione, conscio del fatto che nessuno volesse ascoltare la sua storia e credere a tanto orrore, anzi, quando provò ad accennare a qualche episodio, a guerra finita, qualcuno lo tacciò di essere uno squilibrato. Riuscì per decenni a non parlarne nemmeno con la moglie e i figli, non voleva che le persone a lui più care, portassero, come lui, un infame peso e fossero contaminate da un simile dolore. Poi, finalmente, trovò il coraggio e scrisse il libro senza omettere nulla.
Colpisce il lettore, la lucidità, l’onestà, la schiettezza, la semplicità con cui è narrato ogni dettaglio, sempre scevro da patetismo autocommiserazione volti a suscitare pietismo. Commuovono il coraggio, l’inesausta energia, l’arte di arrangiarsi a volte con un pizzico di scaltra e tempestiva intuizione, la sovrumana forza d’animo anche nell’abisso del dolore più cupo, degradante e lacerante della disumanizzazione e dell’abiezione che Venezia fu costretto a sopportare.
Ebbe un’infanzia difficile: nato nel 1923, apparteneva alla comunità ebraica di origine italiana di Salonicco, secondo di cinque figli, rimase orfano a soli undici anni e, a dodici, iniziò a lavorare per aiutare la madre a sfamare la famiglia.
“ Eravamo circondati da una grande miseria, il che ha formato il mio carattere e mi ha portato alla convinzione che una vita di privazioni rende le persone più forti.”
Nel 1938, dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali, iniziò a serpeggiare l’antisemitismo anche nelle comunità italiane lontane dalla madrepatria, come Salonicco, che anni prima aveva avuto dei vantaggi dal governo fascista, sebbene fossero un mero espediente politico di propaganda all’estero. Con l’invasione italiana dell’Albania nel ‘40, cui poi seguì quella tedesca, iniziarono le deportazioni, prima degli Ebrei greci e poi di quelli italiani. Shlomo e la sua comunità furono trasferiti prima ad Atene, grazie all’intervento del console italiano, ma fu solo un’illusione di salvezza: dopo l’otto settembre finì la protezione italiana e l’unico destino fu la deportazione.
Il viaggio da Salonicco ad Auschwitz durò circa undici giorni, nelle condizioni, a tutti ben note, dei treni merci. Fortunatamente Shlomo fu abile a occultare pacchi con ausili, ricevuti alla partenza dalla Croce Rossa, nel suo vagone, cosa che permise a tanti di sopportare il durissimo tragitto.
Dopo l’arrivo ad Auschwitz, Shlomo non rivide mai più la madre e due delle sue sorelle, mentre riuscì a restare in contatto con il fratello e i cugini. Dopo i crudeli rituali previsti all’ingresso nel campo, organizzati con la consueta catena di montaggio disumanizzante, si aprì la terrificante realtà fatta di fame, disperazione, efferata e sadica violenza nei confronti dei prigionieri, perciò, quando nella baracca si presentò un kapò che invitava, chiunque volesse, a un “lavoretto supplementare” in cambio di una razione alimentare in più, egli, senza esitare, assecondando l’istinto insopprimibile della fame, accettò, senza immaginare neppure minimamente a cosa sarebbe andato incontro.
“Se avessi saputo che il nostro lavoro supplementare consisteva nel tirar fuori i cadaveri e portarli al Crematorio, avrei preferito morire di fame piuttosto cha accettare, ma quando lo compresi, era troppo tardi”.
E, in un breve lasso di tempo, Shlomo capì, vedendo il fumo che costantemente usciva dalla ciminiera, che esisteva nel campo un luogo dove venivano bruciati i morti, ma anche uno, inimmaginabile, dove le persone erano uccise in massa al loro arrivo. Si aprì per lui la discesa nell’inferno del Sonderkommando, definito “comando speciale”, ma inizialmente non comprese i vari passaggi di questo mostruoso ingranaggio di morte. Seppe anche che tutti coloro che facevano parte del Sonderkommando prima o poi sarebbero stati “selezionati”, (falso eufemismo che significava “uccisi”) e sostituiti con altri stücke, “pezzi”: in altri termini, nessuno dei prigionieri dopo aver visto cosa succedeva realmente, sarebbe dovuto sopravvivere per poterlo narrare. Il lavoro si rivelò molto massacrante ma soprattutto impossibile da sopportare e metabolizzare, il supplemento di cibo non era che un ignobile compromesso di fronte all’atto di dover bruciare cadaveri in fosse comuni o nei famigerati forni.
“Vedendo quel corpo bruciare, mi ritrovai a pensare che i morti avevano forse più fortuna dei vivi: non erano più obbligati a subire questo inferno in terra, a vedere la crudeltà degli uomini”.
La narrazione continua e sono inseriti nel testo anche dei disegni del sopravvissuto David Olère che rappresentano alcune terrificanti e realistiche scene. Solo in occasione della scrittura del libro, Schlomo riesce a raccontare la morte nelle camere a gas e le immagini tragiche che si presentavano agli occhi dei prigionieri prima e dopo. Le descrizioni lasciano il lettore incredulo, senza fiato, impietrito: impossibile, razionalmente trovare una spiegazione di tanta efferata e ingiustificata crudeltà, pianificata a tavolino da menti, sì folli, ma lucide e consapevoli.
“Li trovavamo aggrappati gli uni agli altri, ognuno alla ricerca disperata di un po’ d’aria […] erano talmente pigiati tra loro che i più piccoli e i più deboli venivano immancabilmente soffocati [..] La scena che ci si presentava aprendo la porta era atroce, impossibile farsene un’idea. […] i primi giorni, malgrado la fame che mi attanagliava, facevo fatica a mangiare il pane che ci davano, mi sentivo insudiciato dalla morte”
I compiti dei membri del comando speciale erano dunque inenarrabili, ma nessun prigioniero addetto poteva rifiutare di eseguirli, sarebbe stato ucciso all’istante, e, sebbene ognuno di loro avesse comunque la certezza di dover morire presto, l’istinto di tenersi in vita comunque prevaleva.
“Se avessi creduto anche un solo istante di sopravvivere, avrei annotato tutto per poter raccontare [..] Qualcuno mi ha chiesto se non sarebbe stato meglio farla finita. Forse, anzi, certamente. Ma io non ci pensavo, bisognava andare avanti giorno dopo giorno senza farsi domande: continuare a vivere anche se era terribile. […] Penso che ci sia voluta una forza particolare per sopportare tutto ciò, una forza fisica e morale.”.
Molti, all’interno del campo stesso, pensavano che i prigionieri avessero una parte di responsabilità in ciò che succedeva nel crematorio, ma in realtà non era così:
“E’ importante sottolineare che noi non avevamo scelta: quelli che si rifiutavano venivano uccisi con un colpo di pistola alla testa. […] e poi non ragionavamo più con il nostro cervello, pensando a quello che succedeva.. eravamo diventati degli automi. […] non eravamo più padroni di niente”.
Quando le SS ordinano di smantellare i forni in previsione dell’evacuazione del campo, gli addetti del Sonderkommando furono radunati in disparte in modo che nessuno potesse portare notizie all’esterno. Shlomo e altri, rischiando la vita, s’intrufolarono nelle baracche di coloro che si preparavano alla “marcia della morte”, eludendo i controlli e le domande delle SS che chiedevano se qualcuno avesse lavorato nel Sonderkommando, per eliminarlo. La colonna di Shlomo era composta di circa seimila persone, i pochi reduci del reparto speciale erano in condizioni fisiche relativamente migliori perché avevano ricevuto qualche caloria in più, perciò si prodigavano per aiutare gli altri. L’odissea sotto la neve e il gelo portò quelli che non morivano di freddo e di stenti, in Austria, prima a Mauthausen, poi ai lavori forzati nel campo di Melk: nuove fatiche e nuove sofferenze, ancora fame per esseri umani già ridotti allo stremo. Infine ci fu un ultimo trasferimento a Ebensee, in condizioni ancora peggiori, ma proprio in quel luogo avvenne finalmente la liberazione, il sei maggio 1945 con l’arrivo degli Americani. In un loro campo militare, Shlomo, ammalatosi, fu sottoposto a delle visite accurate e gli fu diagnosticata la TBC, perciò il suo ritorno alla vita iniziò con altri lunghi patimenti.
Quando dal 1992 Shlomo Venezia iniziò a raccontare, a testimoniare, (tornò pure ad Auschiwitz per la prima volta), diventò consapevole di essere afflitto dalla “malattia dei sopravvissuti” ben diversa dalla TBC che l’aveva tormentato e da altre afflizioni del corpo :
“La nostra è una malattia che ci rode dal di dentro e che distrugge ogni sentimento di felicità. Ce l’ho dal tempo della sofferenza nel campo e non mi lascia mai un momento di felicità o di spensieratezza, è uno stato d’animo che logora le mie forze continuamente. […] tutto mi riporta al campo. Qualunque cosa faccia, qualunque cosa veda, il mio spirito torna sempre nello stesso posto, E’ come se il lavoro che ho dovuto fare laggiù non sia mai uscito dalla mia testa. Non si esce mai, per davvero dal crematorio”.
Per Shlomo Venezia testimoniare rappresentò sempre un enorme sacrificio, superato però dalla necessità di far conoscere al mondo intero una realtà che deve indurre a riflettere sull’importanza e sul valore della memoria e soprattutto combattere chi ancora stoltamente sostiene il negazionismo. Pertanto, l’istituzione del “Giorno della memoria”, al quale Venezia e altri reduci, (come Sami Modiano o Piero Terracina, Liliana Segre), hanno dato un importante contributo, non deve costituire una data convenzionale utilizzata solo per leggere qualche frase d’occasione o guardare frettolosamente abusate e logore immagini dei lager di un passato ritenuto lontano, giusto per alleggerire la coscienza. Oggi, più che mai, la memoria storica deve servire come monito a tutti, infondendo la consapevolezza dei misfatti e delle tragedie a cui possono condurre regimi totalitari esaltati da propaganda fasulla, forme di nazionalismo esasperato, che, arrogandosi un potere arbitrario o alimentando velleitarie pretese di appartenere a culture considerate egemoniche o a presunte razze superiori, hanno potuto e potrebbero progettare, in modo lucido, ponderato e razionale, l’eliminazione sistematica di milioni di persone in qualunque periodo storico, (non ultimo il presente), e in qualsivoglia luogo del mondo. E’ pertanto altamente educativo e formativo conoscere testimonianze come quella di Shlomo Venezia, che non sminuiscono di certo gli altri numerosi e terrificanti eccidi e genocidi accaduti nella storia, ma ne rappresentano uno di esemplare gravità che la società contemporanea, contaminata dall’intolleranza, dal razzismo e dall’odio dilaganti, ha il dovere di conoscere a fondo, perché ciò che è successo ad Auschwitz non si ripeta mai più da nessuna parte.
Graziella Enna
 Sonderkommando. Auschwitz
Sonderkommando. Auschwitz
Shoa
Rizzoli
2009
235