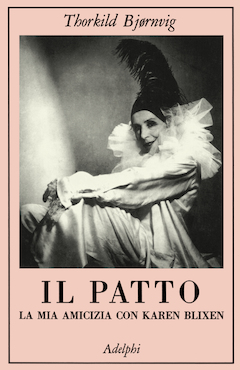Un ventaglio di donne: la Pellegrina Leoni di Karen Blixen
Nella Nascita della tragedia Nietzsche scriveva che il poeta lirico (Archiloco in quel caso) è colui che si presta, si fa attraversare: una visione del “genio dell’universo, che esprime simbolicamente il dolore originale in quel simbolo che è l’uomo Archiloco”.
È necessario un sacrificio affinché quella voce possa manifestarsi, il sacrificio di sé che è, però, fedeltà alla propria vocazione, a quella chiamata che sussurra: sii nel tuo intimo che è mondo.
Sembra un paradosso eppure è quella grandeur che non si piega, che reclama attenzione e visibilità assoluta perché si consuma in fretta e fa della vita tragedia e splendore, grazia e disperazione sempre risorgente: un geyser spinto in alto da una potenza ipogea che anela al cielo, a quell’empireo gocciante che è giusta dimora dove rimanere come memoria di corpo che dilegua e ricasca, per un attimo, perché altri giungeranno, altri getti- l’acqua è la stessa? Non possiamo dirlo: l’acqua è il racconto che ci appartiene e ci parla ancora e sempre con la forza di un geyser che sbuffa, si scrolla il suolo di dosso e percorre l’aria, la percuote, la buca, ne fa ascensore.
Blixen è quel getto che descrive la parabola della storia infinita, la storia immortale, quel lampo bagnato che preme e, nell’attrito con l’aria, soffre, si sbuccia la pelle sottile, è solo pelle, è solo ideale di pelle, è tutto sentire, tutta nobiltà che lampeggia.
È Pellegrina Leoni, la grande cantante, superba e innamorata di quella gente che si spertica in applausi perché vede in lei, sente nel suo canto, quel paradiso possibile oltre gli affanni, oltre le miserie quotidiane; Pellegrina de I sognatori (la penultima delle Sette storie gotiche), colei che può vivere solo in voce e che, non potendo più usarla dopo il ferimento durante l’incendio del teatro d’opera a Milano, muore al suo nome, ma rinasce come ventaglio di donne, tutte quelle che riesce a contenere, ad attraversare: “Non voglio più essere una sola donna, d’ora in avanti; voglio essere tante donne. Mai più vorrò legare il mio cuore e la mia vita intera a una sola donna, per soffrire tanto. […] Marco, io sento -ne sono certa- che tutti a questo mondo dovrebbero essere più d’uno, e che allora tutti, sì, tutti avrebbero il cuore in pace. E riderebbero di più”.
Ben distante dall’attitudine ombelicale che sembra dominare gran parte della nostra narrativa odierna; e dunque un buon consiglio: riversarsi in altri vite, staccarsi dall’illusione di essere uno, uno solo, un “io” di cui divenire schiavo e prigioniero, quell’io che non è il genio dell’universo, è la sua visione, una delle possibili declinazioni, uno dei possibili geyser attraverso cui toccare il cielo comune, il grande catino delle storie, dei miti che non muoiono se raccontati ancora, se incarnati, come la Blixen sapeva: per questo raccoglieva inesausta la sfida delle esperienze, spendendo ogni respiro, fino al crollo.
Come quando ormai settantatreenne fu invitata a New York e non si fermò un attimo, ovunque richiesta e desiderosa lei stessa di non mancare agli appuntamenti, tutti.
La vediamo così: al Cosmopolitan Club dove aveva acconsentito a narrare un racconto alle signore del Club. E poi non si era fermata, aveva chiesto altro pubblico e, rimasta sola, aveva continuato a narrare. Nancy Wilson Ross, amica della famiglia Finch Hatton ricorda: “Non voleva che il momento magico finisse, per poi ritrovarsi improvvisamente sola, carica di forza creativa e senza nessuno che l’ascoltasse. Mi implorò di restare a cena con lei… me ne andai con la sgradevole sensazione di averla delusa”.
In quei giorni Clara Svendsen, la sua segretaria, la chiamava “Khamar,” un cavallo di battaglia arabo di una vecchia ballata danese. I purosangue corrono finché crollano, diceva la Blixen. “Khamar” fu infine riportato in Danimarca, contro la sua volontà, ormai in fin di vita.
Pellegrina, in punto di morte, deve però ritornare a sé, al suo nome; deve e può essere riconosciuta e raccontata perché di sé ha fatto sperpero ed è lecito quindi che torni nelle parole degli altri, e nei loro sogni.
“Tu non sai, Tembu”, disse a un tratto Mira, dopo un silenzio ” che se nel piantare una pianta di caffè si piega la radice, dopo un po’ di tempo l’alberello comincia a gettare quasi alla superficie del terreno una miriade di piccole radici delicate. Una pianta simile non sarà mai rigogliosa e non darà frutti, ma fiorirà più doviziosamente delle altre. Quelle piccole radici sono i sogni della pianta: mettendole fuori, non sente più il bisogno di pensare alla radice grande. Esse la tengono in vita, non troppo a lungo, ma solo un poco. Oppure, se più vi piace, potete dire che la fanno morire. Perché in realtà sognare è la maniera con cui le persone bennate si tolgono la vita”.
Rossella Pretto