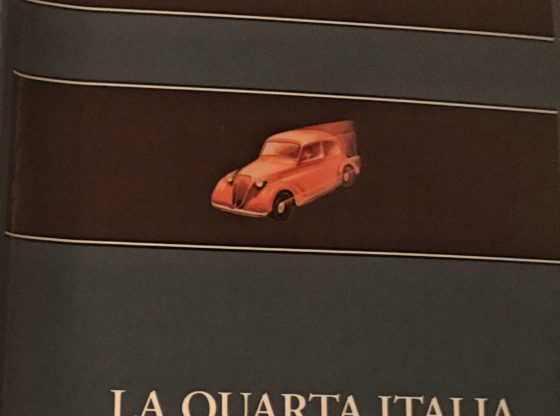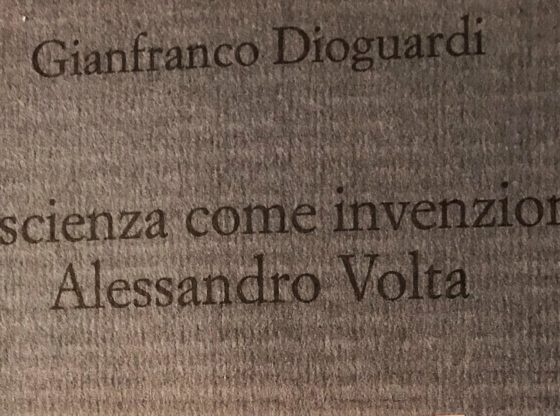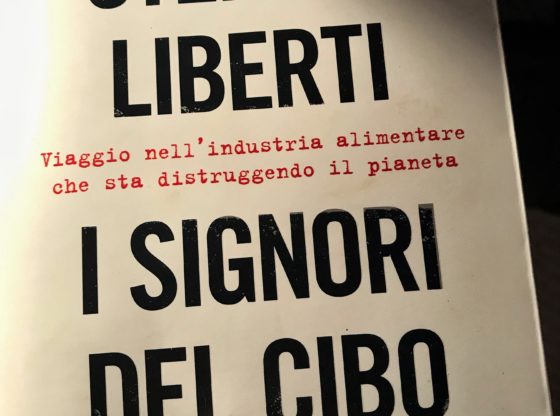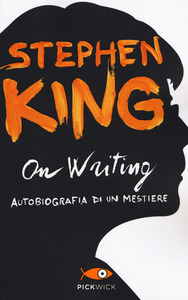Laura Pugno, In territorio selvaggio. Corpo, romanzo, comunità, Nottetempo, Milano 2018
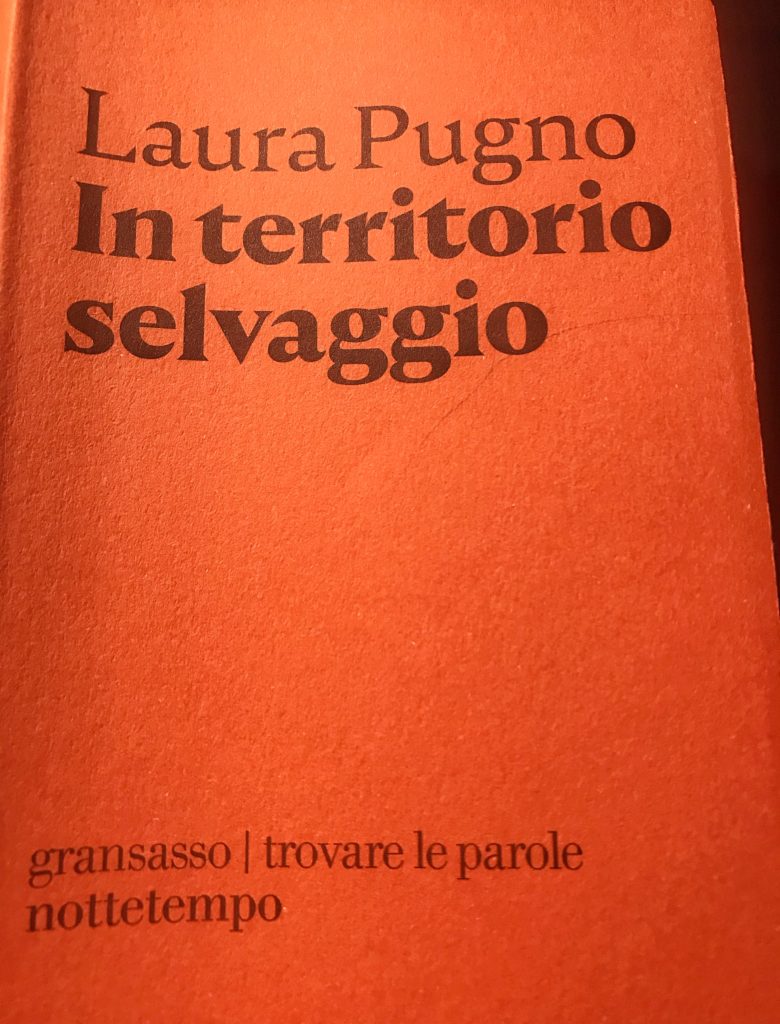
Non è affatto semplice anche solo inquadrare questo libro di Laura Pugno (clicca su Laura Pugno per guardare il suo sito) senza rischiare la protervia esegetica del recensore pure ben intenzionato. Facile incorrere nelle trivialità degli eccessi interpretativi tipici della critica verbosa che pretende di subissare di parole a vuoto, il vuoto significativo invece, il silenzio deciso, il non detto esplicito di chi scrive poesia, visto che, come ricorda la stessa Pugno: “(…) la poesia è un’esplorazione alle frontiere della lingua, per dire ciò che non è stato detto prima e forse non è del tutto dicibile (…)”.Le indicazioni di lettura di In territorio selvaggio, sono comunque fin da subito esplicitate dalla intenzione di fondo della collana editoriale di Nottetempo in cui il libro si presenta in un’affabile veste grafica che è intitolata gransasso|trovare le parole da cui leggiamo: “Per tante cose non abbiamo le parole. Per certe altre ne abbiamo troppe e non sappiamo quali scegliere. Trovare le parole ha chiesto agli autori di farlo per noi, rinunciando al velo della finzione e facendosi avanti senza maschere (…) se non smetteremo di cercarle, saranno le parole a trovare noi.” Ecco che abbiamo forse qualche indizio in più dove le intenzioni dell’editore si fanno conforto per l’autrice e relazione con la comunità dei lettori. Intenzioni, conforto, relazioni, comunità, sono questi i termini chiave nel bosco (o labirinto? o deserto? giardino?) del libro assieme ad altre parole-mondo quali: corpo, mente, tempo, romanzo, felicità e ovviamente l’umano e il selvaggio. Cominciamo subito col dire che, per ammissione della stessa Pugno, In territorio selvaggio è un quaderno d’appunti; un diario intimo schiuso all’osservatore esterno che “modifica l’oggetto osservato già col solo gesto di osservare”. Parole private dette in pubblico, per riprendere con l’autrice il titolo di un libro di Giulio Mozzi, è la traccia madre su cui sono imbastite le riflessioni a strati concentrici in questo centinaio di pagine che leggiamo a polmoni dilatati per ossigenarci il cervello. Cosa si sta dunque cercando – perché qualcosa si sta pur cercando – attraverso le parole in prosa frammentata del libro di cui parliamo? Se la poesia, come ben detto prima dalla scrittrice che è poetessa (“poeta” nella nota biobibliografica in quarta di copertina), concerne l’esplorazione degli abissi dell’indicibile, la prosa, a seguire sempre alla lettera l’autrice “(…) è il momento in cui il bottino di queste esplorazioni viene riportato alla comunità. Spartito, condiviso.” Allora la scrittura oltre ad essere di conforto per chi la pratica e per chi la legge, può divenire anche fonte di conoscenza. Condivisione e spartizione di un bottino prezioso per la comunità. Un bottino che è conoscenza non consolatoria. Esperienza vissuta dell’oltre, dell’altro da sé, cioè letteratura come urgenza primaria. Straniamento. Afflato animalesco perturbante. “Occhi nuovi”, conoscenza selvaggia appunto “che avviene attraverso il perdersi, e poi ritrovare, trasformati, la strada” Non si smette mai di creare il nuovo, il nuovo ricrea perennemente se stesso anche nostro malgrado, ragione per cui la scrittrice afferma di trovare irritanti le trite lagne – non sono infatti una novità – sulla morte dell’arte, sulla fine della storia e della letteratura. Quel frammento in cui il romanzo – il romanzo sempre necessariamente borghese? – viene definito come “opera di una società che vive nelle case, che trascorre la propria vita – i giorni; le notti – nello stesso luogo” a differenza della poesia che è più “portatile”, la quale può essere “incisa su un sasso, nascosta in un bosco”, mi ha riportato alla mente quella figura mitologica della cultura italiana che è stato Emilio Villa. Poeta, biblista, raffinato traduttore di lingue morte, tanto immenso quanto ignorato scrittore e critico cui tutta l’arte del ‘900 italiano e non solo deve tutto. Sembra infatti, così narra la leggenda che lo riguarda, che Villa scrivesse versi sui sassi e poi li gettasse nel Tevere. Il Tevere, fiume selvaggio, confine sconfinato a recidere in due la selva urbana infinita dal bosco altrettanto inquieto della provincia in un gioco interminabile di scambi umorali, flussi, eterni ritorni di cose, relazioni, genti, nella gran confusione di sentimenti imprecisi (In the general mess of imprecision of feeling), per riprendere un verso esatto come un orologio di precisione svizzero di T. S. Eliot. Dai Quattro Quartetti per l’esattezza, nella traduzione Garzanti di Filippo Donini, proposto a ragione dall’autrice quasi a metà di questa sua lancinante meditazione sul corpo, il romanzo e la comunità. “Scrivendo, i miei personaggi non mi sono mai sembrati solitari o isolati, solo pronti a spingersi alle estreme conseguenze di se stessi.” Sotto traccia, mai troppo esplicite ma insinuate come sottilissima filigrana che impreziosisce l’originalità malinconica di In territorio selvaggio, s’intraleggono le enormi questioni apocalittiche dei nostri mala tempora currunt: avvelenamento ecologico, devastazione ambientale, surriscaldamento del pianeta, flussi migratori. “Il mondo non può essere ridotto alla tua casa”. Lo smarrirsi nel bosco per conoscersi. “La neve radioattiva” e altre questioni-mondo che poi determinano o sono determinate dallo spirito dei tempi, ovvero da un onnipresente, avventuroso alone di zeitgeist involontario che adombra tanto sulla realtà quanto sul romanzo quale “strumento per porre domande”, motivo per cui “ogni romanzo è romanzo d’avventure”. Lo spirito boschivo dei tempi, non per forza di cose è stato preordinato a giardino dalla stessa autrice, ossigena e pervade come un cielo l’atmosfera di solitudine, una “materia fisica”, nella quale annaspano i personaggi dei suoi romanzi su cui si sofferma per alcune pagine a radiografarne il senso: Quando verrai, Antartide (entrambi Minimum Fax), La caccia (Ponte alle Grazie), Sirene, La ragazza selvaggia, La metà di bosco (tutti e tre Marsilio). Considerazioni finali andrebbero fatte sui confini labili tra la letteratura di consumo e quella d’autore, rilevando che “merce e non-merce” si mescolano ambiguamente senza soluzione di continuità. Mi assumo il rischio di semplificare un po’ troppo ma, In territorio selvaggio, riluce infine come l’accorata autoanalisi in pubblico di una poetessa che contempla filosoficamente intorno e in fondo all’urgenza ultima dello scrivere romanzi e del fare prosa, al di fuori o dentro a una comunità di lettori per i quali la domanda mai taciuta sulla felicità meritava una risposta in positivo piuttosto articolata che Laura Pugno, romanziere e poeta, ha tentato di argomentare con schietta onestà intellettuale per tutte le 119 pagine di questo piccolo grande libro.“La necessità di essere felici in letteratura, è direttamente proporzionale all’incapacità di credersi capaci di costruire la felicità nella realtà?”
Gae Saccoccio

Questa sera Laura Pugno sarà ospite alla Rimessa Roscioli a Roma in Via del Conservatorio 58, per la serata A cena con l’autrice. Per informazioni consultare la pagina facebook di Rimessa Roscioli dedicata all’evento (clicca su evento)

 In territorio selvaggio
In territorio selvaggio
Poesia, prose, riflessioni
Nottetempo
2018
119