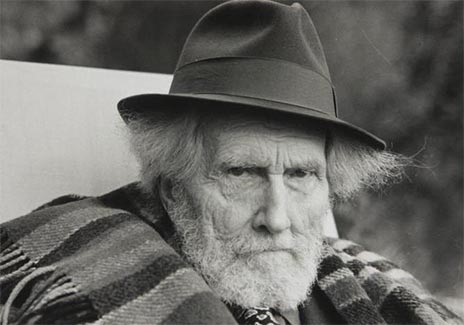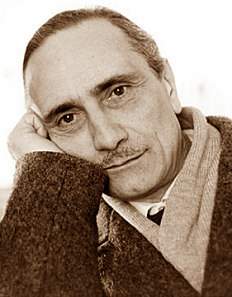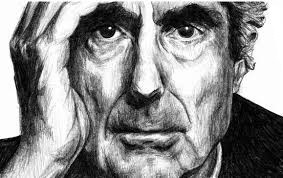Rassegna letteraria del ‘900
Di Brunella Sacchetti
Franz Kafka e altri mondi kafkiani

Kafka ritratto da Andy Warhol
E’ necessario superare “l’impressione che, qualsiasi parola si dica su Kafka, sia sbagliata” per potersi permettere di scrivere sul grande praghese; le parole virgolettate sono di Roberto Calasso e denunciano l’estrema difficoltà di chi, come Calasso, narratore, saggista, editore, sa quello che dice e conosce gli angoli più profondi della letteratura contemporanea e non. Ma Kafka ha subito traversie critico-interpretative notevoli: è stato passato al vaglio delle più insistenti forme di approcci psicanalitici e, al contempo, delle più insofferenti forme di analisi marxista, è stato circoscritto nel bozzolo dell’intellettuale ebreo di lingua tedesca e ceca, dell’artista mitteleuropeo che scandaglia abissi spiraleggianti di tutte le coscienze infelici che si concentrano in quello spazio geo-culturale complesso, privo di delimitazioni e vere connotazioni; è stato insignito dei meriti riferibili agli intellettuali epigoni dell’impero asburgico e, al contempo, dei meriti riferibili alle più inquietanti anticipazioni profetiche dell’olocausto. Muore di tubercolosi come un ultimo romantico ed era, invece, un moderno rappresentante della burocrazia assicurativo-amministrativa che si occupava prosaicamente di infortuni sul lavoro; caratterizzato da sofferte ed insoddisfatte pulsioni erotiche era, al contempo, pressoché incapace di vivere, in forma compiuta, storie forti e lunghe con le donne da lui amate: era “tanto”, sicuramente “troppo” per essere facilmente definito sul piano critico-concettuale. La difficoltà oggettiva delle sue opere, che pur lo rendono un vertice della letteratura contemporanea, la percezione di un universo di cose e pensieri che si stabilizzeranno negli scritti letterari non prima di mezzo secolo dopo la sua morte, il carattere plurilinguistico e interculturale della sua formazione, l’appartenenza ad un mondo che pochi anni dopo subirà una devastazione storica unica (le tre sorelle di Franz sono state tutte vittime della Shoah), il suo appartenere ad una generazione che è già in conflitto con quella dei padri, come un antesignano della beat generation, ne fanno un unicum nella Storia letteraria del ‘900.
Per l’inquietudine ricorda Leopardi e Tasso, per la complessità meandrica del discorso rinvia a Dante ed Ariosto, per il senso di solitudine ed aegritudo ci riporta a Petrarca, per la forza dell’ironia rappresentativa ricorda Rabelais, Cervantes, Montaigne, per lo sforzo ontologico rinvia a Goethe…Anche il cinema ha tentato di riprodurne la sfuggente personalità umana ed artistica, con “Delitti e segreti” (il titolo originale era” Kafka”), del 1991, per la regia di Steven Soderbergh, con Jeremy Irons nel ruolo di Kafka, ma già 30 anni prima il grande Orson Wells aveva girato un film su “Il Processo”, con Anthony Perkins. D’altra parte, tutti sappiamo che quando da un nome scaturisce un aggettivo, abbiamo di fronte uno dei protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia: “kafkiano” viene, infatti, utilizzato come attributo di sostantivi quali “situazione, personalità, burocrazia, paura, metamorfosi, incubo…”e definisce una circostanza caratterizzata da inquietudini ed incertezze, vertigini logiche e slittamenti cognitivi; di fatto “kafkiano” è l’attributo che meglio si attaglia al nostro vivere collocato ai confini dell’indefinito e nel limbo delle nostre incomprensioni. Insomma, il nostro mondo!
Tutto questo ha pesato, e pesa, sulla personalità e sull’arte di Kafka che, fragile ed indifeso, sopporta da quasi un secolo una carica di epiteti e giudizi con cui il lettore medio contemporaneo si sbarazza delle stolidità critiche più comuni, riversandole su di uno scrittore che non si è sforzato in nessun modo di definirsi e che avrebbe voluto che i suoi scritti scomparissero dopo la sua morte.
Kafka e il rock gotico dei Cure
“Sprofondato nella notte. Essere sprofondato nella notte come talvolta si abbassa la testa per riflettere. Gli uomini intorno dormono. Una piccola commedia, un’ innocente illusione che dormano nelle case, nei letti solidi, sotto un tetto solido, stesi o rannicchiati su materassi entro lenzuola, sotto coperte; in realtà si sono trovati insieme, come a suo tempo e come più tardi in una regione deserta, accampati all’aperto, un numero incalcolabile d’uomini un esercito, un popolo sulla terra fredda, sotto un cielo freddo, coricati dove prima erano in piedi, la fronte contro il braccio, il viso contro il suolo, col respiro calmo. E tu sei sveglio, sei uno dei custodi, trovi il prossimo agitando il legno acceso nel mucchio di stipe accanto a te. Perché vegli? Uno deve vegliare, dicono. Uno deve essere presente.”
E’ il racconto più breve di Kafka; circa 130 parole, in lingua tedesca meno; però la dimensione narrativa c’è tutta: un gruppo di uomini, numerosissimo ( “incalcolabile”, dice Kafka), accampati all’aperto, in una regione deserta dorme faccia in giù, il volto contro un braccio, e forse si illude di dormire in un letto, con lenzuola e coperte; invece è lì, sulla terra nuda, dove prima era all’impiedi; c’è poi un guardiano, un custode che deve vegliare e controllare…Ricordano gli immortali di Borges o alcune tipologie di dannati danteschi.
Quella che oggi si chiamerebbe una short story è uno dei racconti kafkiani più seri e importanti, che non può, però, non essere avvertita come una profezia dell’internamento nei lager: corpi accatastati e confusi, senza distinzione nè individualità di sorta; un carnaio dove il sonno somiglia alla morte e la morte alla negazione di ogni forma possibile di esistenza: nei lager non era sufficiente, infatti, morire, occorreva restituire ad un’autorità (una qualsiasi autorità, purchè indifferente più ancora che crudele) l’accesso alla vita come occasione di definizione dell’individuo quale essere unico ed irripetibile; nei lager veniva oscurata quella scheggia di luce che si accende alla nascita e che nell’universo culturale ebraico era, per altro, tutt’uno con una forma di estrema specificità culturale e di definizione etnica, linguistica, religiosa; i lager erano innanzitutto la negazione di questa identità e la negazione si esprimeva ammassando i corpi, traducendoli in numeri e destinandoli a forme di eliminazione di massa.
Un racconto così basterebbe a rendere la forza letteraria di Kafka, ma sicuramente, per chi ama il rock e le sue articolazioni anni ’80, il fatto che un genio come Robert Smith dei “Cure” abbia sentito la necessità di tradurre la story kafkiana in un brano dark, o meglio goth, costituisce un altro motivo per proporlo ai lettori odierni; d’altra parte Robert Smith lesse e tradusse musicalmente Camus ( la famigerata “Killing an arab”…), Baudelaire, Cristina Rossetti, in genere la poesia tardo ottocentesca e decadente, cercandovi i tratti “noir” che si avvertono nella cover dell’album “Seventeen secrets” del 1980, di cui fa parte “At nigth”( Clicca su ASCOLTO ), esplicitamente ispirato al brevissimo racconto di Kafka. Dall’album fu estrapolato un unico singolo, “A forest”, uno dei brani più noti dei “Cure”, divenuto poi un vero classico dark; la copertina sembrerebbe proprio far riferimento al testo di “A forest”, dove l’autore racconta di un inseguimento in un bosco dai margini imprecisi e incantati, tuttavia credo che sia proprio “At nigth” a costituire il brano che caratterizza il mood dell’album; si legga il testo in italiano.

“Nella profondità della notte/Affondo nella notte/Rimanendo solo/Sotto il cielo/Sento il freddo del ghiaccio/Sul mio viso/Guardo le ore passare/Le ore passare/Tu dormi/Dormi in un letto sicuro/Accoccolata e protetta/Protetta dagli sguardi/Sotto un tetto sicuro/Nel cuore di casa tua/Inconsapevole dei cambiamenti di notte/Di notte/Sento l’oscurità respirare/Un senso di quieta disperazione/Ascolto il silenzio della notte/Ci deve essere qualcuno/Ci deve essere qualcuno/Qualcuno deve essere lì”.
E si pensi che, per una strana “coincidenza“, la band, durante la registrazione dell’album fu costretta a dormire sul pavimento della sala di registrazione a causa della mancanza di fondi; di fatto ciò che si avverte in “At nigth” è un senso di oppressione e di angoscioso abbandono: la notte è uno “spazio”che contiene senza proteggere, il contrario di una casa, e la promiscuità dei corpi rimarca la condizione di alienazione, estraneità, paura.
Non è certo difficile, in questa situazione, immaginare di essere responsabili di qualcosa di terribile, e di doversi aspettare un castigo, una pena, o, almeno di dover subire un’accusa, benché imprecisata e non circostanziata.
Il Processo a Josef K., a K. e a Gregor Samsa
«La
Dama di Cuori con tutti gli onori
Dei dolci imbandì;
Il Fante di Cuori con altri signori
Quei dolci rapì.»
E’ questa l’imputazione al Fante di cuori nel processo a lui intentato e raccontato negli ultimi capitoli di “Alice nel paese delle meraviglie”; l’accusa viene letta da Bianco Coniglio, sotto gli occhi stupiti di Alice e alla presenza del Re e della Regina, mentre da un lato fanno bella mostra di sé le torte e le crostate cucinate dalla Regina, quelle che avrebbero indotto il Fante a rubare; Carroll chiude così il suo famoso romanzo con una delle più dissacranti rappresentazioni di processi che la letteratura abbia mai realizzato. A tal proposito occorre tener presente che il “processo” è un vero e proprio archetipo letterario: è, per cominciare, rappresentato in uno dei riquadri dello scudo di Achille, dove quell’immagine di un processo rappresenta la polis greca, che ebbe nella normativa legislativa e giudiziaria un preciso fattore costitutivo; il processo è, poi, il piano narrativo su cui poggia la vicenda dell’Antigone di Sofocle; è il tema di fondo della canzone dantesca “Tre donne intorno al cor mi son venute”; costituisce la chiusura esplosiva dello scontro tra Antonio e Shylock ne “Il mercante di Venezia” di Shakespeare; è uno snodo narrativo fondamentale dei romanzi di Victor Hugo, Dickens, Dostojeski… un processo, d’altra parte, promuove quel senso di scoramento e impotenza che è proprio de “Lo straniero” di Camus; è, inoltre, ovviamente, il nucleo centrale di tutta la letteratura poliziesca: di fatto la concreta messa in atto del diritto nella sua forma di procedura giudiziaria accompagna la narrazione del nostro evolverci o comunque del nostro modificarci, quasi che le riflessioni umane non possano trovare una collocazione migliore di quella che la Legge e la Giustizia nel corso dei secoli ha avuto in serbo per noi.
Non ci stupisce, dunque, che Kafka abbia dato vita ad un romanzo su questo tema; iniziò a scriverlo intorno al 1914 e, pur nella sua incompiutezza, il romanzo ebbe un vero “finale”, con la condanna a morte di Josef K.; fu pubblicato postumo, ma gli anni in cui l’opera venne alla luce, nelle forme contorte di un intreccio ben poco lineare; erano gli stessi anni de “La Metamorfosi” e, al contempo, sembra che Kafka stesse già sviluppando lo schema narrativo de “Il Castello”: le opere più famose, e significative, stavano, cioè, delineandosi da un unico alveo di ispirazione.
A volerle leggere secondo una sincronia concettuale, il racconto de “La Metamorfosi”, e i due romanzi principali, rappresentano la condizione umana come appariva al giovane Franz: sulla base di un Potere lontano quanto inattaccabile, rappresentato dal Castello, estraneo alla quotidianità dell’esistenza umana su cui pur tuttavia estende senza limiti la sua volontà, sotto l’egida, cioè, di un controllo silente, ma vigile ed indefesso, gli individui conducono una vita costante e monotona nelle dinamiche comuni, che di fatto si ripetono salvo scontrarsi improvvisamente con eventi inattesi e drammatici, per lo più inspiegabili; è da leggersi così l’arresto di Josef K., che, non diversamente da Gregor Samsa, si alza un mattino e scopre che la sua vita di stimato funzionario di banca, ha subito un contraccolpo: un uomo entra nella sua camera al posto della donna che gli portava normalmente la colazione e la sua richiesta relativa proprio alla colazione produce una risatina, negli uomini venuti ad arrestarlo, che preoccupa Josef; da questo momento nulla sarà mai più come prima e, tra ansie e speranze di risistemazione di ogni cosa, tra un’apparente normale conduzione del lavoro e delle relazioni sociali, si avvia il processo che si concluderà, come abbiamo già detto, con l’esecuzione di Josef, senza che l’imputato abbia saputo, né capito, di cosa fosse accusato: di fatto la prima pena inflitta alla vittima consiste proprio nell’essere tenuto all’oscuro della sua colpa. La colpa si delinea, così, come qualcosa di indefinito e minaccioso, lontana da ogni ipotesi e illazione, sfumata, sfocata, slabbrata, priva di agganci con la logica comune; una colpa scompaginata da congetture, che non può non scavare anfratti nella coscienza di un individuo che cerca il senso di accuse vuote, ma sconvolgenti; e tali anfratti diventano un buco nero dell’identità, perché l’identità è necessariamente un tessuto coeso, dove non possono esserci lacerazioni come può essere quella prodotta da un senso di colpa reso inattaccabile dalla mancanza di piena consapevolezza del male prodotto: il non sapere accentua la vergogna ed impedisce un pentimento catartico: Josef K., che ovviamente è lo stesso Franz Kafka, mentre viene pugnalato al cuore da due uomini, con “un coltellaccio lungo, sottile, a due tagli” , riesce solo a pensare che “la vergogna gli sopravvivrà” e a dire “come un cane”, riferendosi ad un esecuzione che somiglia ad un assassinio, perpetrato in una cava, con la vittima accoccolata vicino ad un masso, senza nessuna forma di istituzionale e anodina ritualità.
Nell’altro romanzo, ”Il Castello”, il silenzio del Potere sembra confermare che il “non detto” costituisca una delle irrinunciabili caratterizzazioni dell’autorità: il silenzio garantisce l’assenza di discussione e dialettica, impedisce ogni polemica, respinge inutili sforzi democratici; d’altra parte un “castello” è una fortezza, chiusa, inattaccabile ai più.
Topocosmo della forza tirannica,il castello ha attraversato fiabe e poemi epici, ha avuto caratteri magico-esoterici e labirintici in Ariosto, in Manzoni…, il castello sembra essere stato sempre lo stesso edificio dove si perpetrano rapimenti e omicidi, feste spettacolari e mostruose depravazioni; ha ospitato giganti, principi e vampiri, si è slanciato al cielo o ha preso la forma di una corona imperiale federiciana su colline indifese, tutto questo prima di approdare tra le pagine di Kafka. Qui un personaggio, un agrimensore, anche lui denominato semplicemente K., cerca di capire che compiti gli verranno affidate delle autorità del castell. Senza riuscire mai ad addentrarsi nella rocca, K. farà parte, però, di quella comunità, diventando bidello della scuola locale e amante di Freida, che pare avesse contatti con i potenti del castello, mentre aspetta di poter svolgere le sue vere mansioni, che gli verranno affidate solo mentre sta per morire.
Che nel Castello avesse sede quell’Alta Corte a cui Josef K. non era riuscito ad arrivare per avere un vero Processo? Che le torri del castello custodissero tra le pratiche amministrative il segreto dell’arresto di Josef? Ciò che è certo che Josef e K. muoiono a conclusione di intrecci, al contempo inquietanti e banali, certamente non districabili dal lettore: le opere di Kafka non possono essere districate dal lettore, non si tratta di thriller né di opere, per quanto eccezionali, alla Edgar Allan Poe, non particolarmente amate da Kafka; se un lettore attento vuole entrarvi, come in un bosco narrativo, secondo il codice di Eco, deve farlo senza velleità ricompositive logiche e calarsi nell’incubo.
In una situazione emozionale simile, caratterizzata dalla “non comprensione” dei fatti, l’autore e il lettore guardano la loro vita defluire in forme assenti e destrutturate, dove non conta ciò che sono nel lavoro, con le donne e con gli amici: quell’opera è un gomitolo che si scioglie e si ingarbuglia, fino a dar vita ad ammassi che diventano corporei, simili ai “dormienti” del racconto “Di notte”. Quegli uomini pensavano di avere un tetto sopra le loro teste, invece sono al buio e al gelo, non ci sono lanterne pirandelliane, nè maschere da indossare per farsi riconoscere, e la morte è una soluzione pressoché auspicabile perché pone termine ad angosciosi ed irrisolvibili interrogativi .
La sostanza edipica degli enigmi è indiscutibile, ma nel mito sofocleo l’eroe trova la colpa e la traduce nella pena dell’ accecamento per punire l’organo che non ha saputo “vedere”. K. non sa, e forse la sua colpa è di là da venire, deve ancora essere commessa, forse sarà commessa da altri, ma di essa condividerà la responsabilità. Intanto la coesione identitaria ha ceduto e K. si ritrova come un essere vivente indefinibile: informe, filo disordinato di una vita incompiuta, un essere destinato alla mutazione e destinato a cercare di sopravvivere in luoghi inidonei, dove non mancano castelli a forma di padri giganteschi e golemici, atti a svolgere funzioni terrorifiche e a rappresentare autorità distanti e minacciose. Nel caso di Gregor Samsa il coltello appuntito che uccise Josef diviene una banale mela; basta una mela, forse imparentata a quella dell’Eden, a far fuori l’ultima espressione di vita che K. prende, quella dell’insetto che illegittimamente ha sostituito il “figlio”, dell’insetto che pretende di sopravvivere in una famiglia sgomenta e respingente. Che cosa ha reso Gregor un insetto? Lo si saprebbe se conoscessimo quella famosa colpa di Josef ; neanche al Castello conoscono la natura del “peccato originale”; di fatto una colpa se ha un nome può essere espiata e parte fondamentale delle pene kafkiane è l’impossibilità alla piena espiazione.
Per citare di nuovo i “Cure” cosa rende il protagonista di “Lullaby” (da “Dintegration”, 1989) fragile ed esposto al mostro che sta per divorarlo se non il suo essere colpevole di qualcosa: la “ninnananna di morte”, resa da soavi arpeggi di ispirazione più psichedelica che dark, riproduce ancora una volta un incubo kafkiano di pseudo-espiazione:
“ Su delle zampe a righe bianche e rosa arriva l uomo ragno/leggero attraverso l’ombra del cielo serale/muovendosi furtivamente attraverso le finestre della morte beata/cercando la vittima tremante nel letto/cercando la paura nell’oscurità/e improvvisamente un movimento nell’angolo della stanza/e non c’è nulla che posso fare quando realizzo con orrore/che l’uomo ragno sta avendo me per cena sta notte”.
Sarebbe, perciò, legittimo chiedersi cosa accomuna un artista nato nell’800, inserito nei movimenti mitteleuropei del decadentismo e delle sue propaggini di avanguardia, quali il surrealismo e il modernismo, con musicisti degli ultimi decenni del ‘900.
Che cosa fa di Kafka lo scrittore che ancora ci rappresenta?
Conoscenza e morte: la dark generation del decadentismo
Uno dei periodi felici di Kafka fu quello passato a casa della sorella Ottla nella campagna boema, a Zϋrau, dove scrisse “Gli aforismi di Zϋrau”, 109 pensieri, mini-racconti, brevi memorie, su foglietti volanti che l’amico di una vita, Max Brod, provvide a pubblicare dopo la morte di Franz e che oggi sono pubblicati da Adelphi, con un prezioso saggio di Roberto Calasso; questo, riportato di seguito non è che uno dei tanti interessanti aforismi che , letti attentamente, potrebbero darci grandi certezze nella comprensione dell’opera di Kafka.
[Aforisma 13]
«Un primo segno di incipiente conoscenza è il desiderio di morire. Questa vita appare insopportabile, un’altra irraggiungibile. Non ci si vergogna più di voler morire; si chiede di essere portati dalla vecchia cella, che si odia, in una nuova, che presto si imparerà ad odiare. Un residuo di fede continua a operare, forse per caso durante il trasferimento potrebbe passare il Signore per il corridoio, guardare il prigioniero e dire: “Questo qui non dovete rinchiuderlo più. Viene da me”»
Come dice Roberto Calasso nella prefazione del libro citato, Kafka aveva dentro di sé giacimenti carboniferi da cui ricavava dei purissimi diamanti. Partiva sempre da una base rovente di infelicità esistenziale e ne ricavava una visione non egotica, anzi universale; il senso della morte era, ovviamente, cosmico e rientrava nella morte ontologica del pensiero occidentale che la cultura mitteleuropea aveva percepito con largo anticipo, promuovendone formulazioni quali quelle di Thomas Mann, Robert Musil e del nostro Italo Svevo…
La colpa di Gregor Samsa, di Josef K. e di K. del “Castello” era, forse, dunque, l’incipiente conoscenza, l’attingere proditoriamente all’albero della sapienza, con l’immediato effetto di volerne morire: di fronte alla vita , desiderare di morire è da bastardi e la colpa è innanzitutto nei confronti dei padri che ci generarono: quella vita che ci avevano offerto con sicumera velleitaria, ma tante altre volte con disperato affetto, si mostrava allo sguardo dell’uomo “conoscitivo” come una vera sciagura e Franz-Gregor sente di essere un mutante nei confronti del padre e non basta la tenera pietà che la sorella a volte gli manifesta, Franz sa di essere solo in quella casa e che la sua paura del Padre è legittimata dalle sue colpe in relazione a ciò che il padre gli aveva donato, la vita stessa con i suoi postulati sul mondo e sul resto degli uomini.
Di fatto la vita si presentava agli occhi di Kafka come la notte della short story citata, nella quale tutti dormono senza un rifugio e la terra su cui sono distesi è gelida e dura; e da una notte così ci si risveglia portandosi addosso l’incubo di un’ “indefinibile” imputazione e il senso di un’incredibile mutazione.
E la mutazione lo riguardava da vicino: incapace di accomodamenti, la realtà civile e politica gli appariva minata dall’assenza di un Dio, ebraico o cristiano che sia, a cui gli uomini hanno sostituito la Legge, astratta e lontana , con cui interagire è già un reato ( anche un “peccato”); sembrano sopravvivere bene gli uomini sicuri di sé, incapaci, come vorrebbe Montale di percepire la loro ombra; ma anche a questi ultimi toccano attimi di assurda consapevolezza che sfalda la sicumera, o tocca di non riuscire a trasmettere ai figli quelle certezze su cui avevano costruito la loro vita; ne deriva il senso di un impasse doloroso che riesce a frenare il senso della futuribilità. Intanto qualcuno sta affilando un coltello a due lame, mentre Kafka, il Kafka assicuratore del lavoro, da tempo aveva capito cosa sarebbe stata “L’Amerika” in relazione al sistema lavorativo, mentre l’Artista dalle capacità profetiche era riuscito, non sappiamo come, ad intravvedere, ahimè!, gli orrori della Shoah.
Ebbene Kafka ha “vissuto”, dunque, tutto il ‘900, pur essendo scomparso nel1924; l’ha vissuto e subito compreso e si è trattato di un vero incubo: quel secolo avrebbe attestato senza ombra di dubbio che la scarnificazione del Logos avrebbe invaso tutti gli ambiti dell’esistenza, coinvolgendo i Poteri tutti insieme agli individui più innocenti, ma soprattutto avrebbe rivelato senza ombra di dubbio che la vera ossatura logica era da sempre la dimensione etica: la dispersione cognitiva segnava la fine della ricerca del bene.
“Il male conosce il bene, ma il bene non conosce il male” ( Aforismi di Zurau)
È la sconfitta di Socrate, ma, d’altra parte anche il grande Filosofo aveva subito e sofferto un ingiusto processo.
Brunella Sacchetti