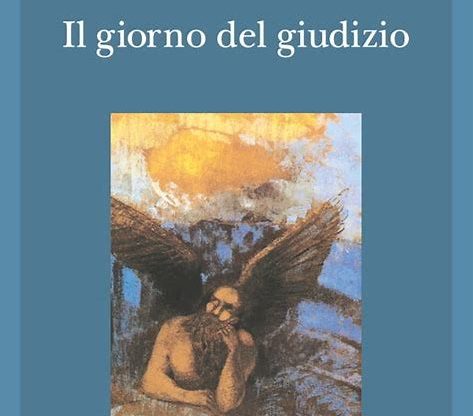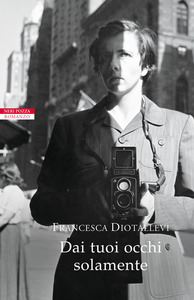Il Giorno del Giudizio di Salvatore Satta
Quarant’anni di solitudine
Di Carmine Maffei
Dopo l’amara esperienza di soldato impegnato nel Secondo Conflitto Mondiale, J. D. Salinger, già narratore, per lo più sconosciuto ma già attivissimo nel privato, capì che l’esperienza di guerra avrebbe cambiato le sorti del mondo intero, come sempre avviene, solo che stavolta c’era lui stesso coinvolto, e tale circostanza avrebbe significato uno stravolgere delle proprie aspettative, dove i sogni letterari avrebbero assunto il sapore della disfatta della società, e allo stesso tempo si sarebbero tinti nel tono acceso delle sue ambizioni.
Forse fu così che nacque Il Giovane Holden (dall’intraducibile titolo originale The Catcher in the Rye), e le sospirate fatiche furono premiate, soltanto che, come ci ricorda Freud, ci sarebbe una reale connessione tra l’avvenire del proprio successo e il successivo ammalarsi, quindi Salinger iniziò ad essere infastidito dal continuo riconoscimento altrui e percepiva l’attenzione dei suoi ammiratori come fiato sul collo, facendo presto ad intuire che l’esistenza sarebbe stata migliore se vissuta nel tanto sospirato isolamento che un tempo non sopportava, e che ora cercava di nuovo con disperazione.
Nel 1975, dopo un lungo periodo di buio, in seguito ad un’intervista (la successiva sarebbe arrivata moltissimi anni dopo) chiuse definitivamente i battenti in faccia ai suoi lettori e si rifugiò nella pace di una scrittura forsennata ma totalmente privata.
E fu in quello stesso anno, in Italia, a Roma, che si spegneva Salvatore Satta.
Satta era e sarebbe stato ancora, dopo la sua morte, uno dei più importanti giuristi italiani del secolo scorso.
Di origini sarde (nato a Nuoro) aveva svolto con successo una carriera invidiabile, ma era innanzitutto dedito ad una serissima attenzione nei confronti della propria incolumità professionale.
Pubblicò alcuni tra i più fondamentali testi giuridici, utilizzati per lo più per integrare diritti processuali, oggetto di studi negli anni a venire.
Tuttavia quasi nessuno si accorse che nel profondo del suo imperscrutabile animo di studioso ci fosse un’indole da narratore, qualità che lui a tutti i costi lasciò nascosta, anche ai più cari, che non potevano intuire che tra il battere continuo a macchina del signor Satta si nascondesse, tra documenti e studi giuridici, un manoscritto di fondamentale importanza letteraria.
In uno dei primi capitoli si legge questo:
“Scrivo queste pagine che nessuno leggerà, perché spero di avere tanta lucidità da distruggerle prima della mia morte, nella loggetta della casa che mi sono costruito nei lunghi anni della mia laboriosa esistenza”.
Dedizione pura ai propri sacrifici professionali, dunque, e zero entusiasmo per un’ispirazione dalla finezza inarrivabile, seppur con una cupezza invalicabile.
Ciò di cui parliamo, Il Giorno del Giudizio, fu molto probabilmente scritto nel primo lustro degli anni Settanta, quando Salvatore Satta era un uomo anziano, malinconico, e propenso alle memorie di un tempo passato.
Il romanzo fu redatto quasi sicuramente fino al punto di morte, perché quest’ultima sorte umana, che come ci spiega il suo autore nella sopraccitata opera, insieme alla nascita segna la differenza tra finito ed infinito, è presente in tutte le pagine, come un’ombra che scurisce, incupisce i periodi vergati con maestrìa inarrivabile, eppure sottoposti ad una tensione spiegabile soltanto attraverso le condizioni psicofisiche di chi scriveva, affranto dal dolore di un’incombente perdita, quella della sua esistenza.
Nel suo “Letture”, il critico letterario francese George Steiner, nella sua stupenda descrizione del romanzo di Satta, scrive:
“il suo <<Deprofundis>>, memoria laconica e straziante del periodo bellico che Satta publlicò nel 1948, è pervaso di latinità e di quell’elevato dolore di cui è impregnata l’immagine tacitiana dell’insensatezza politica umana (…). Il Giorno del Giudizio è stato pubblicato solo nel 1979. E’ un libro postumo non solo perché è apparso dopo la morte di Satta, ma soprattutto perché per molti aspetti è un libro sui morti e per i morti. Un sardo, un nuorese può ammettere che un unico luogo è ricco: il cimitero”.
Il “Giorno del Giudizio” non fu distrutto, per fortuna, dal suo autore, né dai suoi eredi, ma fu riconosciuto come un’opera di fondamentale sensibilità che avrebbe dovuto trovare spazio nell’editoria, quindi vide la sua prima pubblicazione nel 1977, due anni dopo la morte di Satta, con la Cedam, casa editrice esperta nelle materie giuridiche e purtroppo senza alcuna capacità di esaltarne lo splendore letterario, compito che fu invece affidato, due anni più tardi, all’Adelphi.
Nel 1979, quarant’anni fa, l’inizio di un successo inaspettato seppur scontato, travolgente, entusiasmante di uno dei romanzi fondamentali della letteratura italiana, al pari de Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e de I Viceré De Roberto; tradotto in ben diciassette lingue, conferma l’importanza epica, oltre che storica, e oltre che visionaria, anche.
Steiner cita Tacito, ma l’eleganza cupa di Satta tocca punti che possono essere paragonati a Masters di Spoon River, al Foscolo de I sepolcri, a Joyce de I Morti, e ciò è in tutte le pagine, il cui punto di partenza si svolge proprio nel cimitero di Nuoro, dove Satta si trova (o si immagina) a camminare e dove man mano riconosce le tombe delle persone che ha incontrato in un passato lontano o di cui ha sentito parlare; di coloro che hanno in qualche modo fatto parte della sua vita di quando era ragazzo.
L’impareggiabile attrazione verso la morte come fonte di verità storica, di capacità di racchiudere una volta per tutte in un segmento di vita che ha un inizio e una fine decine e decine di personaggi che entrano ed escono dalla nostra lettura a proprio piacimento, fanno di questo romanzo una narrazione di un filo continuo, quasi tutto d’un fiato, con pochissimi dialoghi e tutto da raccontare.
Perché quello che leggiamo, che tocchiamo ogni volta si gira un’altra pagina è la ricerca della sensibilità di un autore che non si riconosceva come tale, e che quindi risplende nella sua chiarezza e nella sua spontaneità da diario, da testimonianza epocale, da circostanza terapeutica alla solitudine.
E per quanto sembra sia lontana tale solitudine nella miriade di protagonisti che si vanno a conoscere, perché ricchissimi di descrizioni minuziose, tale condizione morale, oltre che fisica, aggrega il senso di comunanza di una società racchiusa in un comprensorio di circa cinquemila anime (Nuoro tra fine Ottocento e inizio Novecento) con al centro la figura di Don Sebastiano Sanna Carboni, notaio della città, simbolo dell’aristocrazia e della padronanza, la moglie/vittima Vincenza, testimonianza della sottomissione della donna ai voleri del patriarcato, e poi ancora il clero, i poveri, i quartieri alti, quelli diroccati dei contadini, il caffè Tettamanzi, la Farmacia, le chiese, le ambiguità socialiste in politica, la Prima Guerra Mondiale e la successiva partenza dei figli, tutto nelle singole storie chiuse in ognuno, dove quell’ognuno resta chiuso a sua volta nella propria solitudine.
Satta scrive in maniera quasi forsennata, eppure non abbandona mai l’eleganza, e se ci si discosta un attimo il libro dalla visuale e lo allontaniamo fino a che le singole lettere delle singole parole diventano delle ombra indefinite, ci accorgiamo che dinanzi a noi scorre un fiume d’inchiostro che non mostra singulti, che non offre pause rilassanti, che non si ferma quasi mai ad indugiare in punteggiature rilassanti, in conversazioni di scontata natura, che si sperano ma che non arrivano.
Eppure la lettura non è di difficile interpretazione, non mostra processi troppo impegnativi di ragionamenti cosmici, giuridici, scientifici, è tutt’altra forma di espressione facilitata di un racconto senza deformazioni o forzature professionali, ma con la spontaneità di quando non si ha paura del confronto.
“Come in un negativo che si sviluppa, volti remoti ricompaiano in questi che mi circondano: gente sparita dalla terra e dalla memoria, gente dissolta nel nulla, e che invece si ripete senza saperlo nelle generazioni, in una eternità della specie, di cui non si comprende se sia il trionfo della vita o il trionfo della morte”.
Molto spesso Satta soffre, e si sofferma e si concede dei sospiri, delle lacrime e degli interrogativi, su come si sia spinto così lontano nel prendere in mano la decisione ingiusta di rimettere in gioco quelle anime defunte, nella realtà immaginata di allora catapultata in quella di oggi, anziché lasciarli nel loro eterno riposo, distesi tra le uniche parentesi di un atto di nascita e uno di morte, e dove ciò che sta nel suo mezzo, oggi, non può interessare nessuno di passaggio.
Eppure Pasolini ci dice che i morti non è vero che non parlano, siamo soltanto noi che abbiamo dimenticato il modo di ascoltarli.
E il titolo del romanzo racchiude la semplice ma spiazzante filosofia di chi scrive, che si ritrova a interpellare ogni singolo defunto, al suo passaggio nel cimitero, come se lo richiamasse a nuova vita, giudicandolo nel bene e nel male, mettendolo a confronto con la propria epoca, oltre che con i propri simili e dissimili; lui, come un dio, con la missione di riordinarli in fila per il giorno del giudizio e liberarli in eterno dalla propria memoria.
Ed ora lasciamoci con le sue parole:
“La difficoltà che io ritrovo in questo ritorno al passato è quella di mantenere le prospettive. E si capisce perché: in ognuno di noi, anche se si limita a guardare in se stesso, si vede nella fissità di un ritratto, non nella successione dell’esistenza. La successione è una trasformazione continua, ed è impossibile cogliere e fermare gli attimi di questa trasformazione. Sotto questo profilo, si può dubitare del nostro stesso esistere, o la nostra realtà è solo nella morte. La storia è un museo delle cere”.
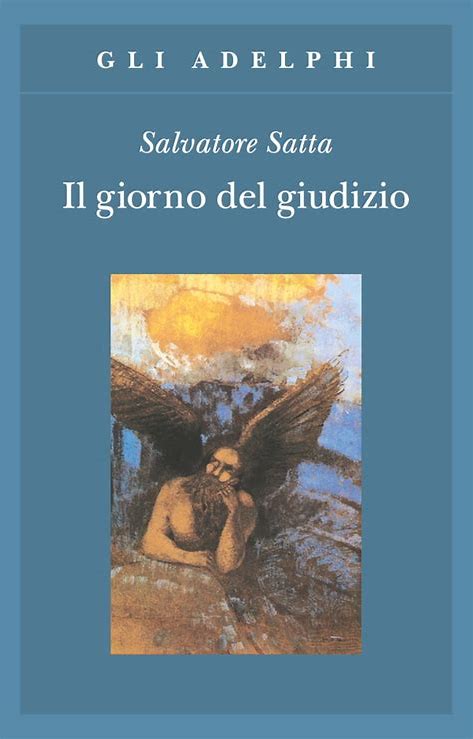 Giorno del giudizio
Giorno del giudizio
BA
Letteratura italiana
Adelphi
1979
292