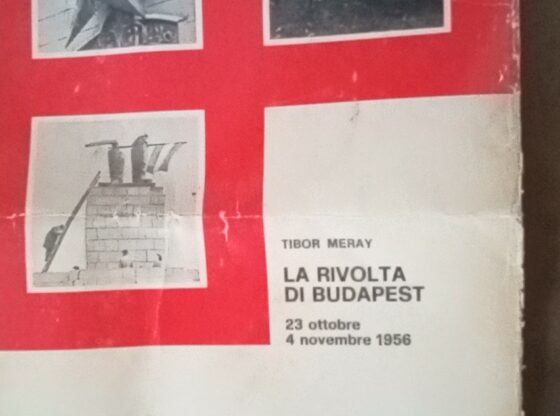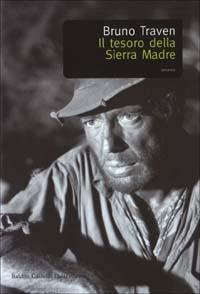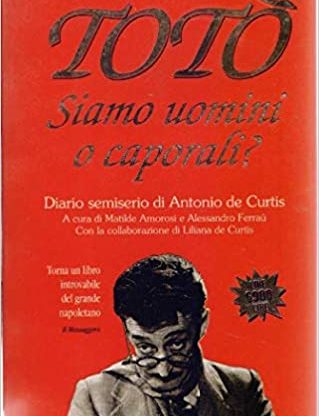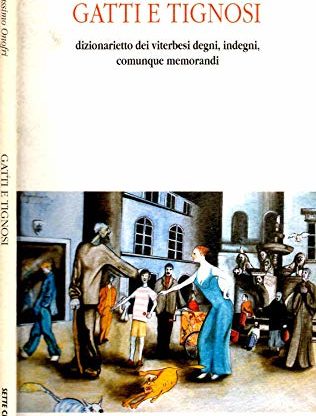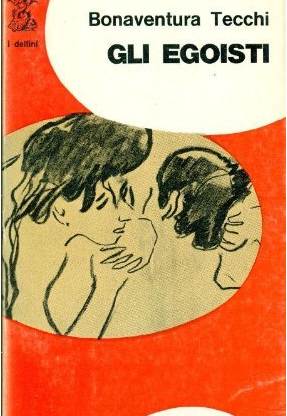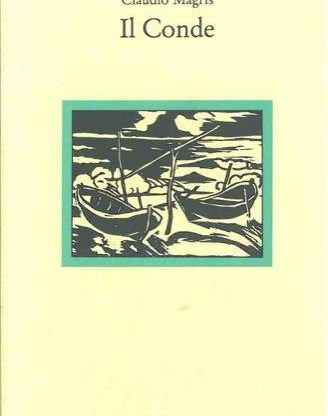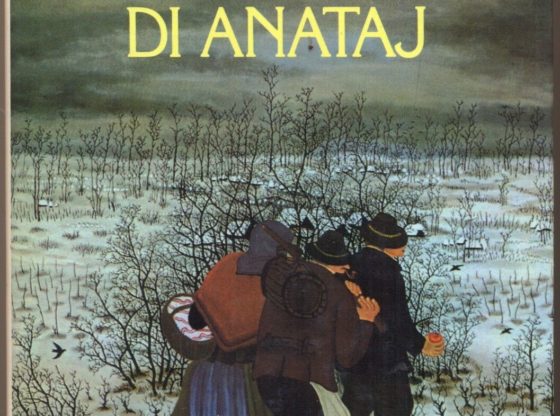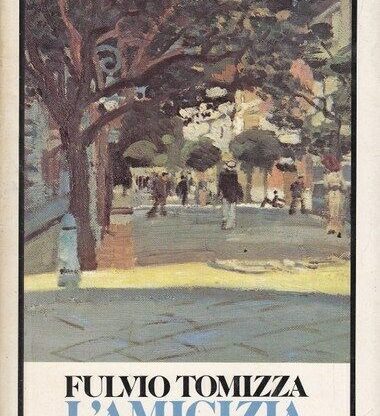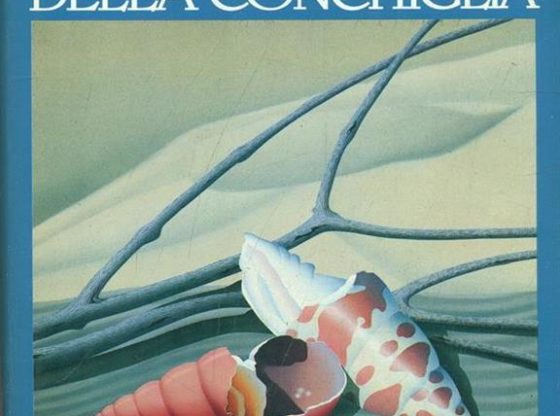Stig Dagerman, uno dei maggiori scrittori svedesi, morto suicida a soli 31 anni nel 1954, è conosciuto in Italia soprattutto per due testi: Autunno tedesco e Il nostro bisogno di consolazione. Chi avesse letto quei libri e si trovasse a leggere L’isola dei condannati, pubblicato da Guida e ormai introvabile, probabilmente vivrebbe qualcosa di molto simile a un vorticoso spiazzamento.

Ma andiamo con ordine. L’isola dei condannati fu scritto durante la primavera e l’estate del 1946, Autunno tedesco nel 1947 e Il nostro bisogno di consolazione nel 1952. Per quanto arbitraria sia, sempre, la tentazione di rinchiudere la poetica di un autore nel recinto stretto di solo alcune delle sue opere, questa volta cediamo a questo arbitrio per dissipare le accuse di oscurità e eccessivo virtuosismo con cui una certa critica ha colpito L’isola dei condannati.
Certo, leggendo queste pagine, può sorgere il dubbio di avere tra le mani la scrittura e la letteratura di due autori diversi. Eppure. Eppure, leggendo con attenzione, non si può non notare come L’isola dei condannati possa considerarsi Dagerman all’ennesima potenza. Partendo proprio dalla struttura e dallo stile. Qui, sia chiaro, bisogna riprogrammare gli strumenti di navigazione, abbandonare i punti di riferimento spazio-temporali a cui si è abituati e viaggiare lasciandosi disorientare. Tra salti passato-presente, momenti di veglia che sembrano sogni, sogni che sembrano incubi, allucinazioni che sono veglie, L’isola dei condannati è un caleidoscopio di immagini che ci restituiscono un libro che, se non è corretto considerare una preparazione ad Autunno tedesco e a Il nostro bisogno di consolazione, è sicuramente un testo gravido delle urgenze più profonde dello scrittore svedese.
Naufragati su un’isola deserta, due donne e cinque uomini, sono preda dei loro incubi, delle loro paure più profonde. In mezzo ad una natura tutt’altro che benevola, i sette personaggi portano in scena una intera cultura in cui, puritanesimo e trauma post bellico, sono dipinti e fatti a pezzi in quella che, giustamente, la curatrice del volume Vanda Monaco Westerstahl “furia distruttiva senza salvezza”.
Senso di colpa, solidarietà, individuo contro organizzazione sociale e politica, solitudine, tempo, dolore, sono buttati su questa isola con uno stile che dal realistico passa, senza soluzione di continuità all’onirico, simbolico e finanche barocco. Ma attenzione perché se si può, certo, notare una sorta di cesura nello stile, la continuità delle tematiche è evidente tra questo libro e i due sopra citati.
Se insistiamo in questo raffronto non è tanto per semplicistica approssimazione ma, al contrario, per mettere in luce la inarrivabile e irrisolvibile complessità di un autore che, proprio con questo salto stilistico, dimostra con la scrittura il suo anarchismo, il suo bisogno di strapparsi dalla tradizione pur sapendo che questo strappo sarà sì la conquista di una sua propria identità di contro però a una specie di perdita di punti di riferimento: un vero naufragio.
“Tutto quello che possiedo è un duello, e questo duello viene combattuto in ogni istante della mia vita tra false consolazioni, che solo accrescono l’impotenza e rendono più profonda la mia disperazione, e le vere consolazioni, che mi guidano a una temporanea liberazione.” Così nelle pagine conclusive de Il nostro bisogno di consolazione. “La stessa oscurità sembra separata in due da una orribile parete di luce, ne siamo inesorabilmente attirati come tarli, poi di colpo tutto passa: la luce si spegne ma brilla ancora sulla nostra retina, con gli occhi sanguinanti cerchiamo di avanzare verso questo punto del quale prima solo sospettavamo l’esistenza, siamo preparati a tutto, preparati a incontrare la salvezza e la rovina, la verità e la menzogna.” Così in L’isola dei condannati. “La carne di dubbia provenienza che in un modo o nell’altro riescono a procurarsi o le verdure sporche trovate dio sa dove non sono indescrivibili, sono profondamente disgustose, ma quel che è disgustoso non è indescrivibile, è solo disgustoso.” Così in Autunno tedesco.
Tre varianti di un’unica partitura in cui si avverte, forte e disperata, la resa di Dagerman alla responsabilità della scrittura, alla presa in carico del ruolo di scrittore, che si cimenti con la letteratura, con la riflessione o con il reportage giornalistico. Anche ne L’isola dei condannati Dagerman non dismette la denuncia sociale, la consapevole lucidità di chi si sa immerso nella stessa rete culturale da cui tirarsi fuori vuol dire, inevitabilmente, restare soli. I personaggi di questo libro appaiono dunque come sette sfumature della stessa sostanza di cui è fatto Dagerman uomo e scrittore che, in fondo, sono la stessa cosa.

Le domande che emergono in continuazione, proprio come le onde che in continuazione colpiscono le spiagge e le scogliere dell’isola, scarnificano certezze, recinti chiusi ma sicuri, richiamando a gran voce il bisogno di un orizzonte di senso anche dove senso non c’è. Dove il senso, come scrive Dagerman in queste pagine, è il simbolico, la lotta che non ha altro senso che la lotta stessa. Cosa sono, l’obbedienza, la direzione, l’individuo e la società? Anche in questo L’isola dei condannati è presente il bisogno/desiderio di vivere senza condizionamenti e la consapevolezza di cosa stare al mondo in questo modo faccia paura. Ecco gli incubi dei personaggi, le loro incertezze, cadute e apparenti vigliaccherie.
Ci piacerebbe vedere ristampato questo meraviglioso e difficile L’isola dei condannati, magari sempre in Iperborea, per se non completare almeno arricchire ulteriormente la conoscenza di un percorso dannato e geniale come quello di Dagerman
Letteratura
Guida
1985
270