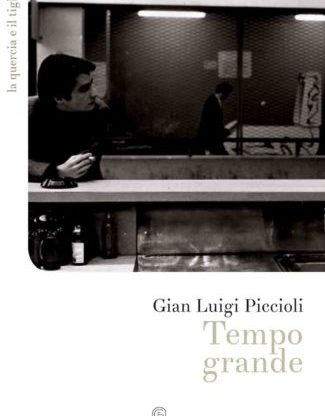Di Geraldine Meyer
Tempo grande che, come giustamente nota Simone Gambacorta (curatore del libro) fu pubblicato “nell’orwelliano 1984”, ci ricorda cosa accade quando la letteratura si mette, attentissima, in ascolto del presente. Arriva a parlarci dell’oggi o del futuro. Capace com’è, la letteratura e segnatamente la narrativa, di scorgere in anticipo le più minuscole particelle del domani prossimo o venturo. Non si tratta di essere visionari. Tempo grande, di Gian Luigi Piccioli, fortunatamente da poco ripubblicato dalla abruzzese Galaad, non è, infatti, un libro visionario. Quanto, semmai, il libro di uno scrittore che ha frapposto membrane permeabili tra vita e scrittura, rendendosi così in grado di leggere ciò che, a posteriori, diventa quasi percorso obbligato.
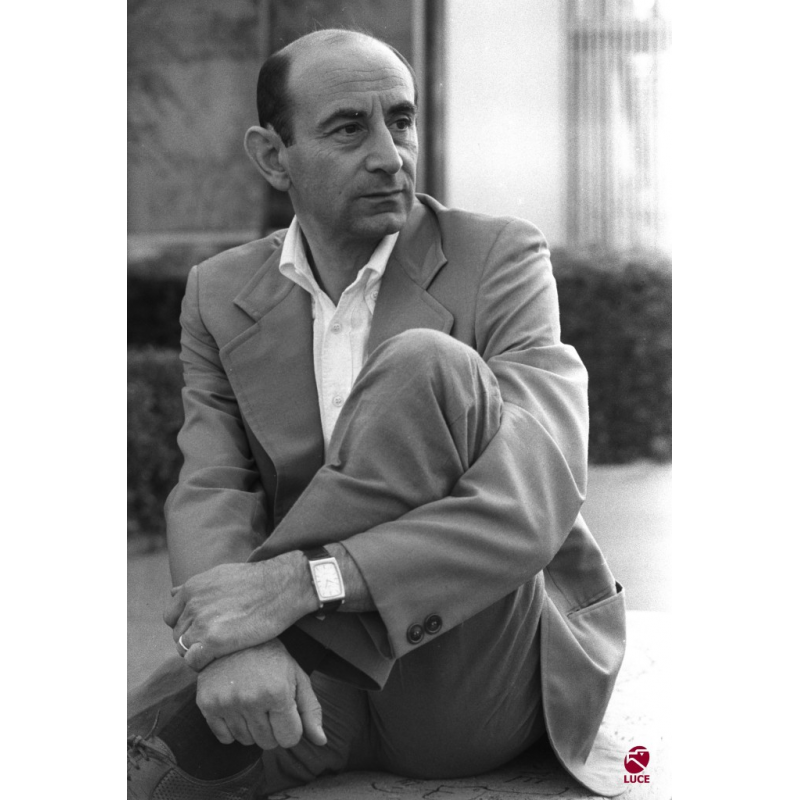
Piccioli, autore tra l’altro di quell’Inorgaggio che gli valse il giusto riconoscimento come scrittore tra i più importanti della cosidetta letteratura industriale, fu uomo di mondo e nel mondo che girò in lungo e in largo realizzando grandi reportage per le riviste Ecos e Synchron, rispettivamente di Eni e Agip, quando le grandi industrie univano capitalismo e cultura, mercato e scrittura, in una quasi ossimorica contraddizione.
Fu forse anche questa sua apertura a consentirgli di scrivere un libro come Tempo grande che, con trent’anni di anticipo, raccontava la televisione e le sue derive, il suo trasformare ogni cosa in prodotto, il suo insinuarsi in ogni crepa per sostituire la realtà con la spettacolarizzazione del verosimile, il suo creare finanche una nuova lingua, non semplice ma, semmai, semplificata.
Siamo a Roma, città che appare come coprotagonista del libro, “Le antenne televisive ne fanno il più bel cimitero monumentale del mondo” – scrive Piccioli. E siamo in uno studio televisivo in cui vengono trasmessi, in continuazione e in tempo reale, servizi, notizie, immagini soprattutto, che arrivano da ogni parte del mondo. Un flusso ininterrotto di “live”, di “reality” in cui tutto è sullo stesso piano semantico, emotivo, filologico. Non vi è scarto, non vi è soluzione di continuità. E il numero di spettatori si conta in centinaia di migliaia, anzi, milioni. I servizi sono realizzati da dispositivi che, con un interessante neologismo, Piccioli ribattezza “telebaby”, prefigurando sia gli attuali smartphone o tablet che rendono tutti connessi con tutti e tutto, ma anche prefigurando una sorta di personificazione delle telecamere stesse, che sono “baby”, quindi vive e, in quanto baby, destinate a crescere.
Scrive Gambacorta nella bellissima prefazione: “Il villaggio globale di McLuhan, la società dello spettacolo di Debord, la tv “assassina” di Baudrillard: Tempo grande racconta la bulimia di una televisione sempre più aggressiva e sempre più cattiva maestra – secondo la lettura di Popper e Condry -, un gigantesco tubo digerente a ipertrofico tasso tecnologico che aggredisce e sbrana l’attualità su scala globale per trasformarla e rendere l’informazione e l’intrattenimento (la loro sintesi) merce di consumo.”
Tre i personaggi principali: l’ambizioso e ultratelevisivo Marco Apudruen, il silenzioso e introverso Gigi Insolera, scrittore di poco successo e autore delle didascalie che accompagnano i servizi, e la fotografa Marianna Estensi, bella e giovane che si insinuerà tra i due fino a comprometterne amicizia e rapporto di lavoro. Ma, non pensiate al classico triangolo amoroso, la classica storia in cui la donna mette in pericolo il sodalizio maschile. Il sospetto di misoginia viene spazzato via e dalla biografia stessa dell’autore e dalla lettura approfondita di Tempo grande in cui non è arduo scorgere nei tre personaggi la metafora o, meglio ancora, la rappresentazione di tre diversi linguaggi: televisione, scrittura e fotografia.
Crudeltà, paura, cinismo, mistificazione. La società dello spettacolo, con le sue regole e il suo essere quasi una rappresentazione più vera del mondo vero, sono qui raccontate e dipinte con una lucidità che lascia quasi spiazzati e tramortiti. Certo soprattutto pensando a quando questo libro fu scritto ma, anche, per le domande che pone sulla prevedibilità di ciò che sarebbe avvenuto, sui cambiamenti che la tv avrebbe portato non solo nei suoi propri ambiti ma sulla società intera.
Cosa ha da dirci un libro come Tempo grande che, Gambacorta definisce più contemporaneo che attuale e che io, più modestamente, definisco contemporaneo rispetto all’oggi e già attuale rispetto al 1984? Ci dice che la letteratura resta e deve restare un campanello d’allarme, un pungolo all’attenzione. Una vera e propria sonda che si assuma la responsabilità di scandagliare la realtà e i suoi infiniti modi di manifestarsi. Oggettività e soggettività, verità e menzogna: “La menzogna, percepì ancora con angoscia, non è solo l’opposto della verità, ma è anche il plurale della verità. Doveva avere il coraggio di somministrare le mille verità della cronaca, col rischio di sembrare lui stesso la menzogna in persona, affinchè fossero loro la verità, i telespettatori di cui era al servizio.”
Allora, come nel caso dei gerarchi nazisti che “stavano solo ubbidendo agli ordini” anche la tv non fa niente altro che “ubbidire agli ordini”? Allora si capisce meglio cosa e quanto ancora abbia da dire un libro come Tempo grande in un paese in cui Il grande fratello resta tra le trasmissioni più seguite.
Ne parliamo con Simone Gambacorta che del libro, come ricordato, è il curatore.

Da dove è arrivata l’urgenza di ripubblicare Tempo grande?
«Dal fatto che nasce da una ricerca sulla parola e sui contenuti. È un romanzo che per tema e stile aiuta a porre delle discriminanti. Oggi forse abbiamo dimenticato cosa sia uno scrittore, ci accontentiamo di sapere chi sia: il volto, l’immagine, il nome, la copertina e la spendibilità di una notorietà sempre più commerciale. Secondo me non si può essere scrittori senza essere degli intellettuali. Gian Luigi Piccioli era uno scrittore perché era un intellettuale, era un uomo a cui piaceva la fatica del pensare tra sé prima ancora che sulla pagina. Aveva uno sguardo prismatico e comparativo, metteva in relazione l’Italia e il mondo, la storia e il presente, la narrativa e la scienza. Il distillato eloquente di questa sua inclinazione sono i suoi romanzi, sempre legati a tematiche macro: l’industria, l’Europa, la natura, il potere, i media. Oggi io credo occorra distinguere tra chi pubblica – magari anche con successo – un prodotto vendibile come fiction e chi agisce nel proprio tempo come scrittore o come poeta facendo letteratura. Sono due livelli un po’ diversi. Dico letteratura e penso a romanzi come “Cani sciolti” di Paris, “Il serpente” di Malerba, “Il quinto evangelio” di Pomilio oppure “Misteri dei ministeri” di Frassineti. Cosa raccontare e come raccontarlo sono le dimensioni problematiche che uno scrittore individua come l’ascissa e l’ordinata del proprio lavoro: ma parlo di uno scrittore che non si contenti di confezionare storie tautologiche, che non vanno al di là di quello che dicono e del proprio intreccio. Oggi vedo per lo più romanzi che escono fuori per una grottesca dissenteria collettiva. Vorrei un fermo biologico di alcuni anni: guardiamoci indietro, anche solo di poco, e scopriremo tesori più attuali del quotidiano che sarà in edicola domani».
Credi che il fatto che un libro del 1984 sia così contemporaneo dica molto, oltre che della grandezza di Piccioli, anche sullo stato della nostra letteratura?
«Credo che dica molto dello stato di crescente amnesia che affligge la nostra narrativa. Scrittori come Piccioli, Crovi, Bigiaretti, Prisco, Terra, Lombardi, Ottieri, Patti, Montesanto, Porta – e qui mi fermo perché potrei continuare – sono oggi confinati in una sorta di clandestinità. Il mio non è il rimpianto di un bel tempo che fu, non saprei che farmene di simili lagne. Solo che oggi celebriamo autori che, a confronto con quelli che ho citato, sono molluschi. È un discorso di consapevolezze. Non lo dico per togliere qualcosa a chi scrive oggi, ma per non togliere nulla a chi ha fatto la differenza ieri. Fermo rimanendo che tra chi scrive oggi ci sono per fortuna maestri come Nigro e Desiato. Se oggi uscisse un romanzo come “Scende giù per Toledo” di Patroni Griffi, si griderebbe giustamente al miracolo. Lo stesso vale per “Ninfa plebea” di Rea. Imbarazza il fatto che questi patrimoni di lingua e invenzione siano messi da parte. Uno che scrive non è che debba eleggerli per forza a propri modelli, ma non può neanche non sapere chi fossero».
Dell’importanza di questo libro si è detto. Ma ciò di cui, forse, poco si dice, è la sua scrittura, lo stile. Come definiresti, limitatamente a questo testo, la scrittura di Piccioli? E come pensi sia, anche essa, in certo qual modo, contemporanea?
«Piccioli è stato uno sperimentatore, ogni rigo che ha scritto lo dimostra. A me pare che la scrittura di “Tempo grande” tenda a essere sempre un presente. È una scrittura all’indicativo, una scrittura in atto: è una scrittura che si fa ancora adesso, che si sperimenta, che si mette alla prova anche a trentacinque anni di distanza. Si consegna al lettore rivelando il cimento di sopravvivere a se stessa, alla sua stessa messa in forma. È una scrittura che esprime il senso di se stessa nel tentativo di costituirsi come tensione capace di rinnovarsi in un complesso di soluzioni che divengono stile. Questo uso della lingua si riversa in un sistema di narrazione sostanzialmente governato da due movenze primarie, due grandi forze: una di tipo ellittico e una di tipo paratattico. Del resto ellittica e paratattica era l’epoca che Piccioli ha voluto raccontare nel suo romanzo. Tutto in “Tempo grande” sembra congiurare per opporsi alla standardizzazione che la tv avrebbe provocato negli anni a venire: mi riferisco a quell’omologazione pasoliniana che avrebbe imposto un ribassato gusto di “lettura” delle cose e che avrebbe determinato – com’è stato – l’emarginazione di scritture come quella di Piccioli. Mi dà da pensare l’amore per i gialli. Li trovo consolatori, giungono a soluzioni certe. Leggo e so che tutto alla fine andrà a posto, di solito grazie a investigatori oramai fatti con lo stampino. Al che uno potrebbe obiettare: ma allora Simenon? Ecco, il punto non è l’autore, anche se è evidente che di Simenon il mondo è tutt’altro che pieno; il punto è l’aspettativa del lettore medio, che oramai cerca in un libro intrattenimento e stereotipi».
Un elemento della storia, quasi una storia a sé, è il rapporto tra i tre personaggi. Perché, secondo te, questo loro rapporto è funzionale all’argomento principale del libro?
«Perché “Tempo grande” è sì un romanzo sui media, ossia sulla televisione, ma è anche e soprattutto un romanzo sui rapporti umani. È uno zoom sui sentimenti nell’era del piccolo schermo. Questo ingrandimento sarebbe piaciuto a McLuhan, che mi risulta qualcosa sapesse del rapporto diretto che viene a crearsi tra le mutazioni mediali e le conseguenti mutazioni della relazioni interpersonali e degli assetti sociali».
Ultima domanda: cosa ha comportato, per te, in termini di lavoro come critico letterario, occuparti della curatela di questo libro?
«Prima di tutto due cose. Uno: trovare un editore sensibile a un’operazione che, almeno in linea previsionale, non prometteva particolari ritorni economici. Due: trovare un editore disposto a ripubblicare un romanzo del 1984, impegnativo e di trecentocinquanta pagine. In Paola Vagnozzi e Paolo Ruggieri, della Galaad Edizioni, che sono due amici, ho trovato ancora una volta gli interlocutori ideali. Con loro, non a caso, anni fa pubblicai il libro-intervista a Piccioli “Tempi simultanei”, cui seguì di poco la raccolta di reportage di Piccioli “Africa vivi”, del quale sono stato prefatore. Oltre a questo, l’impegno è consistito nello scrivere una prefazione che spiegasse le ragioni culturali e non solo letterarie della scelta. Tutto però è stato possibile grazie alla disponibilità di una persona straordinaria e generosa come Anna Di Nicola Piccioli. Spero di poter curare la ripubblicazione di altri libri di Gian Luigi Piccioli, non ho dubbi sulla qualità della sua opera».
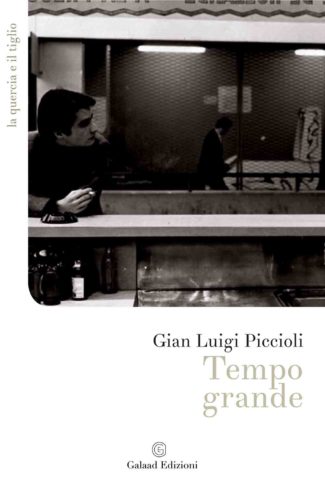 Tempo grande
Tempo grande
Letteratura
Galaad Edizioni
2019
346