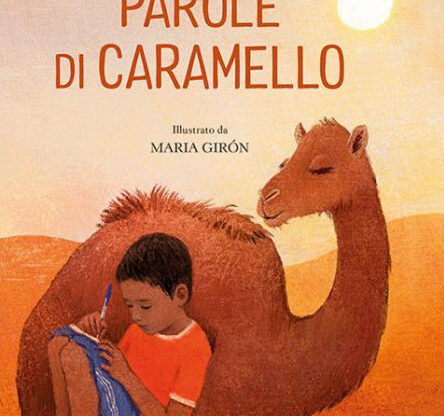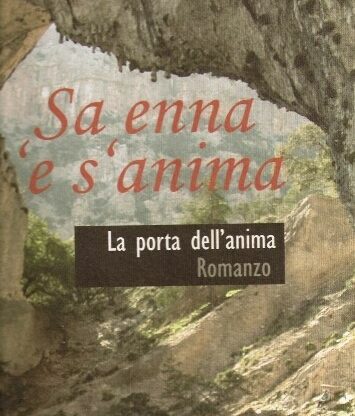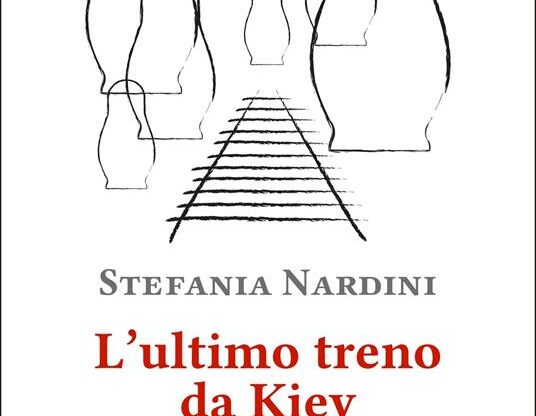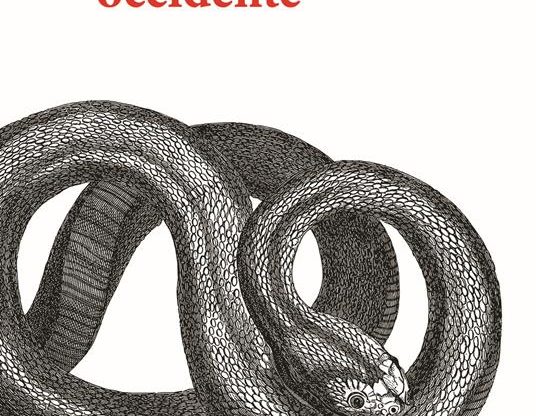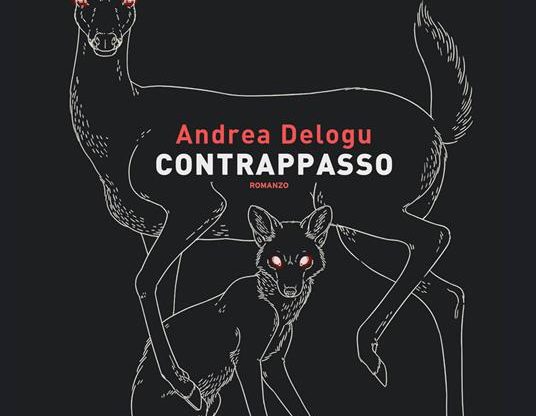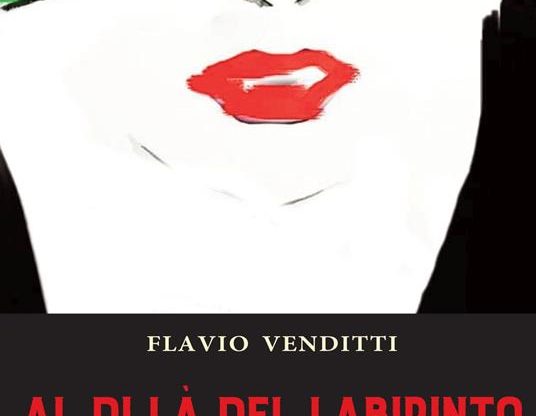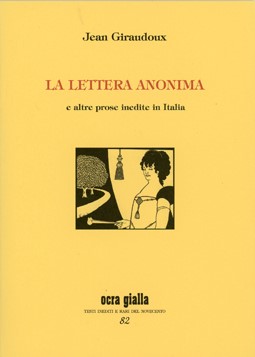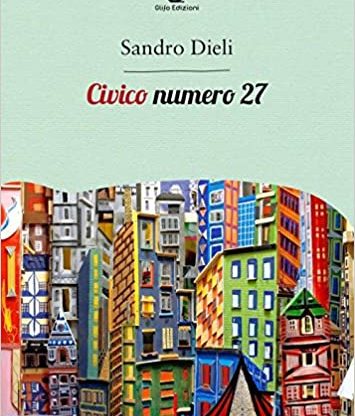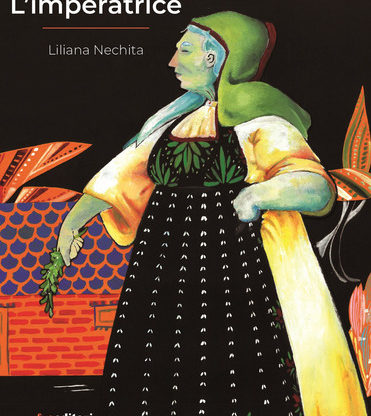Anni Luce di Andrea Pomella. Dixitque Eddie Vedder fiat lux.
Di Carmine Maffei
Dopo aver letto L’Uomo che trema, capii subito che tra me lettore e Andrea Pomella si era come stabilito un rapporto di taciti accordi plurisensoriali che trascendessero da esperienze analoghe, ed oltretutto condivise, come la depressione, la paternità intesa come miracolo risanatore, l’amore indiscusso per il rock ‘n’ roll, e il rock’n’roll inteso come possibile miracolo risanatore della depressione, anche se spesso queste ultime due cose sono andate a braccetto ricompensandosi, dandosi dei buffetti d’intesa. Per molti anni ho ricercato, attraverso i libri, i titoli che m’ispirassero una condizione di benessere che si rifacesse al mio spirito divergente ed ambizioso, pronto ad una nuda esposizione verso il prossimo, tacitando però i pensieri erroneamente considerati più vivaci del solito, ed ho infine compreso, che oltre quell’affetto incontrastato che provo per la narrativa, classica o contemporanea, ci fosse in realtà nascosta tra le sue pagine quella parentesi che mi riportasse indietro nel tempo, nelle esperienze sui palchi, con la mia chitarra, con la voce rotta dall’emozione, ma prontissima. E’ successo qualcosa del genere quando ho letto La banda dei brocchi di Jonathan Coe, e giuro, che oltre ciò non sono riuscito a ripetere tale esperienza di cui ho già espressamente parlato, ed anche in maniera logorroica e pietosa.

Quando, dicevo, ho preso tra le mani L’uomo che trema, ho avuto la sensazione che il protagonista, col suo grido d’aiuto, stesse in qualche modo esponendosi nelle sue debolezze, nella sua scarsa autostima forse, ma soprattutto nella forza incontrastabile che esiste nell’armonia di un brano rock che contenga nella sua linfa la nostra filosofia, il nostro benessere più timido, e tale esperienza era stata analizzata attraverso i brani di Elliot Smith, cantautore americano tra i più sensibili, della scena di Seattle, morto in circostanze misteriose, e forse oggi ancora poco valutato.
“Il rock non risolverà i tuoi problemi ma ti consentirà di ballarci sopra” sostiene Pete Townshend, primo compositore e chitarrista degli Who, la band che per prima distruggeva gli strumenti alla fine di ogni show, come a dire “vi è piaciuto? Allora faremo in modo che ridiventi il vostro incubo”. Roba che nel 1965 avrà fatto inorridire, oltre alla tradizionalista famiglia inglese, addirittura gli scatenati fan della Beatlesmania. Negli anni 90, dunque, i Nirvana furono sì un ritorno all’esperienza di una sorta di My Generation venticinque anni dopo; distrussero, oltre agli strumenti sul palco, in qualche modo la lussureggiante avventura glam e patinata del decennio precedente, presero in pugno la scena, portarono alla ribalta una nuova forma di punk, di quel rock a volte tanto geniale quanto ignorante -e chi scrive non è un genio sullo strumento-, ribaltarono la fine del Novecento nella più autodistruttiva forma di impeto post adolescenziale, quello in cui la presa di coscienza della vita adulta inizia a bussare all’uscio, e dietro non resta che uno spiraglio di luce.
E a proposito di tale ultimo sostantivo appena espresso, il romanzo Anni Luce di Andrea Pomella (Add Editore) mi ha riportato un po’ all’esperienza febbrile della lettura de La Banda dei Brocchi di Coe, solo che questa volta coloro che hanno preso in mano la scena sono gli stessi protagonisti rock di Seattle che nel primo quinquennio degli anni Novanta ebbero il mondo tra le mani, e lo attirarono a sé come un’enorme calamita fatta di dolori ininterrotti, infruttuosi pensieri sull’avvenire, il passato con i suoi bruschi cambiamenti che avrebbero distorto il pensiero influente sui decenni futuri. La storia di questo libro, che vuol definirsi autobiografica (perché ripeto che è come se già avessi conosciuto Pomella, ma non so in quale vita), anche se ovviamente romanzata e arricchita da aneddoti che colorerebbero il testo nelle sue avvincenti diatribe, parla invece di due ragazzi, due ventenni, che nell’era del grunge danno il benvenuto ai loro vent’anni, e probabilmente anche il ben servito, perché cavalcano sull’onda di quella musica arrabbiata, furiosa e autodistruttiva, a cominciare da ciò che forse ha dato il via a tutto: Ten dei Pearl Jam.
“Stringerò la candela fino a bruciarmi / continuerò a farmi prendere a pugni finché non saranno stufi / fisserò il sole fino ad accecarmi / e non cambierò idea né direzione”.
Eddie Vedder, il cantante della band, è anche il predicatore, il messia di questa nuova religione di disperati che si avviano a mantenere un ordine nel proprio disordine, che si autodefiniscono immuni dai cambiamenti che la vita e le circostanze offrono, che si dichiarano totalmente estranei a qualsiasi motto nostalgico degli anni precedenti, ma che non si avvicinano nemmeno alla contemporaneità. Eccoli, coloro che con le loro camice a quadri, di flanella, da operai, inducono a pensare ad una nuova generazione (My Generation appunto) che voglia emulare la comunità del Delta del Blues, e dalla cui sofferenza, causata però dalla febbre di un occidentalismo ostentato, forzato in seguito alla caduta del Muro, viene fuori il motto della propria speranza, racchiusa però in una bottiglia, in un trip, in una gita fuori mano, in un concerto rock.
Il protagonista, l’io narrante, vive la sua vita nella periferia romana come un castigo; i suoi genitori si sono separati già da anni, si sente solo e asociale, frequenta Lettere alla Sapienza ma è un mondo fatto di individualismi, di arrivismo, e si rifugia tra i libri di Kerouac e della Beat Generation, dove è come se i protagonisti di quella corrente gli stessero parlando, gli tenessero compagnia.
La vicinanza a ciò che può definirsi compagnia nel senso più profondo arriva quando lega l’amicizia con Q., ragazzo ribelle, coetaneo, dai lunghi capelli ondulati, col chiodo sempre stampato addosso, con la chitarra Flying V con la quale si espone in assoli nostalgici, sentiti, sofferti, ammalianti. La vera esperienza non è soltanto nella band in cui il protagonista canta e suona la chitarra d’accompagnamento e dove Q. entrerà in tutto il suo splendore mesto, ma nella condivisione di quell’alienazione che è materia di disagio di chi narra. Il bruciore degli anni più irruenti, dei vent’anni, trovano la giusta esposizione nella storia musicale che sta per compiersi, nell’elogio alla follia che tale parentesi sottolinea nelle scorribande dei due, nelle loro sbronze, nella loro vita allacciata a quella di alcuni vagabondi strafatti di acidi, nell’esperienza da artisti di strada, quasi da clochard, nei viaggi che intraprendono per allontanarsi dai propri limiti, per avvicinarsi ai propri obiettivi composti da tutto, forse da niente.
“Grazie al grunge tutto ciò che accadeva intorno alle nostre vite trovava un terreno disposto ad accoglierlo, delle sensibilità in grado di condensarlo, e un bisogno capace di restituirlo. Il grunge faceva di noi degli iniziati che credevano alla dannazione del mondo. La nostra mente, il nostro sistema nervoso, e perfino quella cosa che si suole chiamare anima, erano permeati dall’assenza di luce”
La luce ancora, quella materia indistinta ma accecante, quasi tangibile nel senso più ingannevole del termine, in quanto “ogni ombra è figlia della luce” come sostiene Stefan Zweig, “fiat Lux” dice il Creatore nel primo libro della Genesi; ma anche gli anni luce che definiscono la distanza tra un pianeta e l’altro, ma che trovano importanza addirittura tattile nella frase di Eddie eVedder: “Ogni centimetro tra noi ora diventa anni luce / non c’è tempo per essere vuoti o per risparmiare sulla vita / bisogna viverla tutta”.
Un effetto scatenante dà fine all’amicizia quasi morbosa tra i due, e non sarà l’amore per la stessa donna, ma la capacità d’intravedere, in una tragedia sfiorata, l’affacciarsi delle responsabilità che di lì a poco sarebbero arrivate. Così come il progressive e il poi il punk alla fine dei 70, il grunge alla fine degli anni 90 è soltanto l’emulazione di sé stesso, l’ombra che è figlia di una luce, la disgregazione di un’amicizia fondata su una sincerità che si nutriva di utopie giovanili, ogni centimetro che tra quegli anni e il resto sono soltanto anni luce, il senso di stordimento e poi di vuoto che ci lascia una nottata di sbronze. La storia resta lì, nelle canzoni, coloro che possono rendere immortali i momenti che pensavamo si fossero dissolti, che rende riconducibile il nostro pensiero da adulti ad una voglia matta di infantilismo, di spensieratezze.
“Il mistero di certe canzoni sta nella loro capacità di svelarsi lentamente, pezzi di volti, mani, frasi, si confondono vaghi, inconsistenti, nell’ala inferiore della nostra percezione. Ma lasciano segni, e catturarli è difficile”.
Più o meno alla fine degli anni 90 anch’io ebbi un amico come Q., che suonava davvero la chitarra da dio; dormiva tutto il giorno ad eccezione di quando sentiva di dover esprimere qualcosa sullo strumento, o come quando lo svegliavo alle nove del mattino dopo aver marinato la scuola, solo per il desiderio di vederlo suonare ancora, ed ancora. Non sapevo che alla sera se ne andava a zonzo per la città in cerca di emozioni forti, che lo stordissero a dovere, che lo annientassero. All’epoca ero un ragazzino e certe cose ancora non le capivo, ed era per questo che lui si rintanava a letto, confortato dai poster di Slash e di Jimmy Page. Il sabato e la domenica ci vedevamo per le prove; gli amici, increduli, arrivavano trafelati in sala per vedere quel portento, quel virtuoso, quel dannato i cui segreti notturni conoscevo soltanto io.
Anche per questo ho amato Anni Luce di Andrea Pomella, perché è un libro che mi ha letto dentro.
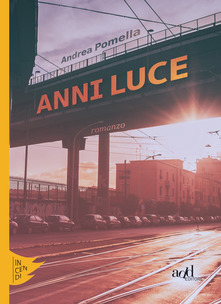 Anni luce
Anni luce
Narrativa italiana
ADD Editore
2018
149 p., brossura