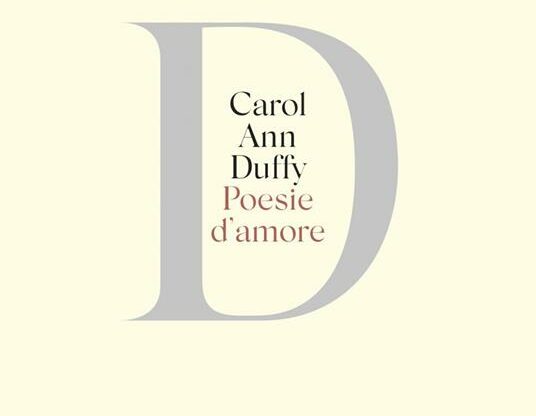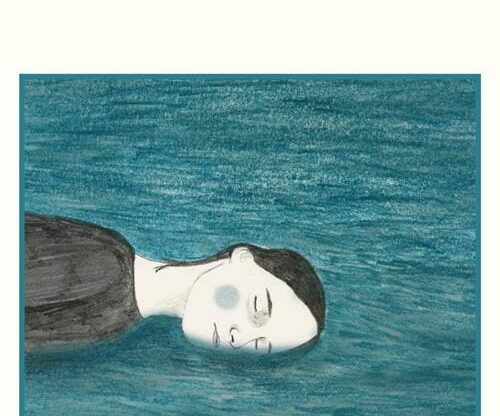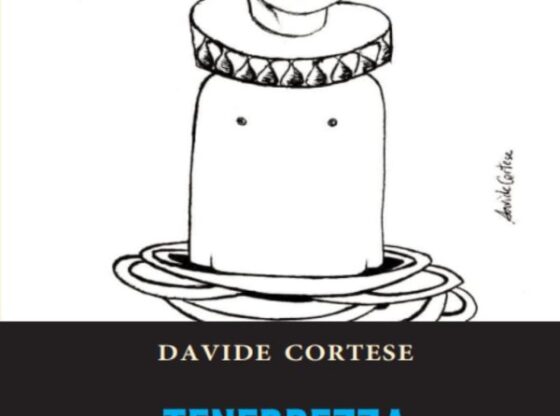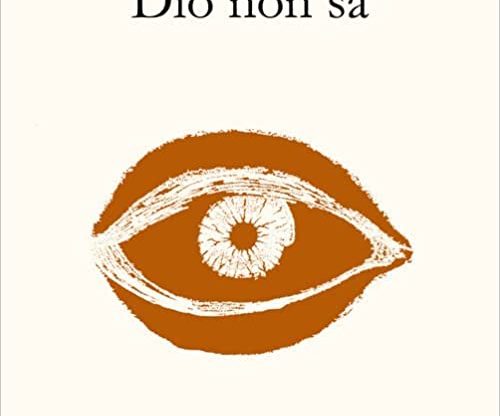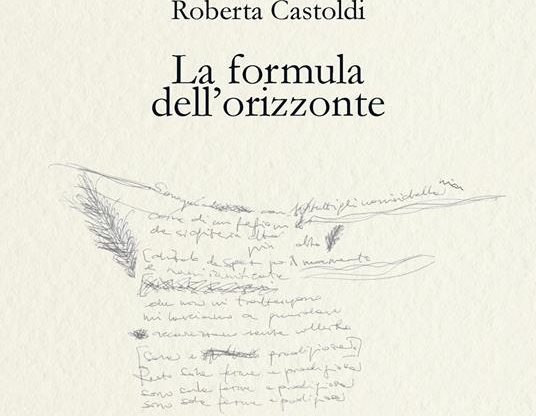Su di un’anima infondata
qualcuno ha scommesso forte.
Due alberi ballano un lento e
sputano fiori sul marmo,
niente che si sforzi di convincere.
Qui, a vertebre spaesate,
bacio la Madonna di fondo
di ogni istante insonne
ma il sogno rimane Kabul,
pietra tumida e primeva,
lapidazione di un capolavoro.
Il peccato non sa attecchire,
il volo cenerino del corvo
non lascia tracce nel corallo
del cielo solcato dall’alba
Fare i conti col santuario
del pube una volta per tutte:
al loto di seta risponde
una bacca di belladonna.
E’ finita l’ominazione,
siamo all’orlo del patibolo,
fendenti dorati attendono
in una squarciabile notte,
la stessa sordida
che ha asservito papi
e sgozzacapre poggiati
alle mura di Lhasa,
papagorge pronte ad incolpare
il vento e il laudano
per ogni claudicante bara.
Molti i mocenighi, troppi
gli altrui ad intiepidirsi
i dorsi delle mani sulle reni
di vecchie e laide.
Sottopelle qualcosa ha messo vela
verso il caos, quello manifesto.
Cercavo soldati perduti
nella nebbia di sangue nubefatto
e invece e’ stato un mercato
di fiori e di piccioni a saltare
per aria coi bambini e gli ami di ottone.
La carta dell’Appeso panneggiata
nel cielo coperto e’ in disservizio.
Luci tiepide schivano le gocce,
una pattina sul vetro di un finestrino.
Eseguire la propria volonta’
di un’esecuzione capitale.
Mi concedo di sfidare
il tempo. Lo spreco e’ un concetto
che non affligge chi ricorda
i primi balbettii della morte.
Ogni planar di fiore vale
le cataste di inferni sbeccati.
Poi, in un giorno mai sognato
ll mio guru disse: “Ora va’
e contraddici te stesso”, e la
vita gioco’ a tagliarsi come petali
di passi nella neve fortificata.
In uno splendido buiore
davvero bevvi il sangue delle creature,
per questo so di non essere un assassino.
Rubai ori scorsoi in una mimesi
di risparmi altrui, per questo so
di non essere un ladro.
Spergiurai sui confratelli
chiamando Luna il Sole
e giorno la notte, per questo
so di non essere un bugiardo.
Tolsi il capo dalle ravvedute tane,
il nome e’ stato un colpo di maglio
senza intenzione di portarsi dietro,
di certi sciami sordomuti
non mi ritengo responsabile.
Fui io a molestare i versi
affinche’ la poesia mi leggesse.
Piu’ i poeti denunciano avventi oscuri,
piu’ innamoro e piu’ delinquo,
in un nido oltremisura.
Mentre onorate il padre e la madre
stretti alla crine di chi non sa la via
il poeta capta Orione, e sparendo
si fa vero, il navigarsi concavo
di un mosaico di presenze,
a malapena certe, a malapena false,
immortali stenti nel mirabile maltempo
di una stagione contraffatta.
Non attardarti sulla pozza di sangue,
sull’uomo che rimuove lo scalpo del figlio.
Queste non sono che coordinate:
bagliori di un astro mai schiuso.
L’anima mai si ripercorre, mai!
I suoi passi lasciano tracce d’incendio
e chi non ce l’ha si affretta dormendo
a schierarsi con furia suicida.
Dal primo giro di giostra d’atomi
mi accusano di troppa traslucenza,
perche’ ho dato fondo alle fornarine
e non ho rispettato regni e phylum.
Reclamando spesso al cospetto
di niente tutto l’oro d’Etiopia, ho
forzato le pareti dell’amnios.
Ma e’ per discolparmi che assalto
gli astri e i bordelli. Mea Culpa!
Solo quando la sera
scava la fossa al sole
e’ accettabile che si adori
il lampo, il fuoco e la brace.
Agevoli lacrime in una guerra persa,
dove tutto e’ misurato
in una psicostasia rose’
che rende fluidi i ruoli,
come lacrime che salgono la fronte
per bombardare i cieli.
E i marinai si fanno costellazioni.
I miei sol non sono chirali,
pero’ esistono, e con loro
ho fatto di ogni citta’ un ninfeo,
le strade di osmio hanno
il tuo nome e il giorno gronda,
ne fuoriescono sogni di latte.
Se mi vedi lieto come la porpora
della sera e’ perche’ ho squarciato
l’aria coi miei cavalli neri,
ho sorretto il lavoro della morte
che ha fatto proprie
teste amiche e nemiche.
Negoziai in prossimita’ degli incendi,
fino alla fine di una sete erotta.
Moebius celebro’ le mie trenta nozze
e nel nulla delle nubi scaldai le tibie,
pane di sussutti sul quale posare
tutti i moventi, le serenissime e le nomee.
Spodestando il savoir faire i miei
strali innici colpiron qualcosa
oltre il diniego del cielo. Sangue fresco
ne provenne, gocce centaurine,
specchi inauditi. Abbiamo ben commesso:
e’ troppo tardi finalmente.
La linfa delle catene fara’ la via,
se proprio ne serve una.
Per un amore invero,
decrescente come un angelo
minore, mi feci donna,
saliva, serie di petali scesi
da un m’ama-non-m’ama,
placenta di un milite
ignoto. Giocoforza mi tradii,
come un calamo di paglia
che scrive col sangue
i suoi scongiuri al giorno
semovente, portato via
da martelletti di cristallo
lacrimale. Mi tradii
e divenni un me,
di selce e di ciocco.
il mondo si riempi’ di sorelle,
d’ori d’oriente, ed ora che
ho ben predato so che e’
il tuo turno di uccidermi.
Se non mi disarcioni e non
mi derubi della liberta’
come potrai divenire donna
e farmi godere? Devi ignorare
chi pianto’ i susini per
il gusto del vento, chi
migrando
ti fara’ anfora fragile.
Ci ripescheremo allora
sul fondale di una baia
di lavendulano. Ho lavorato
nelle miniere del pi greco
proprio per farti fiorire
oltre le spose in schiera.
Prenditi i respiri che ti servono,
che i cavalli rientrino
per
il gran falo’.
Avevamo creduto,
tutto qui, e’ stato bello
temerti e averti svista
non lontana dal Mar Bianco,
vestita di renna, piu’
che viva nel cono
dei cattivi propositi.
Un giorno ritrovero’ il
chiaro dei tuoi occhi come
questa cintura di venere,
adagio sul mio palmo.
L’immagine di copertina è un’opera senza titolo dell’artista polacco Zdzislaw Beksinski, da culture.pl