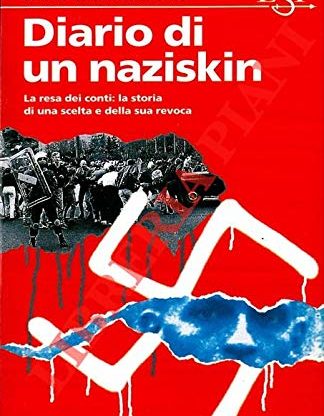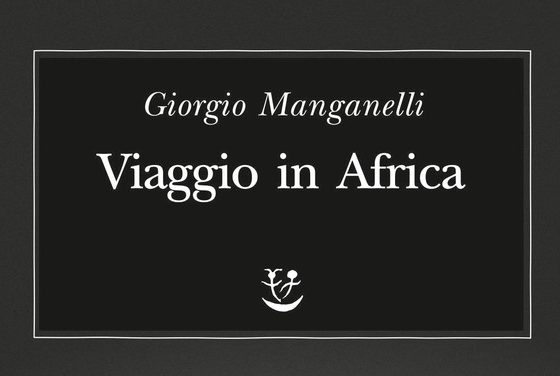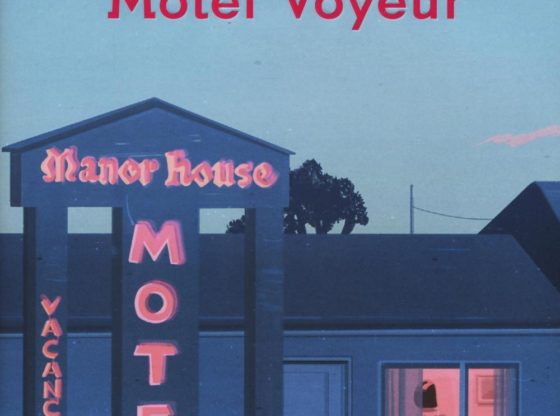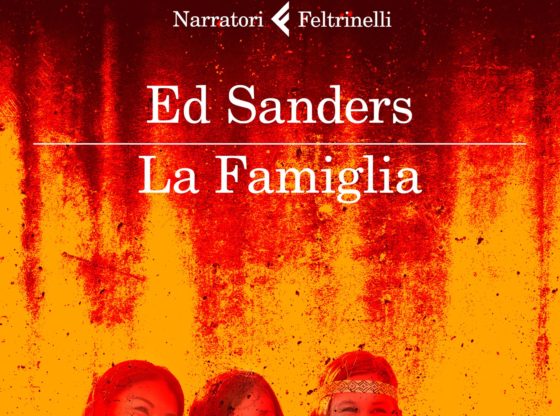Concetto Vecchio, giornalista de La Repubblica, realizza, con questo struggente e lucido Cacciateli, quello che ci piacerebbe definire un libro urgente. Se non fosse che, un testo di questo tipo è destinato ad essere letto da coloro che, l’urgenza l’avvertono già. Non certo da coloro i quali la memoria l’hanno già persa da tempo, o semplicemente non l’hanno mai posseduta.
Cacciateli è un libro che induce, inevitabilmente, ad essere letto e assorbito facendo continui raffronti con il presente. Pur sapendo come gli avvenimenti storici necessitino di una lettura contestualizzata, il richiamo all’attuale è, non solo forte, ma anche necessario.

Cacciateli. Quando i migranti eravamo noi, è un lavoro documentato, personale e storico, che mette Concetto Vecchio nella schiera nobile e sempre più scarna, di chi fa giornalismo letterario, o letteratura d’inchiesta. Qui, partendo dalla personale necessità di comprendere la storia dei propri genitori, l’autore ricostruisce la storia dell’emigrazione italiana in Svizzera, nei decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale. Anni in cui i governi italiani incentivarono l’emigrazione dei loro stessi connazionali perché affrontare seriamente il problema della disoccupazione era più complicato che “disfarsi” di manodopera delle cui rimesse beneficiare.
Furono quelli anni di profonde trasformazioni, improvvisi inurbamenti, di divari sempre più drammatici tra nord e sud. Furono dunque, quelli, anni in cui centinaia di migliaia di uomini e donne emigrarono in Svizzera, divenendo gli ultimi (che nella storia ci sono sempre), gli stranieri, i negletti. Da queste pagine emerge una storia che sa, drammaticamente, di altre storie, di altre emigrazioni. In che condizioni vivevano i nostri connazionali nella Svizzera degli anni ’50 e ’60? Baracche, abitazioni che definire tali è quantomeno un eufemismo. Costretti a lasciare a casa mogli e figli perché gli stagionali non dovevano radicarsi in territorio elvetico. Portavano via il lavoro agli svizzeri, se si ammalavano avevano bisogno degli ospedali svizzeri, se avessero messo su famiglia avrebbero avuto bisogno di nuove case. Troppo, decisamente troppo per un paese e una popolazione ubriacata dal benessere tanto quanto terrorizzata dall’idea di perderlo. E sull’onda di tale terrore e di una altrettanto forte perdita di memoria della loro precedente povertà, fu facile aprire la strada a rivendicazioni di stampo xenofobo, al grido di “prima gli svizzeri”.
Così eccoci alla comparsa di una figura melliflua quanto inquietante. Quel James Schwarzenbach che diverrà l’esponente di punta del partito di estrema destra Nationale Aktion, grazie a lui entrato in Parlamento alla metà degli anni ’60. Con lui, colto e ricco rampollo di una delle famiglie industriali della Svizzera, verrà sdoganata quella odiosa xenofobia che, ovviamente, non ha il coraggio di definirsi tale. Nei suoi discorsi, il razzismo si ammanta di un improbabile quanto distorto anticapitalismo che gli “stranieri” andrebbero a implementare con il loro lavoro e con il conseguente ulteriore sviluppo industriale. Con la conseguente perdita di purezza, identità e idilliaca bellezza paesaggistica.
In questo sconclusionato ma ahimè articolato programma, la vita degli emigrati italiani è sempre più difficile. Concetto Vecchio ne ricostruisce la storia attraverso un rigoroso e documentato lavoro di archivio, tra notizie in rete, ritagli di giornale e testimonianza dirette. Il quadro che ne esce è quello di sconquassi personali e familiari, di emarginazione e di rancori montati ad arte da una politica che, allora come ora, ha bisogno della paura, del nemico, dell’Altro che viene per sovvertire ordine, disciplina e valori.
Sono pagine, queste di Cacciateli, che rappresentano davvero quello che può definirsi un libro definitivo sull’argomento. E non perché non vi sia bisogno di aggiungere altro ma perché fotografa, senza retorica ma anche senza ideologia, ciò che accade quando lo straniero diventa il piattello di un tiro incrociato di politica e propaganda. E non solo della destra. Interessante leggere di come mentre la destra si faceva portavoce del populismo più bieco, andando a coagulare attorno a sé le istanze degli strati più “bassi” della popolazione, con la complicità degli stessi sindacati, la sinistra galleggiasse nelle stesse sabbie mobili della xenofobia in cui, a fare da eccezione, erano proprio gli imprenditori capitalisti che avevano bisogno della manodopera italiana. In questo guazzabuglio di strumentalizzazioni e interessi comunque di parte, gli italiani erano manodopera, non esseri umani.
Storia di una difficile convivenza, storia di una xenofobia che, pur non volendo mettere tutto nello stesso calderone, si nutriva e si nutre sempre, nella Svizzera di quegli anni come nell’Italia di oggi, delle stesse parole, delle stesse semplificazioni. E, allora, gli stranieri diventano il parafulmine di disagi complessi. Basterebbe, per cominciare, ricordare che in quegli anni gli stranieri siamo stati noi.
Ciò che colpisce, se non di più certo non meno di tutto il resto, di questo bellissimo viaggio nella memoria storica e personale dell’autore, è il richiamo finale di sua madre: “Non scrivere male della Svizzera. […] “Perché adesso da vecchia, ne serbo un buon ricordo. Mi ha emancipato. Tutto quello che sono l’ho imparato in quegli anni lì. Se fossi rimasta al paese oggi avrei una pensione miserabile, questo ti è chiaro vero?” […] “Non abbiamo solo lavorato, abbiamo anche vissuto. Guarda la Sicilia invece: è rimasta quella di sempre, i giovani emigrano.”
Forse il senso più vero di tutto il libro è, amaramente, questo.
 Cacciateli. Quando i migranti eravamo noi
Cacciateli. Quando i migranti eravamo noi
Reportage, inchiesta
Feltrinelli
2019
189 p., brossura