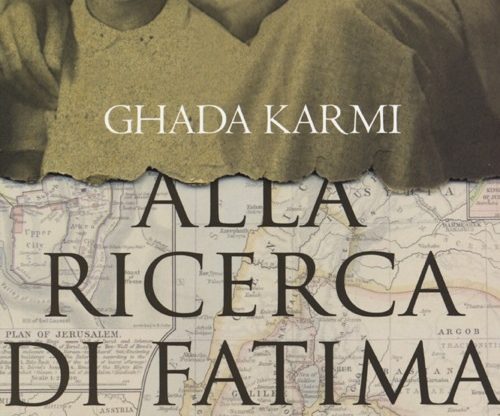Di Paolo Massimo Rossi
“Papà baciò anche me e Shiram, mentre alla mamma strinse solo la mano. Il nonno li guardava: a quel tempo non era consuetudine che le coppie, anche se sposate, si baciassero in pubblico. Non ho idea di come si sentisse durante quei saluti, ma ricordo i suoi occhi umidi. Quelle lacrime, mi chiedo oggi, erano per noi o perché era costretto a lasciare le sue radici e i ricordi della Palestina e temeva di perderli per sempre?”
Ghada Karmi racconta la propria vita dall’infanzia al 1998.
Ma narra anche la storia della Palestina in quegli stessi anni.
L’una e l’altra – in realtà mai scisse nel racconto – viste attraverso gli occhi e i ricordi di Ghada bambina e vissute poi da adolescente e donna ormai emigrata in Inghilterra.
Ghada nasce nel 1939 nella città vecchia di Gerusalemme, terzogenita in una famiglia della borghesia palestinese.
Il padre è un intellettuale che lavora per il Ministero dell’Istruzione occupandosi, essenzialmente, di traduzioni e trasmissioni radio in lingua inglese per la popolazione del paese.
La madre, casalinga, gestisce il menage familiare con modalità non dissimili da quelle caratteristiche di un normale nucleo europeo.
Ghada ha una sorella, Siham, e un fratello Zihad, che svolgono ruoli di altalenante importanza nella sua vita. A volte come affettuoso sostegno parentale, altre come dicotomica contrapposizione nelle rispettive e diverse prese di coscienza.
I genitori non vengono identificati con i nomi propri di famiglia ma, in accordo con la tradizione araba, con i prefissi Abu per il padre e Um per la madre, seguiti dal nome del figlio maschio: quindi Abu Zihad e Um Zihad. Emblematizzazione di una cultura di forte stampo maschilista che prefigura, in grandi linee, i destini delle persone in funzione del sesso.
Ghada e la famiglia subiscono quella che si può giustamente connotare come una vera e propria occupazione della terra palestinese da parte di ebrei provenienti da diversi paesi europei, soprattutto Russia e Polonia.
Sorta di diaspora all’incontrario, quella degli ebrei, che trova un drammatico contraltare nell’espulsione (diasporica) della popolazione araba verso il mondo occidentale.
Il racconto di Ghada segue con crescente drammatizzazione l’incrociarsi di destini di due popoli che, diversi per lontananza e modi di vivere, diventano via via caratteristici di una convivenza conflittuale sempre più drammatica. Per sfociare, infine, in una guerra che provocherà – tragedia storica epocale – la fuga e la diaspora del popolo palestinese.
Gli anni dell’infanzia di Ghada sono caratterizzati da attentati (tristemente famoso quello dell’Hotel Semiramis compiuto dagli israeliani dell’Haganà), dall’abbandono della Città Vecchia per Qatamon e, infine, per Damasco, ospiti lei e la famiglia del nonno materno.
Le difficoltà di lavoro del padre creano, e impongono, le condizioni per un definitivo trasferimento a Londra nel 1949. Quando Ghada ha dieci anni e si appresta ad affrontare il periodo decisivo della sua formazione scolastica ed esistenziale.
E qui compare la prima frattura nel modo di vivere della bambina, diventata ormai adolescente.
Ghada ha bisogno di una nuova idendità, non soltanto in senso residenziale, ma anche, e soprattutto, in senso psicologico e affettivo.
L’atteggiamento vagamente elitario del padre – che vive come un intellettuale che si pone al di sopra dei problemi contingenti del quotidiano –, la sua scelta di adesione a valori propri di un apolide di terre e di culture e il suo atteggiamento di quasi annoiato fatalismo politico, privano Ghada, almeno nelle evidenze narrative, di una vera presenza paterna.
Analogamente, il rifiuto della madre nei confronti dei modi di vivere inglesi – se non nei saltuari aspetti amicali di vicinato – che la spingono sinanche al rifiuto di apprendere la lingua del nuovo paese, separano Ghada da quell’ ambiente familiare che era stato, in Palestina, rifugio e calore affettivo. Ambiente che si trasforma, col tempo, nel ricordo elegiaco di una sorta di Eden perduto.
Ghada si impone, con ferrea determinazione, di “diventare“inglese, abbracciando, anche acriticamente, usi e costumi di questa nuova patria.
Studia medicina; si laurea (nel 1964) e sposa John (nel 1967), un collega medico inglese di mentalità tradizionalista, anche se intellettualmente disposto a comprendere il diverso da sé. Sino a convertirsi alla religione Islamica.
E qui si pone un primo interrogativo. La conversione religiosa di John viene presentata come avvenimento di relativa importanza, privo di drammaticità, quasi un accadimento di banale quotidianità.
Il matrimonio finisce, ovviamente, con un divorzio.
Con soddisfazione manifesta della madre Um Zihad che aveva, a suo tempo, ostacolato, con matriarcale saggezza, quell’unione e con una non specificata indifferenza paterna sulla quale (ed ecco una successiva perplessità) Ghada non si dilunga. Necessità di comprimere il racconto in termini di lunghezza? Criptato rifiuto dell’antica cultura palestinese che, solo superficialmente, sembrava accettato? In realtà l’autrice non ci fornisce un’analisi. Anche se le antiche radici culturali continuano ad aleggiare nell’atmosfera del racconto.
D’altra parte, anche il marito sembra non abbia lasciato tracce salienti nella vita di Ghada. E, anche qui, manca un’analisi approfondita di un avvenimento che con difficoltà si riesce ad accettare come di irrilevante importanza.
Supposizione (non avallata da considerazioni esplicitate in modo chiaro nel racconto): il marito appartiene a un mondo da abbandonare così come era stato fatto per quello delle origini?
Con gli anni Ghada sembra acquistare, ad ogni modo, una coscienza più profonda di sé. Il mondo della Palestina che sembrava essere stato posto in un pallido dimenticatoio, torna a farsi strada nel suo animo attraverso la presa di coscienza del dramma dell’espulsione. Delle sofferenze e della diaspora moderna dei palestinesi che assumono valenza di allegoria (e mi si perdoni l’uso di un termine che solo apparentemente può apparire eufemistico, essendo, invece, carico di una tragedicità necrofora e alienante) di quella sionista imposta dall’Imperatore romano Tito nel 69 D.C..
Ma, come spesso nel romanzo, la sovrapposizione della vicenda personale di Ghada con quella storica della Palestina, a fronte di un desiderio evidente dell’autrice di farne l’una pregnanza dell’altra, finisce per rappresentare, invece, una reciproca condizione al contorno dei due aspetti, mancando, di conseguenza, un vero approfondimento critico o narrativo di entrambe.
In questo senso l’autrice paga il pedaggio, strettamente letterario in realtà, di una duplice e conflittuale tendenza.
A momenti nei quali assume una posizione extradiegetica per porsi al di là dell’universo narrato, si succedono altri momenti in cui l’atteggiamento diventa intradiegetico mediante l’io narrante all’interno del testo.
La sovrapposizione, se da un lato poteva ben rappresentare la cifra caratteristica della storia, dando a questa una valenza umana e letteraria, da un altro – e a causa di elementi troppo in fretta glissati nell’andamento narrativo – finisce per rendere poco significante e piuttosto superficiale l’approfondimento degli episodi.
Resta Fatima. Personaggio solo superficialmente caratterizzato nella prima parte del libro (quasi secondario rispetto al cane Rex e tanto più incomprensibilmente visto il titolo del romanzo) che si vorrebbe adombrare come metafora della ricerca: non di una persona ma di un paese e, ancor più, di una radice.
E, in tal senso, Ghada Karmi riesce (in questa fase e finalmente in modo chiaro e poetico) a far intuire come il suo ritorno in Palestina alla ricerca di Fatima sia, in realtà, la ricerca di sé e delle sue origini.
Ma, ancora, a momenti di lirismo evidentemente propri di una nostalgia del ritorno, si sovrappongono elementi di cronaca troppo rapidamente liquidati a favore, credo, di necessità editoriali.
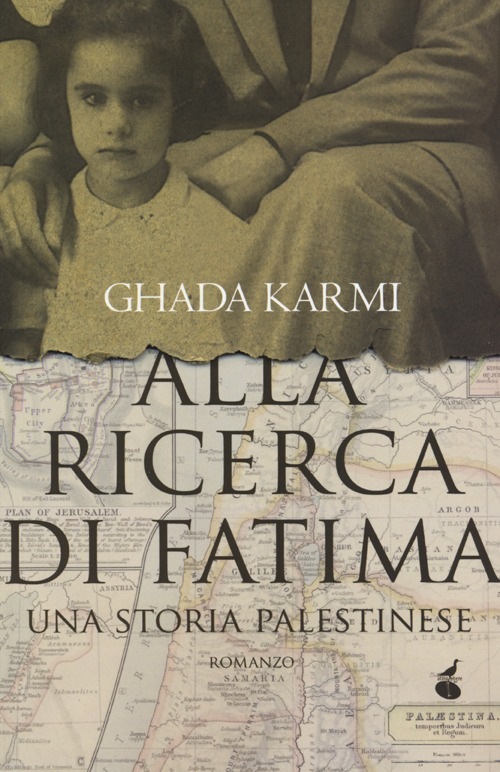 Alla ricerca di Fatima. Una storia palestinese
Alla ricerca di Fatima. Una storia palestinese
Letteratura
Atmosphere Libri
2013
414 p,