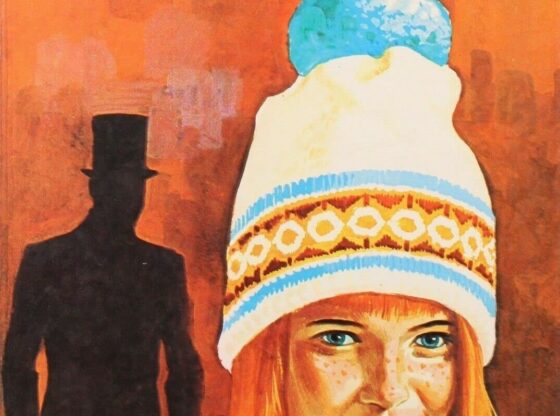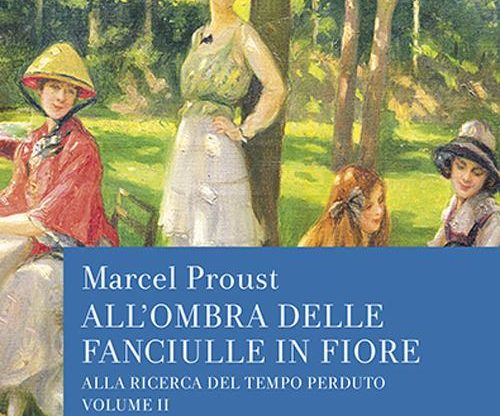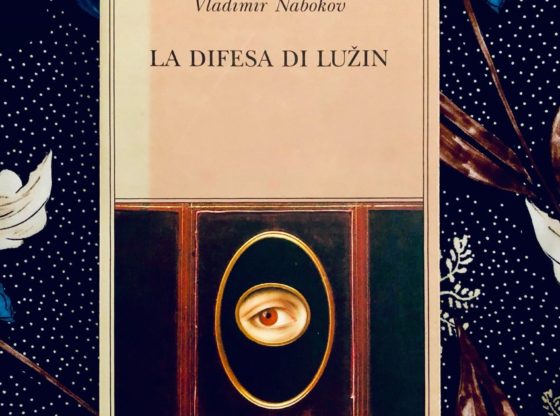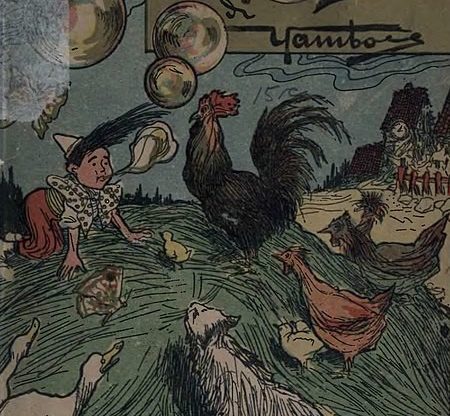Dante e Ariosto reinterpretano Virgilio: Pier delle Vigne, Astolfo, Polidoro e il ramo spezzato.
Di Graziella Enna
Un episodio dell’Eneide molto particolare, che ha ispirato Dante e Ariosto, è situato nel III libro, quando Enea, con un’ampia analessi, sta raccontando alla regina Didone il periglioso ed odissiaco viaggio che l’ha condotto fino a Cartagine. I Troiani, approdati nella Tracia, prima tappa delle loro peregrinazioni, decidono di allestire dei sacrifici, perciò Enea vedendo un boschetto di piante di mirto, sacre a Venere, ne vuole raccogliere alcune fronde ma un terribile prodigio lo lascia attonito e raggelato.
“Appena sradicai la prima pianta, da essa uscì del sangue nero, che macchiò la terra intorno. Un terrore mi raggelò il corpo, anche il mio sangue si gelò dalla paura. Mi accinsi così a sradicare un altro ramo, cercando di capire la provenienza di quel sangue, e di nuovo le gocce colano nere dalla corteccia spezzata. […]
Ma mentre, con sforzi maggiori, mi accingevo ad assalire un terzo ramo e lottavo contro la terra che lo vuole trattenere facendo leva sulle ginocchia, sentii provenire dal cespuglio un gemito implorante, una voce che disse: ” Perché mi ferisci, Enea? Abbi pietà per chi è stato sepolto; non macchiarti le mani, oneste, di sangue. Non sono uno straniero, ma un troiano, e il sangue che vedi non esce dal legno. Scappa da questa terra crudele, da queste spiagge! Io sono Polidoro. Qui mi ha colpito una moltitudine di frecce e poi è cresciuta con radici resistenti e gemme sottili.”
Mi stupii, assalito da un dubbio spaventoso, mi si rizzarono i capelli e mi si strozzò la voce in gola.”
Polidoro era uno dei figli di Priamo, che egli aveva voluto salvare dalla furia dei Greci, inviandolo dal re della Tracia con molto oro e denaro. Ma purtroppo il re trace Polimnestore, disattese le aspettative di Priamo ed uccise Polidoro dopo la distruzione di Troia e si alleò con i Greci vittoriosi. Il suo corpo trafitto dai dardi rimase insepolto e si imprigionò in un mirto. Celeberrimo e’ il verso in cui si deplora la cupidigia umana:
“Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra
fames”
“Maledetta febbre dell’oro, a che non costringi gli animi mortali! “
Polidoro viene dunque ucciso a tradimento e i Traci si impossessarono delle sue ricchezze: Enea, sconvolto dal prodigio del cespuglio che parla e gronda sangue, compie l’unico gesto che la sua pietas gli suggerisce: dare una degna e onorata sepoltura al giovane sfortunato e compiere le necessarie libagioni per dare finalmente pace eterna alla sua anima.
I legami tra questo episodio e Dante sono soprattutto dati dalla presenza del cespuglio che parla e gocciola sangue, ma in realtà l’atmosfera dantesca è molto differente, Dante vi si ricollega direttamente nella selva dei suicidi, nel canto XIII dell’Inferno, il cui protagonista, come e’ ben noto e’ il suicida Pier delle Vigne. Il canto si apre, dopo i primi versi, con una cupa ed inquietante descrizione, caratterizzata da numerose antitesi, della sinistra selva in cui non c’erano fronde verdi ma di colore scuro, non rami dritti ma nodosi e contorti, non c’erano frutti ma spine con veleno.
Non fronda verde, ma di color fosco;
non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti;
non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco.
Io sentia d’ogne parte trarre guai
e non vedea persona che ’l facesse;
per ch’io tutto smarrito m’arrestai. 24
Cred’ïo ch’ei credette ch’io credesse
che tante voci uscisser, tra quei bronchi,
da gente che per noi si nascondesse. 27
Però disse ’l maestro: “Se tu tronchi
qualche fraschetta d’una d’este piante,
li pensier c’ hai si faran tutti monchi”. 30
Dante sente da ogni parte dei lamenti ma, non vedendo nessuno, si ferma confuso. Con un poliptoto verbale (cred’io ch’ei credette ch’io credesse) esprime il suo smarrimento. Egli pensa che Virgilio abbia creduto che lui avesse la convinzione che tante voci provenissero da genti nascoste, per cui il maestro lo invita a spezzare un ramoscello, gesto con il quale avrebbe dissipato ogni suo dubbio.
Allor porsi la mano un poco avante
e colsi un ramicel da un gran pruno;
e ’l tronco suo gridò: “Perché mi schiante?”. 33
Da che fatto fu poi di sangue bruno,
ricominciò a dir: “Perché mi scerpi?
non hai tu spirto di pietade alcuno? 36
Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:
ben dovrebb’esser la tua man più pia,
se state fossimo anime di serpi”. 39
Dante spezza un ramoscello da un cespuglio spinoso ed il tronco gli gridò di avere pietà di lui e di non straziarlo, perché un tempo tutto quei cespugli furono uomini ed ora erano stati mutati in sterpi, seppure fossero stati serpi la mano di Dante avrebbe dovuto mostrare pietà. Le dolorose parole di Pier sono molto simili a quelle di Polidoro.
S’elli avesse potuto creder prima”,
rispuose ’l savio mio, “anima lesa,
ciò c’ ha veduto pur con la mia rima, 48
non averebbe in te la man distesa;
Virgilio stesso aggiunge che Dante avrebbe dovuto credere a ciò che egli aveva esposto nel suo poema, riferendosi chiaramente all’episodio di Polidoro. Ma mentre Polidoro esorta Enea a compiere un gesto improntato alla pietas, perciò di carattere religioso, Dante invece viene invitato ad un’umana pietà. I cespugli danteschi emettono lamenti continui perché vengono lacerati dalle brutte arpie, creature mostruose sempre di ascendenza virgiliana, che nidificano sui loro rami, lacerandoli di continuo. Le arpie dantesche sono del tutto simili a quelle presenti nel III canto dell’Eneide, in cui Enea e i Troiani si imbattono nelle terribili e sozze donne-volatile che preannunciano loro funeste profezie.
Pier delle Vigne dà vita all’episodio di cui è protagonista narrando la sua triste vicenda e desidera che la sua memoria venga rinverdita e riabilitata da Dante una volta che egli tornerà in terra. Troppe infamie, infatti, gravavano sulla sua esistenza terrena, ma finalmente il Poeta diventerà depositario della verità su Piero compiendo un atto di giustizia nei suoi confronti. La causa della sua rovina fu l’invidia (così come la causa della morte di Polidoro fu la bramosia di ricchezza), che è fonte di ogni male dal suo punto di vista. Inizia così Pier delle Vigne:
Io son colui che tenni ambo le chiavi
del cor di Federigo, e che le volsi,
serrando e diserrando, sì soavi, 60
che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi;
fede portai al glorïoso offizio,
tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e ’ polsi.
Era dunque il segretario speciale dell’imperatore Federico secondo di Svevia, Pier delle Vigne e esprime questo suo ufficio così elevato con l’espressione ricercata delle chiavi che aprono e chiudono il cuore dell’ imperatore. Ma tale compito fiduciario, portato avanti con estremo zelo, fu così gravoso che gli fece perdere il sonno e la vita. Prosegue poi delineando la causa che lo fece cadere in disgrazia:
La meretrice che mai da l’ospizio
di Cesare non torse li occhi putti,
morte comune e de le corti vizio, 66
infiammò contra me li animi tutti;
e li ’nfiammati infiammar sì Augusto,
che ’ lieti onor tornaro in tristi lutti. 69
Con la metafora della meretrice dagli occhi sfrontati descrive l’invidia, peggiore vizio e rovina delle corti, che infiammò gli animi dei cortigiani, che a loro volta alimentarono il germe del sospetto nell’animo dell’imperatore così egli cadde in disgrazia. Anche qui il linguaggio è piuttosto artificioso con l’uso di ripetizioni, del poliptoto (infiammò. Infiammati, infiammar) e dell’antitesi (lieti onori vs tristi lutti). Da qui la tremenda risoluzione del segretario speciale:
L’animo mio, per disdegnoso gusto,
credendo col morir fuggir disdegno,
ingiusto fece me contra me giusto. 72
Per le nove radici d’esto legno
vi giuro che già mai non ruppi fede
al mio segnor, che fu d’onor sì degno. 75
E se di voi alcun nel mondo riede,
conforti la memoria mia, che giace
ancor del colpo che ’nvidia le diede
Egli compie un gesto innaturale ed è consapevole del grave peccato che sta compiendo privandosi della vita e condannandosi per l’eternità, nonostante la sua innocenza, diviene ingiusto. Ma l’accorata preghiera rivolta a Dante è quella di narrare la verità sul suo conto cioè la fedeltà assoluta nei confronti del sovrano di cui conserva immutata la stima, nonostante la sua condizione deteriore di arbusto spinoso e infernale dalle recenti radici, contrappasso terribile a cui è stato condannato per essersi privato del dono prezioso della vita. A questo punto l’anima tace, ma Virgilio, su richiesta di Dante, troppo rattristato per porre altre domande, chiede a Piero come le anime si leghino ai cespugli. Anche qui troviamo un’analogia con l’anima di Polidoro che spiega come si era inglobata al mirto con la motivazione di essere rimasta insepolta. Le anime dei suicidi vengono letteralmente scagliate, dopo il giudizio di Minosse, nel settimo cerchio, dove germogliano facilmente, come semi di graminacee e divengono piante selvatiche tormentate continuamente dagli artigli delle Arpie che vi nidificano e ne mangiano le foglie. Dopo il Giudizio universale esse non potranno riavere il loro corpo, come tutti gli altri dannati, ma lo vedranno appeso al loro triste cespuglio visto che volontariamente se ne sono private.
Quando si parte l’anima feroce
dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta,
Minòs la manda a la settima foce. 96
Cade in la selva, e non l’è parte scelta;
ma là dove fortuna la balestra,
quivi germoglia come gran di spelta. 99
Surge in vermena e in pianta silvestra:
l’Arpie, pascendo poi de le sue foglie,
fanno dolore, e al dolor fenestra. 102
Come l’altre verrem per nostre spoglie,
ma non però ch’alcuna sen rivesta,
ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie. 105
Qui le strascineremo, e per la mesta
selva saranno i nostri corpi appesi,
ciascuno al prun de l’ombra sua molesta.
Ariosto nel sesto canto dell’Orlando Furioso, si rifà direttamente all’episodio dantesco, ma in atmosfera completamente diversa e, soprattutto, l’essere umano diviene vegetale solo in modo temporaneo a causa di un incantesimo. Ruggiero mentre vola sull’alato ippogrifo, si ferma in un’amena selva attirato dalla sua bellezza. Ruggiero conduce a terra l’ippogrifo e, temendo di perderlo, decide di legarlo ‹‹ a un verde mirto in mezzo un lauro e un pino ››, ma, spaventato da rumori lontani, si agita e spezza un ramo del mirto, palesando così la vera natura dell’albero.
canto VI, ottave 28 e 29
Onde con mesta e flebil voce uscìo
Espedita e chiarissima favella,
E disse: — Se tu sei cortese e pio,
Come dimostri alla presenza bella,
Lieva questo animal da l’arbor mio:
Basti che ’l mio mal proprio mi flagella,
Senza altra pena, senza altro dolore
Ch’a tormentarmi ancor venga di fuore. —
Al primo suon di quella voce torse
Ruggiero il viso, e subito levosse;
E poi ch’uscir da l’arbore s’accorse,
Stupefatto restò più che mai fosse.
A levarne il destrier subito corse;
E con le guance di vergogna rosse:
— Qual che tu sii, perdonami (dicea),
O spirto umano, o boschereccia dea.
Ruggiero ode le parole del mirto che lo esortano a essere commiserevole e a allontanare l’animale perché gli bastano già le sue afflizioni e non ne vorrebbe altre. Perciò egli, voltatosi stupito, con il viso rosso di vergogna, corse subito a spostare il fatato destriero. Poi chiede notizie al mirto, che narra la sua vicenda. Si tratta di Astolfo, cugino di Orlando e Rinaldo fatto prigioniero dalla maga Alcina che arse d’amore per lui, ricambiata, essendo lei molto bella.
Completamente perso nei piaceri, Astolfo diviene il suo unico amante, dimentico
di tutto, finché la maga improvvisamente rivolge il proprio cuore altrove,
caccia Astolfo e lui scopre che nella sua stessa situazione ci sono altri mille
amanti, trasformati in alberi, animali, fonti per evitare che vadano in giro
per il mondo a raccontare le abitudini della maga. Solo grazie alla fata
Logistilla riprende sembianze umane e fugge con Ruggiero. Ecco il racconto
di Astolfo sulla sua trasformazione in cespuglio.
Quando credea d’esser felice, e quando
credea ch’amar piú mi dovesse Alcina,
il cor che m’avea dato si ritolse,
e ad altro nuovo amor tutta si volse.
50
Conobbi tardi il suo mobil ingegno,
usato amare e disamare a un punto.
Non era stato oltre a duo mesi in regno,
ch’un novo amante al loco mio fu assunto.
Da sé cacciommi la fata con sdegno,
e da la grazia sua m’ebbe disgiunto:
e seppi poi, che tratti a simil porto
avea mill’altri amanti, e tutti a torto.
51
E perché essi non vadano pel mondo
di lei narrando la vita lasciva,
chi qua chi lá, per lo terren fecondo
li muta, altri in abete, altri in oliva,
altri in palma, altri in cedro, altri secondo
che vedi me su questa verde riva;
altri in liquido fonte, alcuni in fiera,
come piú agrada a quella fata altiera.
Ariosto dunque, parte da un episodio analogo ma lo rinnova e lo rielabora
dandone una connotazione completamente diversa dal suo modello Dante, abbandona
infatti la descrizione cupa ed oscura della selva dei suicidi ed inserisce la
scena in un locus amoenus dai connotati magici.