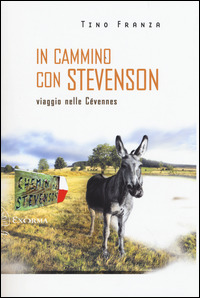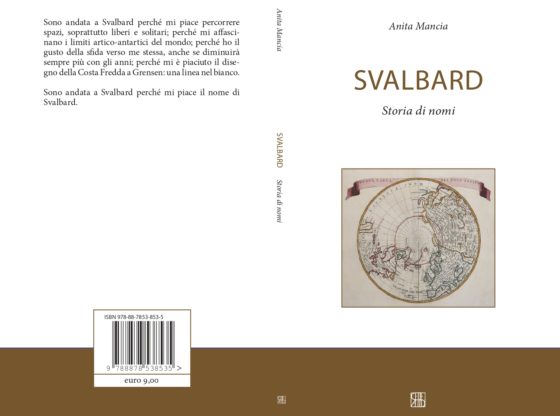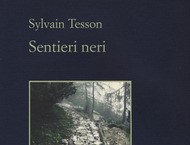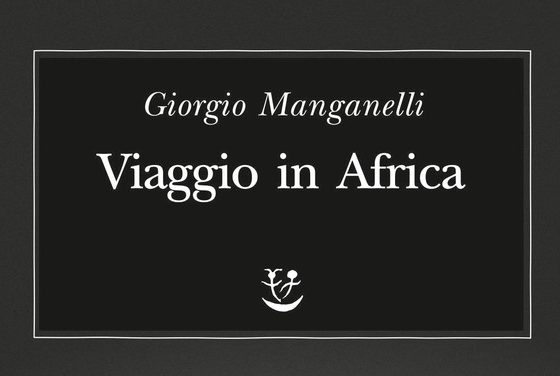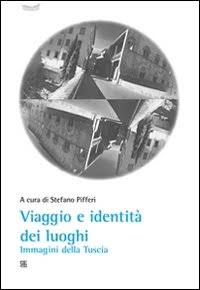Di Geraldine Meyer
Qual è il filo conduttore tra il terremoto che ha ferito e squarciato i nostri Appennini e l’Europa? Come arginare l’olente brezza razzista che sta avvolgendo il nostro continente sempre più spinto verso un’estrema e devastante balcanizzazione? Quali sono le autentiche radici cristiane d’Europa, quelle profonde, non quelle sbandierate da politici in perenne campagna elettorale? Domande, tante domande a cui Paolo Rumiz cerca di dare risposte in questo magnifico Il filo infinito. E, una di queste risposte, forse la risposta, è San Benedetto, la cui statua, risparmiata dalla devastazione di Norcia, ha dato inizio al dialogo interiore tra lo scrittore e il santo, patrono d’Europa.
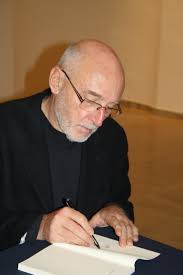
Un filo conduttore che conduce Rumiz in un viaggio inevitabilmente non solo geografico, alla ricerca dei seguaci di quei benedettini che salvarono l’Europa con la sola forza della fede e che lo fecero quando le invasioni non erano quelle presunte, dei disperati di oggi. Quando le distruzioni che seguirono la caduta dell’Impero Romano erano spietate. E come lo fecero? Con l’esempio, con la sobrietà di quel ora et labora che rappresenta la cifra della regola benedettina.
Rumiz insegue questa cultura, questa onda di fede che salvò, letteralmente, la millenaria cultura europea, anche attraverso la cura del territorio, soprattutto quello abbandonato, proprio come il nostro attuale Appennino. Ed ecco che si fa via via più chiaro e indissolubile il legame tra devastazioni passate e presenti, facendosi più chiara anche la grandiosa attualità e urgenza del messaggio benedettino, portato avanti, in abbazie e monasteri, da uomini e donne che non si arrendono al moderno, che continuano a combattere perché le vere radici cristiane, che sono solidarietà e accoglienza, tornino ad essere argine alla barbarie.
Paolo Rumiz, con questo Il filo infinito, ci porta con sé nel suo viaggio tra abbazie e monasteri, dall’Atlantico al Danubio passando, per forza, dall’Italia, anzi proprio dall’Italia partendo. Da quel centro, geografico e culturale, che sono i nostri Appennini, così carichi e gravidi di spiritualità, di fede antica.

Quello di Rumiz è un viaggio alle radici dell’Europa e di un monachesimo non a caso inviso alla Chiesa cattolica e alle gerarchie ecclesiastiche, non tolleranti verso quella fede così carnale in fondo, così impregnata di natura e di meraviglia e rispetto per il mondo. Come tollerare la meravigliosa fede che considera preghiera anche “godere di un tramonto mentre si beve un bicchiere di buon vino”, come tollerare una fede che non solo non disdegnava ma, addirittura, esaltava il femminile delle cose, il femminile della terra, dell’acqua e di tutto ciò che da vita?
Ecco perché la ricerca di Rumiz non è solo rivolta al passato ma, ancor più, all’attualità e all’urgenza del messaggio e dell’esempio benedettino, che accoglie con letizia, che apre i cuori con lo “zelo buono”, che rispetta le differenze, che ha realizzato tra i primi, l’autentico portato della democrazia. Un messaggio che suona come una scialuppa di salvataggio in giorni in cui l’Europa si sta disgregando, e disgregandosi si lascia incantare dai pericolosi pifferai magici che ne vogliono fare una fortezza murata. Murata perché divisa. Anacronistica visione di chi dimentica che, da sempre, l’Europa è terra di migrazioni e di approdo.
Un libro potente e disperato, di quella disperazione lucida che non si rassegna, che, quasi con un ossimoro, ancora spera, ma spera fattivamente. L’attualità di San Benedetto viene qui cercata e portata alla luce come faro, per tornare all’essenza, alla sobrietà di un concetto fondamentale che è quello della cura, del prendersi cura di persone e cose, di uomini e donne ma anche della natura e del paesaggio. Non a caso Rumiz insiste sulla peculiarità europea, rappresentata proprio dal paesaggio, in cui, più che altrove, la cura ha dato vita a un abbraccio rispettoso tra natura e mano dell’uomo. Una cura che è andata ormai persa, come quella verso la vita.
Tutto si tiene in questo libro e tutto si tiene nell’eredità dei benedettini, che è eredità di esempio e di gesti, eredità di quel filo infinito rappresentato dalle abbazie, legate l’una all’altra da una voce, da un canto. Da quei canti gregoriani che diventano una preghiera. Mancano, sempre più, purtroppo, le orecchie che ascoltino questa preghiera. In fondo, come scrive Rumiz, si può fare se si pensa che: “Cosa hanno fatto i monaci di Benedetto se non piantare presidi di preghiera e lavoro negli spazi più incolti d’Europa per poi tessere tra loro una salda rete di fili?” E la parola incolti è esattamente la parola chiave, nel suo doppio significato di terra e anime.
 Il filo infinito
Il filo infinito
Letteratura di viaggio, spiritualità
Feltrinelli
2019
174