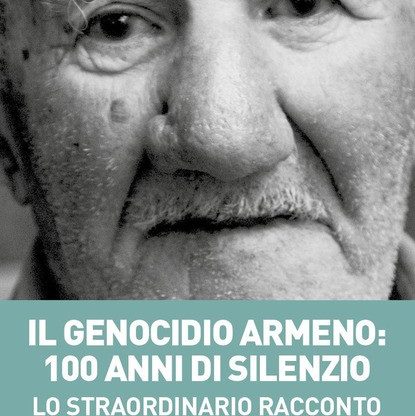Di Graziella Enna
Articolo apparso sulla rivista Euterpe nel numero 29 di luglio 2019
Per quasi un secolo, la realtà del genocidio armeno, (Metz Yeghérn, “il grande male”), perpetrato a partire dal 1915 da parte dei Turchi, è stata occultata e fatta cadere nell’oblio da un inspiegabile negazionismo che ha tentato di seppellire una seconda volta le vittime negli aridi luoghi desertici e inospitali che furono i muti testimoni delle terribili deportazioni. Il grido possente e assordante di tutte le vittime è stato più forte e ha vinto: a Erevan, capitale del piccolo stato armeno, che resta dell’immenso territorio di un tempo lontano, oggi, sorgono un monumento celebrativo eretto nel 1967 e il Museo del Genocidio nato nel 1995 da un’enorme mole di documenti e testimonianze pronti a dar voce alla verità negata. Ai monumenti materiali si aggiunge l’immortalità delle pagine letterarie che, tramite toccanti e splendide opere scaturite dalla memoria dei discendenti o dalla rielaborazione di fatti realmente accaduti, hanno narrato le storie di tante vittime: del resto non potrebbe essere altrimenti, perché come tutte le verità scomode, questa tragedia ha bisogno di essere urlata al mondo intero.
Nell’ormai sfilacciato Impero Ottomano, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, iniziarono a serpeggiare forti ideologie nazionaliste alimentate dal movimento dei “Giovani Turchi” rappresentati dal partito “Ittihad ve Terakki” (Unione e Progresso), che miravano a fondare un potente stato per allinearsi alle potenze occidentali e a eliminare ogni minoranza presente nel loro territorio, soprattutto quella armena, cristiana, ritenuta particolarmente dannosa, perché costituiva un ponte ideale con l’occidente e ostacolava le mire espansionistiche propugnate dalle ideologie del panturanismo. Chi oggi è considerato il padre dei Turchi, Mustafà Kemal Atatürk aveva affermato che “l’unico armeno buono è quello morto”, instillando così una smisurata intolleranza negli animi dei compatrioti. Iniziò così una sistematica eliminazione sotto la regia occulta della Germania e del cosiddetto triumvirato dei paṣa Enver, Talaat e Djemal, con l’intenzione di colpire, in primis, per motivi politici, l’élite armena, formata da dirigenti, intellettuali, sacerdoti, professionisti, ma in seconda istanza per razziarne beni, ricchezze e terre. Iniziarono così le stragi, cui seguirono le deportazioni sistematiche, in varie parti della Turchia, delle comunità armene costrette a estenuanti marce verso campi di concentramento che in realtà erano luoghi desertici verso cui si dirigevano le colonne di disperati che morivano di fame, sete e stenti, ma occorsero anche episodi di resistenza. Questi eventi sono narrati in diversa maniera in due delle opere di cui vorrei parlare, prescelte tra una larga messe disponibile sull’argomento: “La masseria delle allodole”e “I quaranta giorni del Mussa Dagh”, mentre l’altra, ”Mayrig”, narra altri aspetti della diaspora in Europa e il genocidio vissuto nei ricordi.
Una sequenza cinematografica tratta da “Mayrig”, film del regista Hernry Verneuil, (alias Achod Malakian), traspone la vicenda narrata nell’omonimo libro autobiografico, ci presenta in un teatro parigino, dopo che il sipario è calato sulla prima di un’opera di un autore franco armeno, un anziano signore seduto in platea, solo: suo padre. L’autore estrae da un prezioso cofanetto un antico flauto armeno e glielo porge, si siede accanto a lui e chiude gli occhi: la sala si riempie delle calde, intense e suggestive note di un motivo tradizionale e in quel momento, passato e presente si fondono, uniti dalla musica che riecheggia nelle volte del teatro e sembra far rinascere tutto lo spirito mai estinto nei due personaggi, retaggio della cultura millenaria un popolo pacifico, laborioso e mite che la violenza dei Turchi aveva voluto estirpare con inaudita efferatezza.
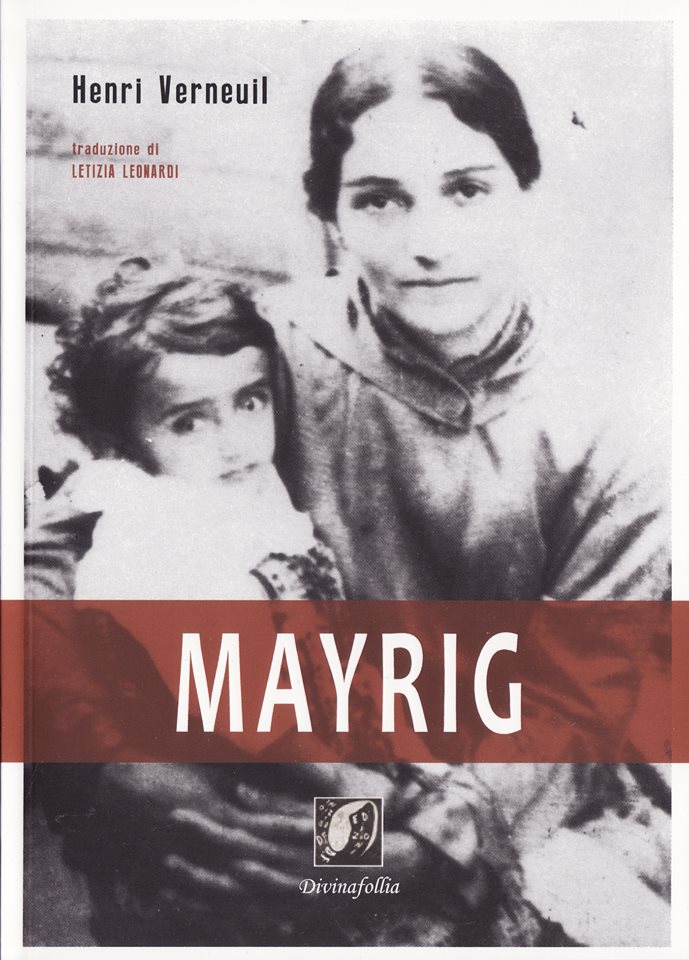
Il romanzo Mayrig, (parola, che in armeno significa mamma), è ambientato a Marsiglia alcuni anni dopo il genocidio: si apre con il protagonista, Achod, che raccoglie gli ultimi respiri della sua Mayrig morente, pilastro portante di tutta la narrazione. Da qui prende le mosse, una lunga analessi con cui egli ripercorre le tappe della sua formazione in una dimensione intimistica di una dolcezza disarmante: rivive in ogni pagina la profonda umanità dei singoli membri della famiglia, che, oppressi dai ricordi e dalle traversie del loro popolo, in ogni gesto quotidiano fanno rivivere il loro spirito identitario, nonostante una vita umile e faticosa abbia sostituito quella precedente di persone appartenenti a un ceto sociale medio – alto, come del resto la maggior parte degli Armeni deportati o sradicati. Un elemento fondamentale contraddistingue la famiglia protagonista di Mayrig: la mancanza assoluta di odio, sostituito da un dolore composto e dignitoso, la metabolizzazione di una sofferenza che lacera l’animo che è celata in modo eroico per amore del figlio di quattro anni, Achod, che deve crescere incontaminato, senza conoscere l’ingiustificata e selvaggia violenza che ha oppresso il suo popolo. Il libro evidenzia che i genocidi hanno anche un dopo che è doloroso quanto il prima e il durante, perché è la summa di tutte le angherie e le sopraffazioni vissute, cui si aggiunge la condizione di apolidi profughi in nuovi ambienti sociali in cui aleggiano la discriminazione e la malcelata insofferenza nei confronti del diverso e dello straniero giunto da terre lontane, elementi questi quanto mai attuali e che colpiscono il lettore di Mayrig. Ci troviamo di fronte anche al romanzo di formazione del piccolo Achod sorretto dall’amore della sua famiglia che si sacrifica in tutti i modi pur di garantirgli un’esistenza e un futuro che divenga un riscatto per tutti loro che tentano di rinsaldare, nel microcosmo familiare, i valori dell’intero popolo ferito e disgregato. Dal suo canto, Achod, nonostante sia continuamente emarginato, fin dall’infanzia, subisce in silenzio per non deludere la sua famiglia. Divenuto adulto, avrà quel riscatto tanto agognato per lui e realizza l’entità dell’amore che gli è stato donato incondizionatamente insieme con i valori del suo popolo, che aveva sempre compreso, ma in certe occasioni, quasi rinnegato per uniformarsi all’ambiente francese. In una struttura circolare il romanzo si chiude con la morte dell’adorata Mayrig: gli occhi di Achod cadono su un vecchio libro di poesie armene posato su un tavolino nella bella casa che egli stesso, anni prima, aveva donato a sua madre, contiene una lettera per lui, amato mantechess (in armeno “figlio mio”) in una pagina che contiene dei versi sottolineati in rosso:
Eravamo in pace come le nostre montagne voi siete venuti come dei venti folli.
Abbiamo fatto fronte come le vostre montagne, voi avete urlato come i venti folli.
Noi siamo eterni come le nostre montagne e voi passerete come venti folli.
L’opera affronta quindi le conseguenze del genocidio, la diaspora, condizione tormentosa di sradicamento, rimasta impressa nel momento in cui i profughi, giunti al porto e identificati, con il sordo rumore di un timbro, che riecheggia nei loro ricordi per sempre, avevano ricevuto quasi un sigillo nell’anima, non solo nelle carte, tramite una triste parola rappresentativa della loro condizione: apolidi. Come già specificato, la narrazione rimane in una sfera individuale e familiare, esaminando soprattutto il coraggio e la dignità nel risollevarsi da uno stato di totale prostrazione. C’è un elemento che accomuna le tre opere: il cosmopolitismo degli Armeni, popolo dalla cultura aperta e moderna, che si palesa nelle tre differenti narrazioni nella capacità di adattamento a realtà diverse dalla propria, sia prima sia dopo le deportazioni, senza snaturare la propria identità.
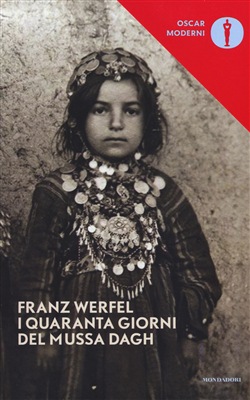
Il protagonista de “I quaranta giorni del Mussa Dagh” di Franz Werfel, (la prima opera letteraria che si occupò del genocidio), di nome Gabriele Bagradian, esponente di una nobile e prestigiosa famiglia armena, dopo un lungo periodo vissuto in Francia, torna in Turchia, nel suo villaggio chiamato Yogonoluk, con la moglie francese e il figlio quattordicenne, riapre la sua antica dimora familiare, che diventa fulcro della vita culturale del villaggio, in cui al lettore sembra di palpare, respirare e vivere la raffinata cultura tradizionale armena con i suoi rituali, mista agli elementi occidentali introdotti dal protagonista. E mentre la vita procede pacifica nei villaggi attorno a Yogonoluk, i Turchi organizzano il genocidio di cui l’opera affronta le terribili vicende in una dimensione epica e corale, narrando la disperata resistenza di quello e di altri cinque villaggi posti ai piedi della Montagna di Mosè, (Il “Mussa Dagh, luogo teatro della disperata resistenza), presso la città costiera di Alessandretta, nella baia di Antiochia. Werfel, ebreo, pubblicò il romanzo nel 1933, ma gli fu impedita la traduzione in armeno e la diffusione nella Germania hitleriana, proprio mentre si progettava lo sterminio degli Ebrei da cui egli si salvò riuscendo ad emigrare in tempo in America. L’opera, si riferisce dunque a una vicenda realmente accaduta e sfata l’immagine degli Armeni sottomessi e asserviti che subiscono senza reagire il genocidio: chi immagina gli Armeni solo come un popolo remissivo e privo d’iniziativa, con questa narrazione si deve ricredere, infatti, il lettore vive con apprensione ed empatia la tenacia, l’eroismo, le sofferenze di circa cinquemila persone che organizzano, dopo essersi rifugiate sull’acrocoro del Mussa Dagh, una comunità autosufficiente nel sostentamento quotidiano, dotata di regole di civile convivenza in condizioni estreme. E durante i quaranta giorni la strenua resistenza, nonostante i buoni propositi, disgrega la compagine sociale a causa della carenza di mezzi e vettovaglie, talvolta gli sfortunati profughi ripetutamente attaccati dagli eserciti Turchi, costretti a estenuanti schermaglie belliche, si pentono di non essersi incolonnati nelle carovane della morte con tutti gli altri, o peggio, assistono alla degenerazione della loro comunità che diviene una sorta di società di hobbesiana memoria, in cui si fomentano insofferenza, invidia, vecchi rancori, entrano in crisi rapporti familiari e legami sentimentali in un processo disumanizzante acuito dalla consapevolezza della fine vicina, dalla miseria e dalla fame. Spiccano atti di eroismo e di abnegazione come quelli del protagonista Gabriele Bagradian, del giovanissimo figlio, la calma ieratica del sacerdote del villaggio, intorno a loro ruota un folto gruppo di personaggi, disertori che si uniscono ai ribelli, stranieri che sposano la causa degli Armeni, vecchie piagnone depositarie di arcani riti, reduci da precedenti persecuzioni, ognuno con la sua storia personale, con le sue attese, che è descritto nelle sue peculiarità in una narrazione che assume i tratti dell’epica. Si salvarono in quattromila, gli Armeni del Mussa Dagh, grazie al fortuito passaggio di un incrociatore francese che avvistò i segnali posti sul massiccio dai profughi, ormai ridotti allo stremo. Molti elementi dell’opera di Werfel si ritrovano nel romanzo “La masseria delle allodole” di Antonia Arslan, che narra sulla scorta dei ricordi dei superstiti, in maniera romanzata, la vicenda reale dei suoi nonni e zii coinvolti nei tragici eventi del genocidio. Un tratto comune ai tre libri, è la descrizione della vita precedente che scorre serena nelle comunità armene, le belle dimore, l’agiatezza economica, il rispetto delle tradizioni religiose, l’apertura verso il mondo e l’inclinazione agli studi che portava molti ad acquisire un bagaglio di conoscenze approfondite all’estero, la possibilità anche per le donne di ricevere un’istruzione. L’alacrità e questo tenore di vita così elevato, stridono pesantemente, in entrambe le opere, confronto alla brutalità con cui essi sono strappati dal loro mondo da perfidi zaptiè, gli esecutori materiali, infimi soldati, prima delinquenti comuni, arruolati per compiere efferatezze di ogni tipo, accumulare bottino, attaccare le carovane dei deportati per privarli di ogni sostanza o avere.
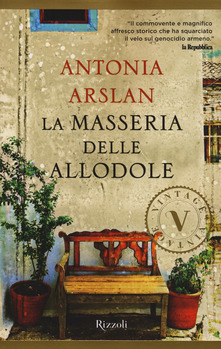
Protagonista della “Masseria delle allodole”, ambientato in una cittadina dell’Anatolia, è il farmacista Sempad Arslanian, che, in previsione della visita del fratello Yerwant, divenuto un ricco medico in Italia, rende una villa di campagna, collocata in un vero e proprio locus amoenus, detta “la Masseria delle allodole”, un’esclusiva dimora con splendide vetrate, bovindi, loggiati, giardini, persino un pianoforte fatto giungere da Vienna. Sarebbe divenuta il luogo perfetto per la riunione della numerosa famiglia di Sempad con i parenti, se a un tratto tutto non fosse stato stravolto e la splendida dimora non fosse stata teatro di una disumana carneficina precedente la deportazione. La narrazione è caratterizzata da un tono quasi mitico e fiabesco che enfatizza, tramite l’attenzione accurata dei dettagli descrittivi, ogni aspetto della cultura armena, il rispetto delle tradizioni, la profonda spiritualità religiosa nella preparazione dei riti pasquali, la sacralità della famiglia. Al lettore sembra di respirare il profumo delle rose e dei gelsomini, la fragranza delle sfoglie dei paklavà dolci e speziati, di vedere le tavole imbandite su candide tovaglie ricamate, di udire la musicalità della lingua armena, la melodia struggente dei canti tipici, la vivacità delle danze. Quest’atmosfera è spezzata frequentemente da frasi prolettiche scritte in corsivo, foriere di dolore e di foschi presagi che palesano a poco a poco la sorte infausta di alcuni dei protagonisti. Dopo l’orribile strage degli uomini e dei bambini alla masseria, le donne affrontano in modo dignitoso ed eroico la deportazione: spicca la figura statuaria di Shushanig, la vedova del protagonista, una mater dolorosa, pietrificata dal dolore e dalla disperazione ma connotata da una straordinaria fermezza d’animo che le scaturisce dallo smisurato istinto di protezione nei confronti dei figli. Dopo ineffabili sofferenze, l’eroica donna e i suoi figli furono salvati in modo rocambolesco da un sacerdote, una prefica greca e un mendicante turco ed ebbero la possibilità di imbarcarsi alla volta dell’Italia, Ma Shushanig, stremata, morì sulla nave per raggiungere il suo amato Sempad. Nessuno però torno più nella piccola città e nella masseria delle allodole.
Termino con le intense parole del poeta russo Osip Mendel’stam, che nel suo mistico “Viaggio in Armenia”, «regno di pietre urlanti» , nel 1930, prima di essere fagocitato nella spirale dei gulag, scrisse in onore del martoriato popolo armeno che rappresentano la chiave della tragedia rimossa:
“Voglio conoscere il mio osso, la mia lava, il mio fondo sepolcrale [sapere come sotto di esso si accenderà all’improvviso di magnesio e fosforo la vita, come mi sorriderà: membroalata, accusatrice, ronzante]. Uscire verso l’Ararat, nella periferia che sputacchia, sbriciola, scatarra.”
Ancora una volta quindi è la letteratura, che, scandagliando i risvolti più oscuri, tragici e inquietanti di fatti storici ingiustamente negati, permette di alimentare la memoria collettiva, unico strumento con cui possiamo onorare le vittime della prima, enorme tragedia del Secolo Breve.
Bibliografia
Marcello Flores, “Il genocidio degli Armeni”, Bologna , Il Mulino, 2006.
Hernry Verneuil, “Mayrig” ,Vignate (MI), Divinafollia 2015
Antonia Arslan, “La masseria delle allodole”, Bergamo, Rizzoli, 2015
Franz Werfel, “I quaranta giorni del Mussa Dagh”, Milano, Corbaccio, 2015
Osip Mandel’stam “Viaggio in Armenia”, Milano, Adelphi 1988
Graziella Enna, nata a Oristano il 12/09/1969, laureata in lettere classiche presso l’Università degli studi di Cagliari, insegnante di lettere nei licei.
- Ha pubblicato nella rivista letteraria “Euterpe” il saggio: “Due poeti francesi reinterpretati da Fabrizio De André: François Villon e Pierre de Ronsard “, nel numero di febbraio 2019;
- nella rivista culturale on line “L’Ottavo” i seguenti scritti:
- 19/09/2018 recensione su “La memoria rende liberi” di Liliana Segre.
- 19/10/2018 recensione su “I cento passi” di Giovanni Impastato.
- 24/10/2018 recensione su “Bella mia” di Donatella di Pietrantonio.
- 06/11/2018 recensione su “I vicerè” di Federico De Roberto.
- 16/11/2018 percorso letterario : “Viaggio sacro e profano” In Petrarca e altri poeti.
- 07/12/2018 percorso letterario: “Catullo e Foscolo”.
- 14/12/2018 recensione su “La notte” di Elie Wiesel.
- 11/01/2019 recensione su “Gli zii di Sicilia” di Leonardo Sciascia.
- 27/01/2019 recensione su “Sonderkommando Auschwitz” di Shlomo Venezia.
- 06/02/2019 leggere Pirandello e’ una rivoluzione copernicana.
- 10/O2/2019 recensione su “Foibe, l’ultimo testimone ” di Graziano Udovisi.
- 23/02/2019 lettura critica del XV canto dell’Inferno di Dante .
- 05/03/2019 lettura critica del XVII canto del Paradiso di Dante.
- 26/03/2019 percorso letterario “Lucrezio e Leopardi di fronte alla natura”.
- 05/04/2019 recensione su “Le Metamorfosi” di Apuleio.
- 12/04/2019 recensione su “Terra bianca” di Davide Piras.
- 20 /04/2019 lettura critica del XI canto Paradiso di Dante.
- 24/04/2019 Recensione su ”Il genocidio armeno, 100 anni di silenzio”di A. Aramu, A. Mazzone, G. Micalessin.
L’immagine di copertina è presa da ilmessaggero.it