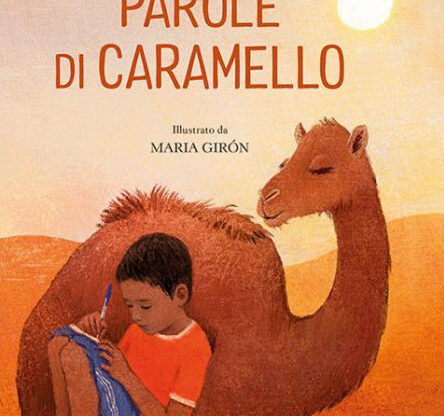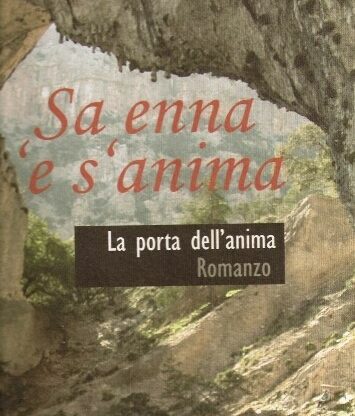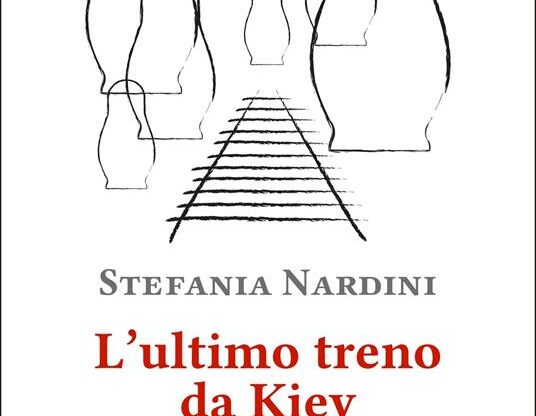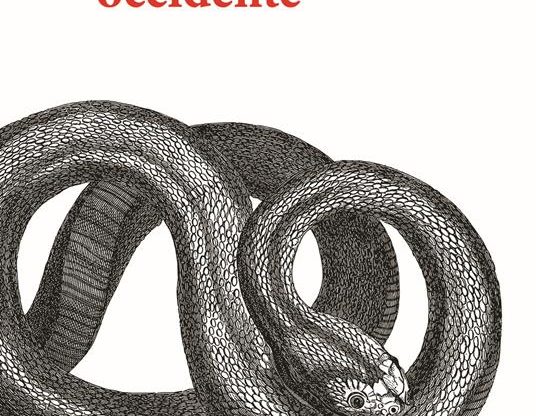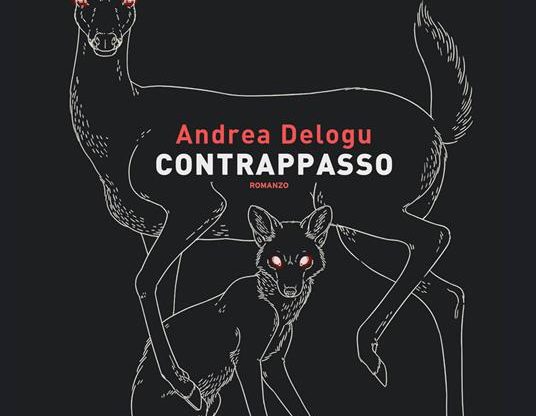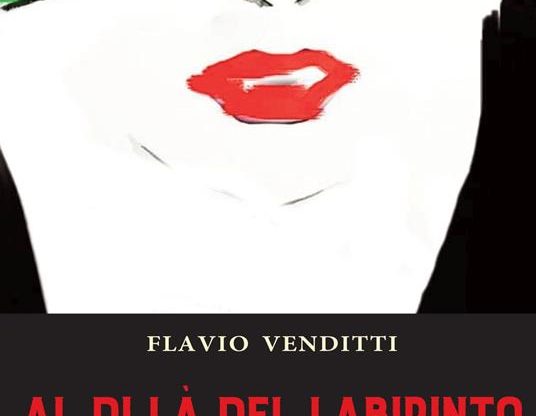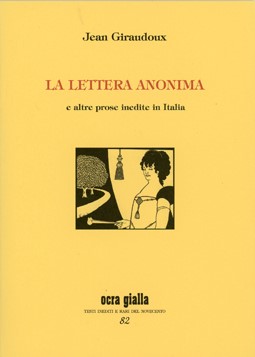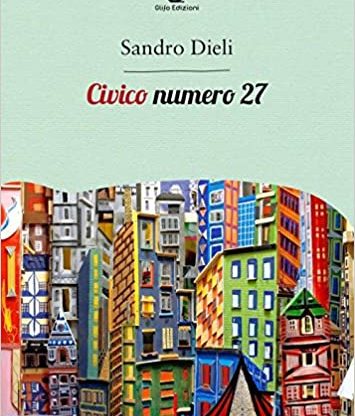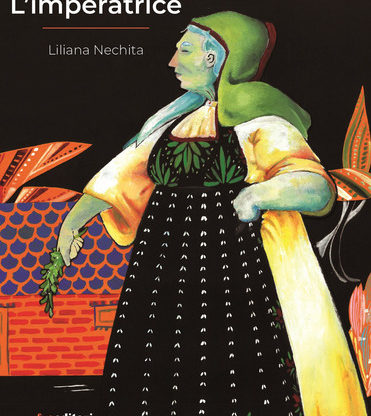Di Marcello Caprarella
- 21 maggio 2019 (dal mio diario madrileno)
Leggo, tra un viaggio e l’altro e un obbligo di traduzione tecnica e l’altro, i romanzi finalisti del premio Strega. Quelli della dozzina, tanto per intenderci. Vivo a Madrid ed è stato difficile procurarseli. Alcuni li ho comprati a Verona, nel corso della mia ultima trasferta lavorativa, mentre altri mi sono stati prestati o regalati da amici italiani che sono venuti a trovarmi in Spagna. Mi accosto ai testi con l’occhio del lettore, non con quello del critico. Leggo, cioè, come posso, con gli strumenti ermeneutici che ho. Il contrario sarebbe ridicolo e pretenzioso. Ho davanti un paio di settimane senza troppe beghe lavorative e ne approfitto per dedicarmi a questo otium. Finora ne ho letti due, fino in fondo, di romanzi “dozzinisti”. Di un terzo di essi, invece, ho letto solo un centinaio di pagine, ma è l’unico che mi piace. L’ha scritto Valerio Aiolli, si intitola Nero ananas e lo ha pubblicato Voland Edizioni. Mi piace perché, da lettore, ci ritrovo una trama credibile, una storia, una coerenza interna.

Racconta il periodo successivo alla strage di Piazza Fontana e altri massacri. Descrive bene la “terra di mezzo” dei depistaggi, delle deviazioni dei servizi segreti. Il clima morale, si sarebbe detto in altri tempi. Il grande affresco della cronaca e della storia italiane, filtrato alla luce dell’acquerello familiare dello scrittore. Insomma, mi sembra che funzioni. Si vede che, pur da semplice lettore, leggo da storico, quale sono e fui.
Negli altri due romanzi, invece, vedo solo esercizi di stile un po’ vuoti, per quanto sapienti e sicuri di sé. Mi ha deluso molto Fedeltà (Einaudi) di Marco Missiroli. Molte persone me ne avevano parlato bene, però a me è parso, lento, noioso, confuso. Il mondo che descrive non riesce a coinvolgermi. Milano, case, palestre, combattimenti di cani, professori universitari alle prese con crisi coniugali, tradimenti. E nemmeno un filo che regga lo scenario. Se la frammentazione postmoderna è un valore, il romanzo di Missiroli varrà di certo qualcosa, ma io non so dirla bene, questa cosa, perché non riesco a vederla. O, meglio, non riesco a vederne il valore.
E veniamo a Lux (Neri Pozza) di Eleonora Marangoni. Tutto molto poco credibile, il tonfo e il tanfo del posticcio sotto una patina di brillantezza convenzionale.
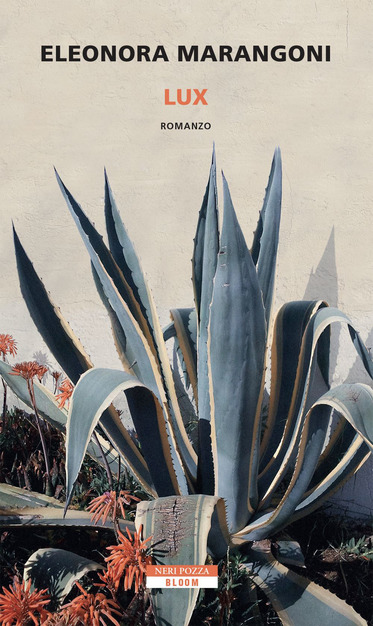
Mi ha ricordato il peggiore Guareschi, quello de Il destino si chiama Clotilde. Sembra quasi un private joke tra una comitiva di reduci (trentenni) da un Erasmus. La freschezza, mi si dirà. E va bene. La mancanza di calore, rispondo io.
Nei prossimi giorni dirò qualcosa degli altri romanzi.
Non mi date retta, eh. Come scrive Aiolli, riferendosi al festival di Sanremo del 1969, non ho l’occhio allenato a individuare favoriti e vincenti. Ho, come Aiolli – lui è della Fiorentina. Io, della Lazio…- gusti da ottavo posto, ma per il momento il premio Strega lo darei a lui, a Valerio Aiolli. Si può essere certi, quindi, che non lo vincerà.
23 maggio
Ho finito di leggere, ieri, Addio fantasmi (senza virgola dopo Addio) di Nadia Terranova, edito da Einaudi. Non è un romanzo, ma un’autoanalisi. Il fantasma è un padre sparito quando la scrittrice era ragazzina e che permea tutti gli oggetti di una casa in rovina e alla quale la protagonista fa ritorno. La casa è a Messina e la riparazione di un balcone la effettua un muratore sessantenne che ha un figlio mezzo greco (la madre è greca) e allora si associa la Sicilia alla luce della Grecia, ma la protagonista non scopa con il ragazzo, che alla fine muore in modo oscuro e discretissimo, come uno che vuol togliersi dai coglioni senza farsi notare troppo. La storia è questa, è ben scritta e non succede niente. Quindi, a rigor di termini, non è nemmeno una storia. Qualunque cosa sia, comunque, è raccontata bene, ma non emoziona.
L’altro manoscritto che ho iniziato a leggere, per contro, è una storia abnorme.
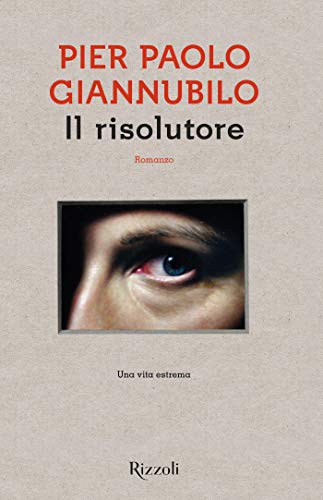
Si tratta de Il risolutore, di Pier Paolo Giannubilo (Rizzoli Editori). Il contesto storico parte dalle rivolte studentesche del 1977 a Bologna e si dipana fino ai nostri giorni, con il pretesto di una lunga intervista-autoconfessione di un protagonista che attraversa in maniera inverosimile e reboante tutti gli anni descritti. Non c’è avvenimento storico e personaggio che non l’abbia sfiorato o che non abbia sfiorato lui, superuomo alternativo che, da studente del DAMS, si ritrova a fare l’agente dei servizi segreti italiani. Entra in contatto con Andrea Pazienza e Moana Pozzi, va in missione in Libano per cercare di uccidere Jumblatt, il leader della milizia drusa; vede cascare il muro di Berlino, incrocia Felice Maniero (quello della mafia del Brenta), ottiene una cattedra per meriti artistici non specificati e passa attraverso lo sfaldamento cruento della ex Jugoslavia. Nel frattempo, gestisce pure un locale alternativo a Lugo di Romagna, dipinge, fa mostre in Germania, va a puttane in giro per l’Europa con i camionisti delle ditte esportatrici emiliano-romagnole, bazzica il Maurizio Costanzo Show e scrive poesie e romanzi. Ogni tanto molla tutto e si presenta al comando dei carabinieri che lo tengono sotto ricatto dai tempi del DAMS e che lo costringono ad andare a fare qualche “lavoretto”. Come bestseller potrà pure funzionare. Come romanzo storico (ammesso che sia quella la pretesa dell’autore) non va bene. Non ha né il tono né la struggente normalità del quotidiano del romanzo di Aiolli, tanto per dire. Forse è un romanzo epico, e sfianca. Se la Terranova annoia perché scrive di un nulla incentrato solo su sé stessa e di sé stessa a centrare il nulla, Il risolutore non mi accalappia perché il sé e il lui stesso narrante pretendono di incentrarsi sul mondo, di farselo girare sulla punta delle dita. A me piacciono le megalomanie più discrete, più credibili, più autenticamente disperate. Quelle in cui accade qualcosa che gira assieme al mondo o in senso contrario, ma che fa intravedere un mondo. Il romanzo di Aiolli, per esempio.
- 24 maggio
Quanto a Il risolutore, ho proseguito e finito. Mi sono informato: è la vita di Gian Ruggero Manzoni, quella che Giannubilo racconta sotto forma di intervista. Non so quanto di vero ci sia nel racconto di Manzoni e in ciò che riporta Giannubilo, ma la discendenza manzoniana del protagonista è autentica. E anche i suoi lavori di docente universitario, scrittore, pittore e, a quanto pare, ex uomo dei servizi segreti. Tutto questo capovolge l’idea che mi ero fatto del testo. Mi sembra che possa essere paragonato, il testo, a quello di Emmanuele Carrère e dedicato a Limonov. Per l’argomento e per il tono, più che per la scrittura, ché quella di Giannubilo mi pare più barocca di quella di Carrère. Il fatto che la storia sia vera (al netto di qualche inevitabile mitomania e affabulazione dell’intervistato) me la fa piacere un po’ di più. Le pagine migliori sono quelle del diario finale e contemporaneo di Giannubilo; dopo le enormità riferite dall’intervistato nei capitoli precedenti, il quotidiano sofferente di Giannubilo può sembrare scolorito e povero, e invece redime e spiega in buona parte le esagerazioni e la genesi del romanzo, in un ricongiungimento ideale tra realtà e finzione, giocato sul filo di un’ambiguità accettabile tra il vero e il falso, la realtà e il ricordo. Insomma, Il risolutore non è male, però io continuo a preferire la sobrietà della fiction di Aiolli, per cui il premio Strega lo continuo ad assegnare a lui. Per il momento…
- 25 maggio
Continuo a credere che un lavoro non legato alla scrittura (un’occupazione manuale, per conto terzi e non necessariamente “di concetto”) eliminerebbe di colpo un sacco di mie nevrosi e mi consentirebbe di vivere in maniera modestamente e moderatamente felice. E, probabilmente, anche di scrivere meglio, più ariosamente.
- 26 maggio
Da “giurato infiltrato” del Premio Strega, vado avanti nella lettura dei manoscritti della dozzina della pre-selezione finale. Ieri ho letto, di un fiato, La straniera, di Claudia Durastanti (La nave di Teseo). Mi è piaciuto molto e condivido in sostanza quanto del testo ha scritto Mario de Santis, la cui bella e articolata recensione non ha condizionato il mio giudizio, dato che avevo già quasi finito la lettura e le mie impressioni avevano preso forma fin dalle prime pagine del romanzo della Durastanti. Che romanzo non è, e non lo dico per sminuirne il valore, che resta grande. La Durastanti ha scritto una specie di autobiografia e di autoanalisi. E, come tutti quelli che scavano, ha toccato le radici. Due genitori sordi, un continuo esercizio di traduzione, di comprensione. Questa, la metafora, l’allegoria che l’autrice espone e sulla quale articola il romanzo. Il contrasto nasce dall’amore per la letteralità dei genitori, da una loro certa insofferenza a fronte del romanzato, del romanzesco. La prosa è ricchissima. I riferimenti letterari (a iniziare dal rimando del titolo a Lo straniero di Camus) e antropologici (che forse appesantiscono un po’ il testo, se proprio si va a cercare il pelo nell’uovo) ci dicono di un’autrice matura, consapevole e colta. La sua vicenda umana, di bambina povera emigrata al contrario (cioè da New York alla Basilicata) e capace di reinventarsi attraverso una (o la) lingua sempre diversa, basterebbe di per sé a farmi dire che il libro è molto bello. Ma c’è di più: c’è il polso della vita di società e luoghi che si sovrappongono (New York, Londra, la Basilicata della Val d’Agri) in periodi diversi, racchiusi tra l’inizio degli anni Ottanta e il presente. Belle anche le considerazioni finali sulla fiction e l’autofiction, che chi scrive diari apprezzerà. La frase di chiusura Ma è una storia vera? non cerca la risposta del lettore e nemmeno pretende di spiazzarlo. Schiude solo una possibilità, che è quella della traduzione che ciascuno di noi saprà farne. A me personalmente piacerebbe che la storia fosse completamente inventata. Un modo, cioè, di ammazzare genitori che non esistono e che non ci possono né ascoltare né vedere. Insomma, se dessero il premio Strega alla Durastanti o ad Aiolli, io sarei contento. Li metto a pari merito perché, seppure da stili, linguaggi e priorità diverse, ci fanno vedere la storia dal buco della serratura di una famiglia, di una casa, di uno sfacelo personale da ricomporre nel vortice dei grandi cambiamenti che si succedono attorno. Stranieri, sì. E anche sempre esuli che non sanno dove far ritorno.
- 27 maggio
Non ce l’ho fatta a leggere per intero Città irreale, di Cristina Marconi ed edito da Ponte alle Grazie. Ho proceduto a salti, tanto sapevo già come andava a finire. Di irreale e di surreale c’è solo che un compitino del genere sia stato inserito nella dozzina del premio Strega. È una storia, da collezione Harmony, di una Erasmus che ce l’ha fatta e che sposa l’inglese bello, ricco, torturato e nobile, dopo essere emigrata a Londra, aver lavorato in varie ditte e non avere capito l’Inghilterra e gli inglesi. Parla solo di sé, la Marconi, e non mi interessa nemmeno sapere se la storia sia vera e inventata, dato che la storia non esiste. La storia è lei, l’autrice, o il personaggio che l’autrice si è cucita addosso, e non mi attira. Di storie di Erasmus ne ho ascoltate anche troppe. La maggior parte di esse erano più palpitanti di quella della Marconi. Che poi che non so nemmeno se abbia fatto l’Erasmus, la Marconi. Ma chi, come me, l’ha fatto capisce ciò che voglio dire. Ci sono sradicamenti veri (vedi Durastanti) ed atterraggi attenuati dal paracadute dell’egoismo e delle porte che si aprono sempre. Forse l’happy end è solo nella fantasia, ma il risultato resta sconsolante. Prendiamo Londra, la città “respingente”. Anche la Durastanti, ne La straniera, descrive l’impressione di gelo umano che comunica Londra, ma lo fa con uno sguardo ampio e pieno di pietas, soffermandosi a guardare anche altre vittime della solitudine metropolitana. Con poche pennellate, ma commoventi. Come, per esempio, quando dice di essere diventata amica solo delle parrucchiere romene che le fanno la messa in piega una volta al mese, le chiedono notizie della sua famiglia o le mostrano le foto del bagno che si sono fatte rifare in Romania con i soldi guadagnati a Londra. E che il sabato sera si mettono il vestito buono e pieno di paillettes. Ecco, questo sguardo in tutti i sensi comprensivo manca, alla Marconi. E, se manca quello, manca tutto.
Mi sia consentito di chiudere con un ricordo personale. Il mio primo viaggio a Londra fu nel 2000, per vacanza, con JA, e fu bello e procelloso. Lui, JA, si sentì più respinto di me. Alloggiavamo da una sua ex amante, dalle parti di Old Street, in una zona un tempo degradata e che si era trasformata in covo di artisti ricchi e alternativi. Come la sua ex amante, appunto. Lei era una tedesca ossuta e alla quale mancavano molte diottrie. JA, che l’aveva conosciuta a Madrid, la trovava peggiorata in pochi mesi; a me sembrò, d’acchito, una di quelle atlete ormonizzate della RDA. Fu gentile, ci accolse nella sua mansarda, all’ultimo piano di una fabbrica dismessa. JA iniziò a farneticare subito e a dire che la tedesca era innamorata di me e che non era bello che la tresca si snodasse sotto i suoi occhi. Un delirio come un altro: tra me e la vecchia fiamma di JA non successe nulla. La tedesca ci invitò pure a una mostra a Chelsea, in cui si esponeva la sua “opera” di artista d’avanguardia: un sole ritagliato su carta e immerso in un secchio pieno d’acqua. A Chelsea, io e JA scroccammo anche un pranzo in casa di parenti ricchissimi di una nostra comune amica italo-spagnola che viveva a Madrid e che era figlia di uno storico barone dell’Università Federico II di Napoli. Il padrone di casa, inglese, era un pittore vero e quotato, e fu quasi caloroso. La moglie, sorella della madre della nostra amica, pur essendo spagnola, ci trattò come i volontari della Caritas trattano i barboni al cenone di Natale. Fu una settimana di musei, sbronze e perplessità, per me e JA. Sempre con l’impressione che la città ci fosse nemica. O indifferente. Non facevamo altro che camminare, sin dall’alba, tra gente frettolosissima e scostante. Ci stancavamo verso le dieci del mattino, e a JA questa cosa faceva rabbia. Io credo fosse colpa del caldo e dell’umidità di giugno, che sfiancavano. JA, invece, diceva che era colpa del nostro provincialismo, che consisteva nel non fare la colazione all’inglese. Un giorno lo fece lui, l’English breakfast, in un posto schifoso, al neon, con i tavolini e le sedie di plexiglass, mentre io lo guardavo perplesso mangiare fagioli, sanguinaccio e torte al lampone. Mi disse: “Oggi ti faccio vedere io come si cammina senza soste e cedimenti!” La prima mezz’ora sembrava un animoso bersagliere, quando il vento sul cappello fa le piume svolazzar. Era impossibile tenergli il passo. Poi, a un tratto, si bloccò su un ciglio di strada, si mise le mani sulle ginocchia, vomitò tutto e iniziò a piangere. Diciamo che Londra non lo accolse, ma che anche lui la rigettò. Come la Marconi.
- 28 maggio
Letto anche Età straniera, di Marina Mander (Marsilio). Altro compitino. A scriverlo è la voce narrante di un liceale, appunto. Con tutti i limiti (forse voluti) di una brillantezza forzata e volontà di stupire con qualche artificio verbale. La storia, però, non funziona. Il ragazzo ricostruisce la figura di un padre morto, uomo tormentato e brillante. Un topos, tra i “dozzinisti” del premio Strega di quest’anno, quello della ricerca del padre assente, giocherellone o morto. Poi c’è la madre, oggetto della contestazione del liceale, e anche lì ritroviamo un tema ricorrente. Il ragazzo attacca la madre, che è una che ha la fissa dell’assistenza agli immigrati e che alla fine si porta in casa un romeno minorenne che si prostituisce e che è scappato da un padre violento. Il ragazzo padrone di casa, sulle prime diffidente e offensivo nei confronti di Florin (così si chiama il viado romeno ospitato), alla fine cede e fa amicizia con l’immigrato, cedendogli la cameretta e accompagnandolo nei furti e nelle piccole avventure urbane.
Ho letto critiche favorevoli, come quelle di chi magnifica l’inventiva linguistica dell’autrice, capace di rendere bene il miscuglio di romeno e italiano dei dialoghi. Boh? Basta così poco per stupire, pare… Il romanzo non vale niente ed è sconclusionato e banale. Tanto, che i due ragazzi diventati amici finiscono su una spiaggia della Liguria ad accarezzare un gattino perché il romeno vuole vedere il mare, giustamente. Il mare è sempre una cosa che rinfranca, tranquillizza e purifica. E poi il padre del ragazzo padrone di casa è morto affogato, se ho ben capito, ma forse era una metafora troppo contorta per un sempliciotto come me. Ah, in casa della mamma circola pure un tassista, nuovo convivente della donna. Secondo me, sotto sotto, il tassista è leghista, ma non ha il coraggio di dirlo. Il liceale lo trova volgarotto e lo paragona al padre intellettuale. Il tassista, di sicuro, non comprerebbe né leggerebbe mai un romanzetto del genere, e questo è motivo sufficiente perché il manoscritto sia apprezzato da chi è davvero sensibbbbile e di ampie vedute. O no? Si parla anche molto di Kurt Cobain e dei Nirvana, e delle canne che l’adolescente padrone di casa si fa. L’immigrato, invece, scappa anche un paio di volte dalla casa di chi l’accolto portando via soldi, ma è inevitabilmente più puro, beve solo qualche birretta (ma quasi sempre aranciata) gli piacciono le merendine Fiesta (e qui il bimbo ricreativo elementare che vive e ricorda in me si commuove sul serio) e alla fine si fa sempre benvolere e perdonare perché la cattiva coscienza di chi l’accoglie deve pesare di più. Ah, e c’è pure un carabiniere cattivissimo che si scopa gratis il povero Florin e che lo minaccia e lo picchia pure, quando lo incontra per le strade di Milano intento a compiere qualche furtarello per comprarsi le Nike ultimo modello e che il romeno dal cuore d’oro compra anche al ragazzo che gli ha ceduto la cameretta, in nome della solidarietà e del comune disagio giovanile da padre assente. E il prostituto romeno, ovviamente, pur essendo analfabeta, ha tante cose da insegnare al liceale privilegiato e spocchiosetto perché il ragazzo romeno, per chi non lo sapesse o non volesse capirlo, è andato all’Università della Vita e della Strada, che vale molto di più della memorizzazione di un pugno di aoristi. E questo è quanto. E questo è tutto.
31 maggio
Ancora da giurato infiltrato e non richiesto del Premio Strega, sto leggendo Di chi è questo cuore, di Mauro Covacich, pubblicato da La nave di Teseo. Provo la stessa situazione di disagio da lettore provata con altri manoscritti inclusi nella dozzina: uno stile piatto, una storia (non so se volutamente) minimalista, personaggi scialbi e appartenenti a mondi che possono interessare pochissime persone. Attenzione: non perché siano mondi aperti a pochi, ma proprio perché vengono caratterizzati in modo debole e autoreferenziale. Il problema è sempre lo stesso, che si parli di Roma o di Londra. Il problema, dico, è che si è incapaci di sciogliersi in una città, e si pretende che la città si sciolga in noi. O, almeno, la risputiamo al lettore piena soltanto dei nostri enzimi egocentrici. E chi dice una città dice una vita o un mondo. Indigeribile, una letteratura così, ma vado avanti.
1º giugno
Ho finito, a fatica, di leggere il romanzetto di Covacich. Il libro è composto da frammenti di diario romano dello scrittore, il quale racconta episodi del proprio quotidiano, delle persone che incontra mentre, malgrado qualche problema cardiaco, fa footing o va a nuotare al club sportivo. Va anche in giro per l’Italia a fare letture delle cose che scrive e che non si capisce mai bene quali siano. Fino alla metà del testo non si sa se il protagonista sia uno scrittore o un giornalista. Verso la fine del romanzo-diario l’autore lascia intendere di essere uno scrittore di romanzi. Non si comprende perché, all’improvviso e periodicamente, gli entri di notte un uomo grasso in casa e gli lasci l’appartamento puzzolente di fumo, mentre la moglie dell’autore dorme. È tutto senza senso, senza trama. Un caleidoscopio sfocato di personaggi alle prese con le proprie nevrosi urbane: il salutismo, i social networks, i rapporti umani allentati, il sesso compulsivo, le dipendenze da farmaci, la nutrizione al posto del mangiare. Vite a compartimenti stagni. Ci sono romanzi costruiti attorno a miriadi di persone che sfilano, raccontano il proprio dolore e poi spariscono o si ripresentano con un dolore nuovo, aggiunto. Penso a La colmena, scritto da Camilo José Cela negli anni Quaranta dello scorso secolo e ambientato nella Madrid che si leccava le ferite della guerra civile. Ma lì, nel romanzo di Cela, il collante narrativo e la compartecipazione (la compassione, sì…) dell’autore rendeva animati i personaggi, e credibili. Quelli di Covacich, invece, sono dei bozzetti freddi, inanimati persino nel dolore. Come se, pungendoli, ne venisse fuori acqua o aria, invece di sangue. Sì: esangue è forse l’aggettivo che meglio definisce questo tipo di narrato, questa scrittura anaffettiva.A un certo punto, nel libro di Covacich, ci sono una quindicina di pagine dedicate ai topi presenti in città e agli scrittori che hanno scritto di zoccole e di ratti, compreso Roberto Bolaño, che fa sempre molto intellettuale alternativo e disperato. Ci sono anche molti cani e un criceto, che appare e scompare nel testo e che dà luogo a un forte litigio all’interno di una coppia. Un’esplosione di piccole cose delle quali non mi frega nulla, che non riescono a coinvolgermi. Più o meno come mi è accaduto con il testo di Missiroli. Nelle ultime pagine c’è la storia più interessante, che è quella che viene raccontata all’autore da un barbone romeno (gli homeless romeni, assieme ai padri assenti, fuggiti o bizzarri, sono un altro topos dello Strega del 2019). È il racconto più vivido ed è significativo che a snocciolarlo sia un io narrante diverso dall’autore, indipendentemente dal fatto che l’autore possa averlo inventato. E, significativamente, Covacich chiude il racconto del romeno e il romanzo affermando di non sapere cosa fare di un materiale narrativo del genere. Una dichiarazione sincera (il meglio del romanzo, senza dubbio) di incapacità o mancanza di volontà di riversare su carta le tragedie autentiche, non “abbellite” dalle proprie considerazioni posticce.
Sono disposto a pensare e finanche a credere che si tratti di limiti miei, di non essere stato capace di intravedere il sublime nelle pieghe recondite del romanzo di Covacich. Vorrei parlare con la persona che ha segnalato il testo al Premio Strega e domandarle cosa ci abbia visto, lui o lei, in Di chi è questo cuore. E dove sia, il cuore.
6 luglio
Ho appreso ieri che ai primi due posti del Premio Strega ci sono, quest’anno, due romanzi storici. Il caso ha voluto che siano stati gli ultimi due finalisti che ho letto, a giugno, perché erano molto lunghi e perché, dopo la parentesi di pace di fine maggio, il lavoro mi ha incalzato. Il vincitore è stato M. il figlio del secolo, scritto da Antonio Scurati per i tipi di Bompiani. Al secondo posto si è piazzato Il rumore del mondo, di Benedetta Cibrario. Quest’ultimo, edito da Mondadori, mi è parso scritto meglio del primo. Sapevo, giacché lo dicevano un po’ tutti, che il romanzo di Scurati era il favorito (su quello della Cibrario, del quale nessuno parlava, non avrei scommesso quasi nulla) e mi riservavo di dire qualcosa a giochi fatti, a bocce ferme. Il figlio del secolo è Benito Mussolini, da giovane. Scurati promette (o minaccia) la prossima uscita della continuazione della biografia romanzata del Duce. Come temevo, in un’intervista al TG1, il nuovo vincitore dello Strega ha detto che un romanzo permette al grande pubblico di accostarsi alla storia, laddove la storiografia è disciplina per pochi. Io pensavo alla monumentale e scorrevolissima biografia che De Felice dedicò a Mussolini, prisma umano attraverso il quale osservare un pezzo di storia italiana, e mi chiedevo perché sia da considerare una lettura destinata a pochi. Mi sembra che, in un’epoca di post verità, il peso della fiction sia sempre più preponderante. Scrittura fantasiosa e lettura senza vincoli. Non sono contro la divulgazione, per carità. Mi limito a prendere atto della progressiva scomparsa di una disciplina come la storia, sulla quale mi sono formato. La storia sparisce dai piani di studio e da quelli di lettura. Se prima era per pochi, nel futuro sarà roba da eruditi stravaganti. Il romanzo della Cibrario, come dicevo, è a mio modesto parere migliore dal punto di vista letterario di quello di Scurati. E anche da quello storiografico, se vogliamo analizzare questo versante. Credo, però, che il fascismo romanzabile di Scurati susciti più interesse, polemico e morboso, dell’ottocento anglo-piemontese e dei pionieri italiani dell’industria della seta di cui narra la Cibrario. Non so quante copie venderà Il rumore del mondo, ma molto probabilmente saranno di più di quelle vendute da Dualismo e sviluppo nella storia d’Italia, un “classico” del grande Luciano Cafagna dedicato all’importanza del settore della seta in Lombardia nel quadro della rivoluzione industriale della “Padania”. Ovviamente Cafagna non parla di Padania perché il suo studio, pubblicato nel 1989 da Marsilio, era già stato concepito in larga parte all’inizio degli anni sessanta, nell’ambito del dibattito sull’arretratezza del Mezzogiorno. Cafagna, morto nel 2012 e che fu mio docente pisano, scriveva meglio della Cibrario e il suo testo è godibilissimo e pirotecnico anche in senso puramente letterario. Peccato che sia e resterà una prelibatezza per pochi. Non eletti, ma semplicemente desiderosi di informazioni veritiere.
Insomma, sarebbe bello se il boom dei romanzi storici incuriosisse i lettori e li facesse accostare alla “storia vera”, ma non sarà così.
Sul versante del mio quotidiano, poco da dire. Mi farebbe comodo mettere mano a un po’ di fiction per rendere più avvincente e variegato il narrato delle giornate che descrivo nel mio diario, ripetitive come la vita che faccio e che viene riempita da cose molto più prosaiche della prosa mia e altrui. Palestra, traduzioni ferroviarie e cinque chili di patate alla settimana, per esempio. Ho scoperto una bancarella al Mercado Maravillas che le vende a 69 centesimi al chilo, cioè alla metà degli altri. Mia moglie, con una logica un po’ da consumatore ceauceschiano, vuole che ne facciamo incetta, prima che le scorte finiscano. Si è anche informata sul proprietario della bancarella: è uno spagnolo che ha altri sette punti di vendita di frutta, ortaggi e tuberi nel mercato. Le altre sue bancarelle sono come quelle della concorrenza, quanto a prezzi, però la “nostra” è stata pensata per un pubblico più popolare. Diciamo che la bancarella sta a un gourmet abbiente come un lettore di Scurati sta a un testo storiografico ambizioso. Dietro il bancone c’è un giovane, riccioluto e aitante venezuelano. La maggior parte dei clienti è sudamericana, con preponderanza di ecuadoriani. Ieri mi ha visto la vicina del 4D e mi sono sentito come un intruso, un povero scoperto a fare la fila con la scodella in mano alla mensa di un convento. Mi precedevano una badante un po’ altezzosa, con la carrozzella di un’anziana parcheggiata a un metro, e due ragazzi peruviani sbronzi, alle undici del mattino. I ragazzi erano piccoli, scuri e con dei nobilissimi nasi alla Montezuma. Compravano ají e rocoto (varietà piccantissime di peperoni) per preparare un ceviche. La badante voleva una batata (non patata, attenzione). Ne voleva una specifica, enorme, e non riusciva ad estrarla dal mucchio, per paura di far crollare tutte le altre. Allora il ragazzo peruviano le ha detto: “Paisana, non ti preoccupare. Te la prendo io!”, e ha messo le mani alla base del mucchio per estrarre la batata gigante e porgerla alla badante, che ha ringraziato freddamente e precisato: “Non sono tua paisana. Sono ecuadoriana!” Il ragazzo peruviano era un fuoriclasse e come tale ha risposto: “Non siamo più in guerra con l’Ecuador, paisana!” Poi ha guardato il venditore e ha detto: “È che ne ho cavate così tante, dalla terra, di batatas, che a volte sento nostalgia…”. Il suo amico ha aggiunto solo: “Sbrigati, paga e non dire troppe stronzate, ché il signore dietro ha fretta!”. Sono uno straniero quasi ovunque.
Post scriptum: Come l’attento lettore avrà rilevato, all’appello dozzinale dei romanzi “stregati” manca Quella metà di noi, di Paola Cereda (Perrone Editore). Non l’ho trovato in libreria a Verona né ho potuto ordinarlo qui a Madrid. Nessuno me l’ha prestato e credo che non lo leggerò, a questo punto della mia vita. Se però qualcuno, a mezzo di questa stessa rivista che mi ospita, potesse convincermi che mi sono perso un capolavoro, io sono qui, con le orecchie e gli occhi spalancati.