Di Geraldine Meyer
“Non abbiamo bisogno di parole per sopravvivere, ne abbiamo bisogno per vivere”. Basterebbe anche questo piccolo frammento per mettere in evidenza la grandezza di Paradiso e inferno, di Jòn Kalman Stefànsson, scrittore islandese che, con questo testo diede vita ad una trilogia completata dagli altri due titoli La tristezza degli angeli e Il cuore dell’uomo.

Perché queste poche parole emergono come la più autentica cifra di questo piccolo capolavoro? Perché pochi libri sono, come questo Paradiso e inferno, una vera e propria elegia alla parola, alla poesia, al suo potere salvifico anche quando porta la morte. Perché le parole e la poesia sono un anelito di assoluto su cui si intesse la memoria, certo, ma anche il legame tra gli uomini, tra gli uomini e Dio, tra gli uomini e la natura.
Forse anche per questo la storia, proveniente da un passato senza però precisi riferimenti temporali, è narrata da una prima persona plurale, un noi che si staglia a fare da coro. Storia di una amicizia tra un Ragazzo (chiamato sempre così nel libro) e Bárður, pescatore di merluzzi per mestiere ma poeta, amante delle parole. Talmente amante di esse da lasciarsi assorbire completamente da un verso de Il Paradiso Perduto al punto da commettere un errore fatale, quello di dimenticare la cerata protettiva. Indumento indispensabile quando si esce per una battuta di pesca nel mare infuriato e gelido tra fiordi e ghiaccio.
Il Ragazzo, rimasto solo, compirà un viaggio che non sarà solamente geografico, ma anche iniziatico e metafisico, per riportare il libro al Villaggio, dove vive l’uomo a cui il testo appartiene. Tutto attorno l’Islanda, con la sua natura, il freddo e quelle forze primordiali che, pur rendendo la vita difficile, sono anche un teatro unico e immanente per le storie degli uomini e delle donne che ci vivono in mezzo.
Solitudini disperate, disperate e umanissime unioni umane, il mare, il ghiaccio e le parole, appunto, le parole che sembrano essere davvero le uniche capaci di “consolarci e asciugare le nostre lacrime, sciogliere il ghiaccio che ci stringe il cuore.” Con una galleria di personaggi che vivono con la natura che li circonda in un modo quasi mitologico e religioso e, proprio perché religioso, fatto di slanci e chiusure, Paradiso e inferno racchiude in sé alcune delle pagine più belle su ciò che la vita dovrebbe essere, un tentativo continuo di strapparsi dal buio per innalzarsi là dove lo sguardo possa abbracciare la vita stessa.
Diviso in due parti in cui il mare aperto e il paesaggio della prima lascia il posto al calore di locande chiuse e stanze al riparo della seconda, Paradiso e inferno, come scrive Emanuele Trevi nella bellissima postfazione: “[…] è una storia di mare, ambientata in un tempo abbastanza remoto, nel quale gli uomini sono ancora quello che per millenni sono sempre stati. Le loro usanze, i loro utensili, le loro parole non sono ancora entrati nel gorgo distruttivo della modernità, che rende tutto deperibile e sostituibile.”
Ecco, forse è proprio questo senso di cose immutate e, dunque, davvero necessarie ed essenziali, a colpire maggiormente in questo libro. È la forza di un tempo indefinibile in cui i silenzi e i fragori del nord diventano protagonisti e metafore della stessa condizione umana, dando a tutto il libro uno stampo autenticamente epico, tra tragedia e rinascita. Perché, come scrive sempre Trevi: “E magistrale è l’impiego di figure femminili che, dall’una all’altra parte del romanzo, sembrano incaricate di insufflare nel nudo accadere dei fatti la linfa segreta di una consapevolezza superiore. Non c’è potere al mondo che possa redimere la tragedia, ma è anche vero che a guardarla da una prospettiva più ampia, ogni tragedia rivela l’aspetto di una fiaba.” Questa è la parola, questa la poesia.
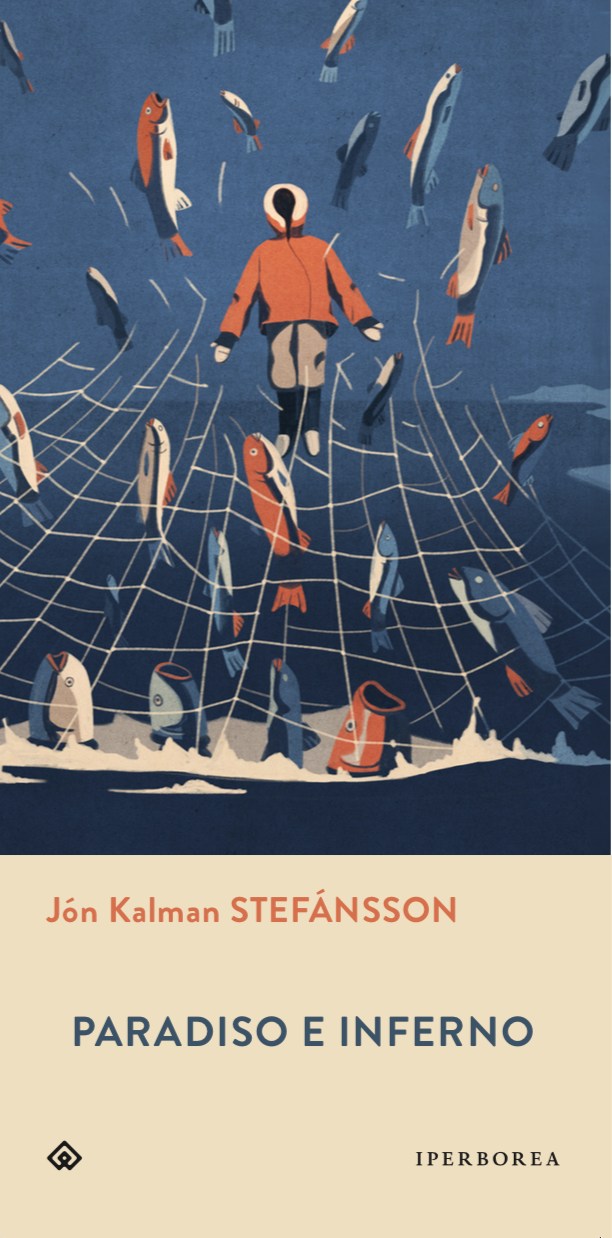 Paradiso e inferno
Paradiso e inferno
Letteratura islandese
Iperborea
2011
241
















