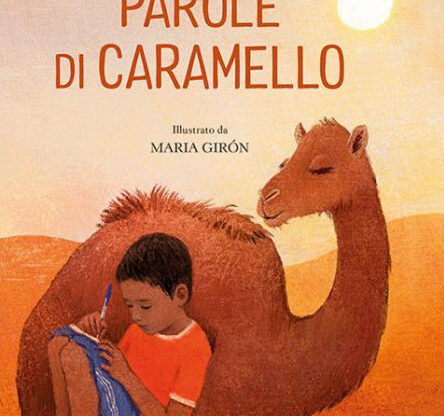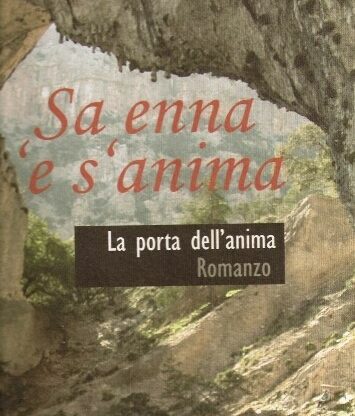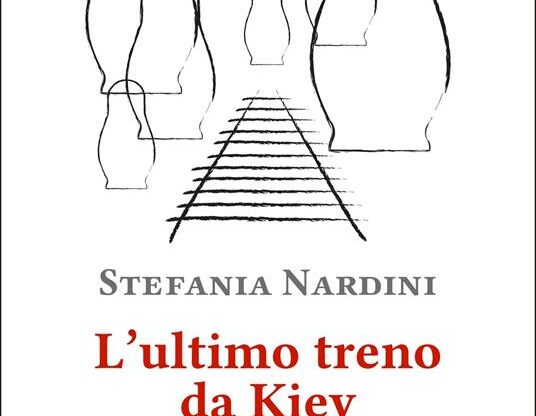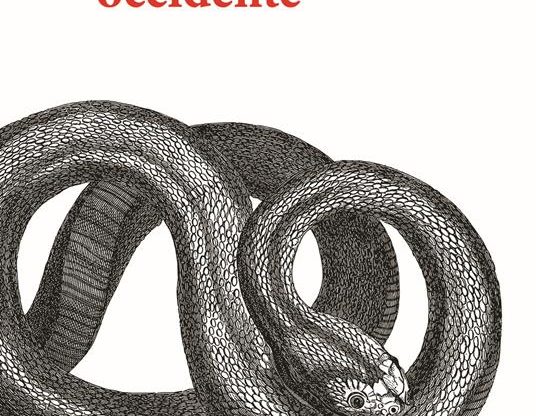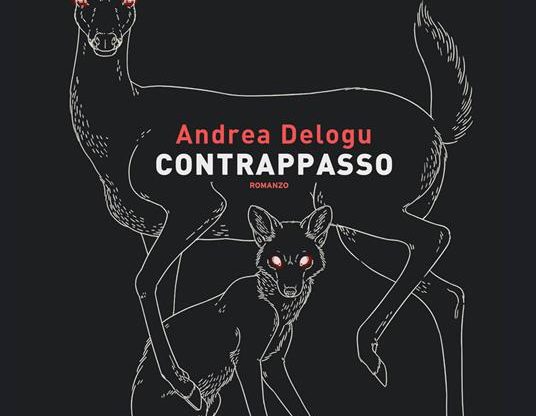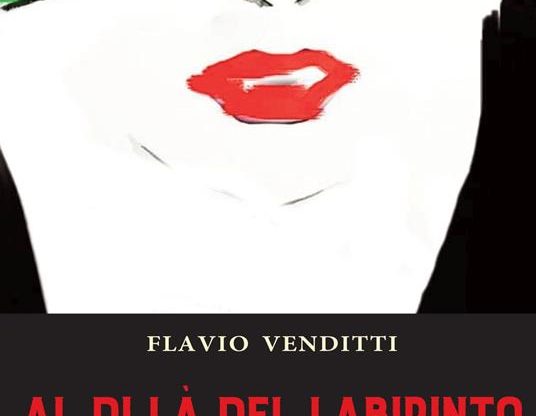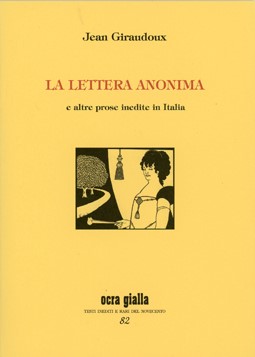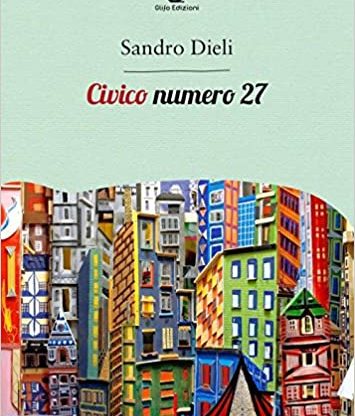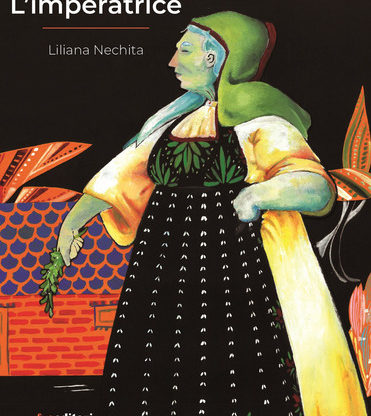Sento la neve cadere è un breve romanzo di Domenico Infante.
L’ambiente: la Sicilia, un piccolo paese (Petralìa), la famiglia, il mondo circostante.
Il periodo: dal 1922 al primo dopoguerra.
La storia: in realtà, le storie.
Perché sono tante.
Perché l’autore, in un approccio/premessa – sorta di campo corto cinematografico – sembra voler mettere a fuoco alcuni soggetti privilegiati per inquadrarli plasticamente al centro della scena; mentre le condizioni al contorno restano relegate, letterariamente parlando, a sfumature e dettagli lasciati all’ intuizione.
È un primo movimento: quello in cui i protagonisti sono Salvatore Salvati, sua moglie Agata, il neonato Esilio, mentre la scena è rappresentata da un’inquadratura che è conclusione di un immaginario zoom partito da un “lontano” solo intuibile.
Il diaframma narrativo ha il suo esergo nel ristretto “foro” in cui sembra passerà la luce del racconto.
L’autore, però, abbandona in breve tempo quello che sembrava il primitivo luogo dell’indagine e sposta l’obiettivo su un nuovo piano: l’amicizia tra Esilio, Gaspare e Peppina.
La casa di Petralìa, Salvatore e sua moglie Agata, mediante uno zoom all’indietro, si trasformano in ambiente sottinteso e sembrano abbandonare il ruolo di protagonisti.
In altri termini, il campo diventa medio e mostra l’incrocio e l’incontro di alcune delle anime che caratterizzano la storia. Il rapporto tra Esilio e Gaspare prevarica, pur in un ambito solo a tratti esplicitato di confidenze ed esperienze condivise, quello che, originariamente, sembrava il “master” originale del racconto.
Eppure, ancora una volta, l’autore ci abbandona e frantuma il palinsesto su cui la nostra fantasia di lettori stava incasellando le tessere di un puzzle in cui far vivere coerentemente modi e personaggi: l’atmosfera rassicurante che avrebbe potuto guidare i protagonisti verso una dolce “fin de partie” è improvvisamente, e di nuovo, manomessa.
Viene così introdotto un Deus ex machina che propone la via d’uscita da una situazione che, contrariamente al “modo” della tragedia greca, appariva sin troppo scontata: la “mechanè”, questa volta è trasgressiva del canone.
Piuttosto, intride di complessità drammatica la storia, ne vanifica ogni certezza e sembra uccidere ogni speranza.
Essa – la storia narrata – che solo apparentemente sembrava possedere una tranquilla logica interna e che si rivela, invece – e inaspettatamente – epifanica di una catastrofe delle esistenze.
Lo zoom si è ulteriormente allontanato, il campo è diventato lungo, nebbioso: la conclusione non sarà quella prevista e prevedibile. La profondità di campo non raggiunge l’orizzonte.
Sembra, dunque, che sia lo stravolgimento delle emozioni e delle vite dei personaggi la nuova modalità conduttrice del racconto.
Eppure l’intuizione sollecitata e le modalità progressive del narrare finiscono per suggerire che non sono Salvatore, o Esilio o Gaspare o Petralìa i reali protagonisti della storia.
Protagonista vero è il tempo.
Quello che dal ventotto ottobre del 1922 si prolunga sino ai giorni attoniti della fine della guerra.
In primis, un tempo locale che trascorre per anni nella vita dei protagonisti senza mai renderli edotti dei possibili rischi di tragicità; quasi disinteressato alle loro vicende di piccoli personaggi interpreti solo di se stessi. Sorta di universo parallelo, a lungo minimalistico, che è obbligato a fare i conti con l’altro, concreto e devastante, che irrompe improvvisamente a spezzare certezze e a distruggere sentimenti ormai sedimentati e accettati acriticamente.
Dunque, due universi temporali – l’uno ignoto all’altro e convissuti per anni senza sfiorarsi – improvvisamente si fondono.
Agli occhi di Salvatore e degli altri protagonisti appare, crudele Moloch, il nuovo tempo: quello rappresentato e conseguente all’avvento del fascismo; opprimente con le sue storture ideologiche – le leggi razziali (Salvatore casualmente si scopre ebreo) – con l’arroganza di insignificanti nobilucci di paese (convertiti a un’improvvisa sovrastruttura di fede mussoliniana) e con il disastro della guerra.
È a questo punto che Infante introduce l’operazione di sovrapposizione letteraria nei confronti dell’impalpabilità del tempo/ambiente, che aveva permeato l’atmosfera iniziale del romanzo, facendolo soccombere a quello tragico della grande storia incombente su una piccola umanità inconsapevole. (Ed è emblematico, ad esempio, il passo in cui l’autore scrive: “A casa di Salvatore, però, il tempo sembrava sospeso, attaccato all’orlo di un giorno che non voleva iniziare”[pag. 8].Certo riferimento al tempo circoscritto di Petralìa, ma aleggiante rimando a un altro grande tempo immanente).
In altri termini, lo zoom sul racconto torna ancora in avanti a circoscrivere la scena, individuando, appunto e ancora, nel personaggio “tempo” il vero protagonista.
Ma ecco che l’autore sente, di nuovo, la necessità di cambiare inquadratura, confermando la scelta di essenzializzare il nuovo elemento principe della storia narrata.
Obbligato dalla necessità di trovare una via d’uscita da un possibile fatalismo necrotico (che avrebbe cozzato con l’ottimismo della volontà che permea il romanzo), Infante recupera il tempo dell’uomo pensante che, diversamente da quello silenzioso ed asettico dell’universo e della “Storia”, contiene – né potrebbe essere diversamente – la cifra della speranza: quella che Salvatore ed Esilio credono di intravedere al fondo del buio tunnel in cui è stata imprigionata la loro vita.
Ed è così, in nome della necessità di raccontare il conflitto, neanche tanto sottinteso, tra tempo della storia e tempo del “particulare”, che, in qualche modo, si giustifica il mancato approfondimento delle personalità di quasi tutti i personaggi: da Esilio a Gaspare, da Agata a Bartolomeo e a tanti altri: tutti sono vittime di quel conflitto.
Al di sopra di questi, restano, però, due protagonisti che sono misurati e descritti in un altro piano narrativo.
Il primo è Salvatore, il secondo l’anziano Zu’ Lillo.
Salvatore in quanto criptato alter ego dell’autore stesso.
Zu’ Lillo in quanto – novello Ersilio Miccio – metafora della saggezza possibile dell’uomo e, soprattutto, testimone che anche il tempo più imperscrutabile, può essere, pur nella sua inesorabilità, interpretato, accettato e compreso. (Emblematiche le sue ultime parole: “sento la neve cadere” un attimo prima di morire [pag. 68]).
Un’ultima nota: il linguaggio.
Non sempre è coerente con le emozioni e con i drammi vissuti da personaggi privi di cultura.
L’autore – ad esempio – in alcuni passaggi, fa parlare Salvatore (già contadino analfabeta: Salvatore non aveva studiato, non sapeva leggere e non sapeva scrivere [pag, 20]
con un lessico da filosofo o da poeta. Stilemi forzati che sono giustificabili proprio – e solo – perché Salvatore stesso rappresenta il suo alter ego; ma che finiscono per costituire una frattura e una violazione dell’unità letteraria del romanzo, se non una concessione smaccata alla vanità scrittoria.
In conclusione, “Sento la neve cadere” è un bel romanzo, soprattutto se si pensa allo sconsolante panorama di una letteratura, quella prevalente nei gusti modaioli, che si nutre di penose imitazioni di fasulli codici vinciani, di facili rappresentazioni di erotismi d’accatto esercitantesi in noiose sfumature variamente colorate, o di ridicole rivisitazioni di racconti polizieschi.
 Sento la neve cadere
Sento la neve cadere
Narrativa italiana
Scritture & scritture
2014
128 p, brossura