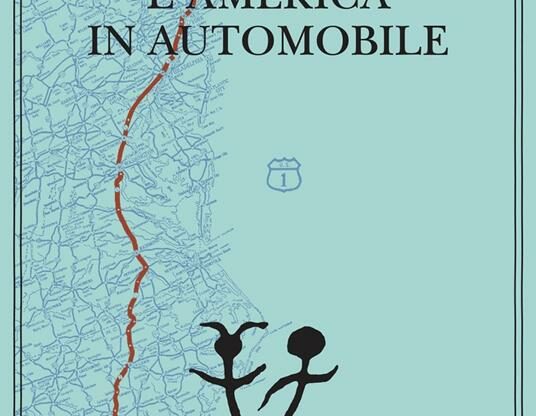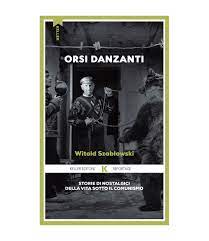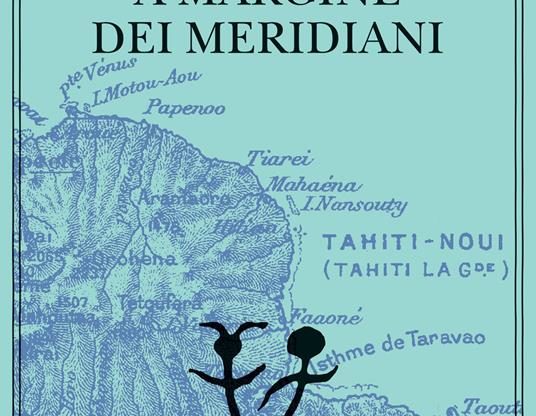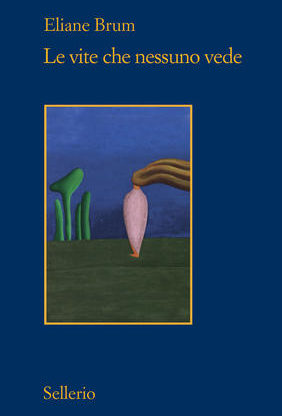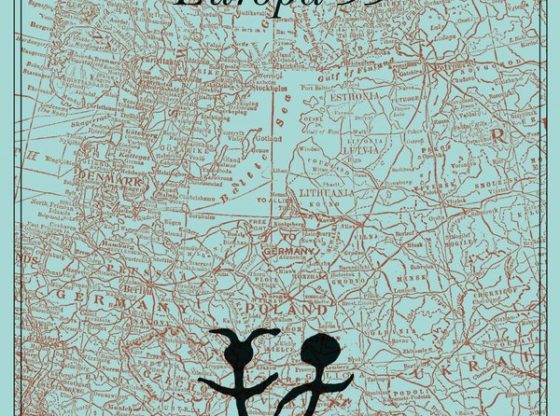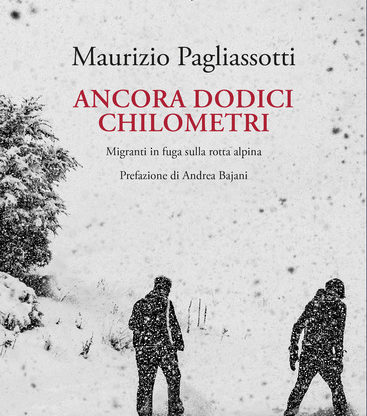Diario slovacco
Di Marcello Caprarella
7 maggio 2018 (Madrid)
Partiremo per la Slovacchia venerdì 11. Mio cugino G. si sposa sabato 12 con D., che vive in una cittadina che si chiama Spisska Nova Ves. Sono molto incuriosito dal paesaggio umano e naturale che ci attende laggiù. Ho sempre fatto il tifo per D., che mi sembra una ragazza meravigliosa. Ho incrociato le dita fino a un mese fa, sperando che mio cugino non mandasse tutto a monte. Non è accaduto, per fortuna. Ieri, domenica, abbiamo iniziato a pianificare un po’ il viaggio. Saremo fuori una settimana intera, approfittando del ponte di San Isidro, patrono di Madrid. Bisognerà ridurre al minimo il bagaglio perché viaggiamo con Ryan Air. Avrei voluto ritardare fino a giovedì l’ansia pre-viaggio, ma mia moglie ha già iniziato a tirare giù dagli armadi trolleys e vestiti che ci riscaraventano in pieno inverno. Il luogo di residenza della futura sposa di mio cugino, infatti, si trova alle pendici dei monti Tatra, e le previsioni del tempo sono catastrofiche: freddo e pioggia, praticamente senza interruzioni. Il parentume nostro ha declinato in massa l’invito, il che è un grosso bene. Saremo in pochi, scelti e caotici. Mancherà solo lo zio G. di Brescia, e mi dispiace.
8 maggio
Giornata praticamente senza senso, quella di ieri: palestra, traduzione di documenti sulla politica della privacy di un operatore che affitta voli privati e un’uscita con mia moglie, poco prima di pranzo, per andare a comprare delle scarpe da ginnastica. Di quelle con la suola robusta, possibilmente a carrarmato, per non lasciar trapelare l’acqua. Per il vicino matrimonio del cugino G. nei boschi slovacchi, insomma. Ieri eravamo ancora nella giungla urbana di Cuatro Caminos, a Madrid, nel mio quartiere. Sulla calle Bravo Murillo, andando verso nord, tra le stazioni della metropolitana di Alvarado e di Estrecho, c’è una miriade di negozi di scarpe da ginnastica. Io direi che c’è una bolla commerciale – così come c’è stata e c’è quella immobiliare – delle scarpe da ginnastica. I prezzi sono assurdi, inaccettabili. Il prodotto, sul quale viene apposto il logo di una marca rinomata, è fabbricato in Cina o in India, da schiavi che sono spesso bambini e che lavorano in condizioni disumane, a cottimo e con stipendi da fame. Eppure, quando si arriva al termine della filiera, cioè al prodotto finito, è difficile trovare qualcosa per meno di sessanta euro persino nei negozi che annunciano saldi per chiusura dell’attività. Parliamo di costi di produzione di poche decine di centesimi: una base di gomma, piuttosto sottile, e un rivestimento di plastica. Tutto qui. Aggiungiamoci pure i costi fissi, quelli di spedizione e le tasse varie, e arriviamo a cinque euro al massimo. Il margine di guadagno delle multinazionali e degli intermediari che si contendono questo mercato in perenne crescita (siamo tutti forzosamente sportivi e dinamici!) è osceno. Per i modelli più sofisticati e trendy, di quelli che piacciono molto ai rappers del Bronx – suola alta, tomaia che imprigiona la caviglia e colori improponibili – si va dai novanta euro in su. Ho iniziato a urlare. Mia moglie mi ha detto: “O la smetti di farmi vergognare o io me ne torno a casa!”. Alla fine abbiamo trovato un negozietto in cui vendono calzature portoghesi: Guimaraes. Trenta euro. Suola alta, che almeno non si consumerà nel giro di tre settimane. Made in China, ovviamente. Mia moglie era contenta dell’acquisto ed è voluta tornare nel negozio nel tardo pomeriggio per comprare un paio di scarpe da ginnastica simili alle mie anche al figlio piccolo. Sono rientrati all’ora in cui iniziano i telegiornali e i valzer delle rondini. Io guardo entrambi, telegiornali e rondini, tutte le sere, in questa primavera di incertezze di ogni tipo. Un occhio rivolto al televisore e l’altro alle rondini, che ieri sera erano come kamikaze che si pentono all’ultimo momento, davanti alla Pearl Harbour della finestra del salone di casa nostra. Così si è chiusa la giornata.
9 maggio
Ieri non sono andato neanche in palestra. A dire il vero, se si esclude la traduzione del documento sulla politica inerente alla privacy dei voli charter per ricchi, non ho concluso niente. A me piacerebbe viaggiare come i ricchi, con volo privato e nessuna preoccupazione. A bordo, tartine e champagne, e bagagli senza limiti. Altro che deportazione per mano e ali di Ryan Air! Sono iniziate le grandi manovre per la trasferta slovacca, e mia moglie si occupa di tutte le questioni pratiche. “E allora tu che c’entri?”, mi si potrebbe domandare. C’entro eccome, perché mia moglie mi rinfaccia l’inettitudine. Io non sono Zeno Cosini, ma mia moglie è come Augusta, la moglie di Zeno. Parafrasando la descrizione di Italo Svevo, io potrei dire che per lei, per mia moglie, il presente è una verità tangibile in cui ci si può segregare e stare caldi. La perfetta salute, avrebbe detto Zeno. E allora è giusto che se la veda lei con il presente, che ieri erano tutte le angherie pre-imbarco della compagnia aerea, che iniziano vari giorni prima del viaggio. Bisogna scansionare carte d’identità e prenotare il posto a sedere per non rischiare di viaggiare nella stiva, a sessanta gradi sottozero, assieme ai trolleys; che a loro volta non vanno riempiti troppo, altrimenti, infatti, si sfora la misura standard e ti fanno pagare 50 euro a millimetro cubico in più, sull’unghia, prima di farti salire a bordo. Insomma, sono paralizzato dall’ansia. Sto pensando di viaggiare senza bagaglio, indossando tutti i vestiti che mi serviranno per il soggiorno tra i boschi slovacchi: sei mutande, sei maglie della salute, sei paia di calze, quattro camice, due maglioni, una felpa, la giacca e un k-way per la pioggia, a costo di sembrare l’omino della Michelin. Sotto le canottiere, il computer. Così, se mi perquisiscono, potrò dire: “Tocchi pure! Sono un finto obeso! Che addominali, eh? Nemmeno Cristiano Ronaldo!”. A Bratislava – e sempre ammesso che l’aereo non cada, e addio programmi… – potrò spogliarmi di tutto e mettere gli indumenti in una busta (grande) della spesa perché prenderemo il treno e acquisteremo pane, salumi e formaggi per il viaggio, che dura quasi quattro ore. Non abbiamo prenotato i posti a sedere sull’interregionale, ma sulla terraferma mi sento più tranquillo. Alla biglietteria della stazione di Bratislava ci saranno di sicuro delle brave persone. Un bigliettaio umano, macerato in acquavite, con i baffi brizzolati e l’uniforme delle ferrovie slovacche. Uno che non saprà nemmeno l’inglese. Io gli dirò, con il migliore dei miei sorrisi (ho una dentatura bellissima, perfetta): “Spisska Nova Ves…”, indicando che siamo in quattro, come un bambino che dice di avere quattro anni. E lui brontolerà qualcosa in slovacco, ma in modo innocuo e nasale, e mi consegnerà i biglietti. Trovare il binario non sarà difficilissimo. La stazione di Bratislava è piccola, ho visto la piantina su Google. E anche tutti gli orari e le fermate dei treni della tratta Bratislava-Kosice, la nostra, conosco. E poi, all’arrivo a Spisska Nova Ves, in stazione, ci sarà mio cugino con la macchina, ed ormai sarà fatta. L’albergo, a cinquecento metri dalla stazione: Hotel Metropol, quattro stelle, cesso (senza bidet) in camera. Birre. Grandi. Varie. Cena di benvenuto a base di formaggi e insaccati locali, identici a quelli acquistati al supermercato di Bratislava poche ore prima. Il giorno dopo, colazione continentale (insaccati e formaggi à gogo) e cerimonia in Comune, alle 15 e 30. Il pranzo lo salterò. Mi rifarò a cena, con gli interessi. Menù nuziale tutto selvaggina. Mio cugino ha ingaggiato anche un’orchestrina locale. Non ballerò. All’ottava Pilsen sarò in grado di farmi capire anche dai parenti della sposa slovacca. Diranno, nella loro lingua: “Questo è il cugino di Madrid!”. E poi, per farsi capire bene: “Messi, Sergio Ramos, paella!”. Il carrello dei liquori! Il trenino brigittebardobardò, invece, lo salterò. Saremo salvi fino a martedì prossimo, quando bisognerà di nuovo entrare nel sito web della Ryan Air e rifare tutta la trafila delle carte di identità e della dichiarazione del bagaglio. Ho rivelato a mia moglie questa mia visione, e lei è stata sadica: “È tutto abbastanza verosimile, eccetto il passaggio alla stazione dei treni di Bratislava. È probabile che non ci sia la biglietteria con l’operatore fisico, e che i biglietti vadano acquistati alle macchinette. Però non ti preoccupare: faccio tutto io!”. Io so che un giorno mia moglie partirà con i ragazzi e che mi lasceranno a casa, a guardare National Geographic dove, nelle visite guidate alle città d’Europa, non c’è mai un intoppo, mai un imprevisto, mai la diarrea del viaggiatore. Ma io so tutto il lavoro che c’è dietro a un risultato del genere, e non invidio gli inviati. Gente senza famiglia e con il pelo sullo stomaco.
10 maggio
Molto poco da dire. Fervono i preparativi per la partenza, bolle l’ansia da Ryan Air. Ieri l’ho scaricata in parte al GoFit, all’alba. Poi ho cercato di scongiurarla con il lavoro, ed è aumentata. È ridiscesa, complice l’ilarità, all’ora dei telegiornali, quando ho ascoltato che si prefigura il governo Salvini-Di Maio. Churchill diceva che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte le forme di governo sperimentate prima. Se avesse visto il TG2 serale di ieri, forse, avrebbe aggiornato l’aforisma.
11 maggio
La prima impressione della Slovacchia è di una terra intermedia tra Svizzera e Romania. Siamo in treno. C’è il Wi-Fi. E una macchia colorata di zingari. Un passo indietro. Siamo partiti da Bratislava. I tassisti intimidiscono. Mi hanno fregato sul prezzo della corsa dall’aeroporto alla stazione. Non fa niente, ma la logica depredatoria applicata allo straniero “ricco” sembra la regola. In una bancarella ho comprato una bottiglia grande d’acqua. Ho chiesto dei bicchieri di plastica; il donnone che era dietro il bancone me li ha fatti pagare cari e me li ha porti mettendoci le dita dentro. Questa cosa mi è piaciuta perché so che il donnone non l’ha fatta apposta. Parte il treno. Il paesaggio è sconcertante. A tratti è bellissimo, nell’esplosione dorata dei fiori delle rape, che io non avevo mai visto in distese così grandi e che nulla hanno da invidiare a quelli dei campi provenzali di lavanda. All’improvviso, però, appaiono dietro qualunque curva i profili delle ciminiere, le contorsioni della ghisa e la cementificazione di un patchwork urbanistico un po’ sovietizzante, prima di arrivare in qualche stazione. Gli zingari sono scesi, allegri e furtivi, davanti allo scheletro mostruoso di una fabbrica abbandonata. Forse vorranno spolparla ancora un po’. Il nome della stazione non lo ricordo. Iniziava per R. Attorno, grandi condomini, un tempo omogeneamente grigi. Li hanno ridipinti – negli anni Novanta, credo – di colori allegri, e questo li rende ancora più tristi, come Aschenbach che si tingeva i capelli a Venezia. Poi arriviamo nella zona dei monti metalliferi, che precede quella dei monti Tatra, e che è tutta verde, senza deturpazioni eccessive. Segherie, cave sui laghi, la mano dell’uomo e la forza di una natura muta, concentrata su sé stessa. Interrompo qui…
Siamo arrivati a Spisska Nova Ves. Dalla finestra dell’albergo si vedono i monti Tatra. Paradossalmente, sono più imponenti se visti da lontano. Mi sento in una casa che non è mia, ma a casa. Come protetto e accerchiato. Tra poco arriveranno per il matrimonio di mio cugino G. i parenti buoni e quelli nuovi, cioè quelli di D., la sposa locale. I figli sono eccitatissimi dalla prospettiva di acquisire dei remotissimi zii e cugini slovacchi. Dopo quello che hanno subito dai parenti più stretti, è ammirevole questo loro atteggiamento. E mi fa molta pena, ma non lo do mai a vedere.
12 maggio
La cena, ieri. Alle sei del pomeriggio non c’era neanche un negozio aperto, e la città sembrava un borgo scandinavo, ma più scorbutico. La poca gente che incrociavamo camminava a testa bassa. I figli erano stupiti e immalinconiti dal silenzio. Poi, un’ora dopo, si sono iniziate ad aprire le taverne, come a un segnale convenuto, e tutto si è riscaldato. Mio cugino G. ha organizzato l’accoglienza degli invitati alla perfezione. L’apporto di D., la futura sposa, è stato comunque decisivo. Si è fatta in quattro, anche perché la comunicazione tra noi e gli invitati slovacchi è difficile. Dalla seconda birra in poi, seguendo i miei programmi, ho tentato di miscelare un esperanto con i nuovi e remoti parenti che sto per acquisire: spezzoni di tedesco avventuroso e ai limiti del temerario con lo zio T.; un improbabile francese con le vecchie zie. Una certa, scanzonata rigidità. Con gli altri, i giovani e quelli della mia età di mezzo, la convenzione dell’inglese da convenzione, più illusoriamente scorrevole. I più allegri sono stati i figli. Per loro, abituati a una famiglia nucleare, scoprire di avere una famiglia allargata e che si interessa al loro mondo è una gioia. Hanno voglia di raccontarsi e di sapere. Il cugino V. detto E. parla e li fa parlare. Oggi c’è il sole e usciremo a passeggiare prima della cerimonia, che sarà come la prima Domenica in, quella condotta da Corrado: civile e pomeridiana. Poco fa lo zio J. di Bratislava, ancora malconcio dalla cena di ieri sera, mi ha incrociato a colazione e mi si è rivolto in un tedesco veloce e impastato. Ho capito solo “Spazieren?”. Gli ho detto di ja. E ci siamo sorrisi in segnale di tregua. Vorrei incontrarlo in strada, più tardi, come per caso. E offrirgli una birra. E un’altra ancora. E parlare piano, capirsi bene, a fondo e non solo partendo dalla buona volontà alticcia. E poi arrivare in Comune, per la cerimonia nuziale, a braccetto e stonando canti da osteria slovacchi. Immagino che il repertorio sia sterminato. I ritornelli li imparerei subito. Sono bravo per queste cose, c’ho orecchio per le lingue.
13 maggio
La giornata di ieri ci è entrata dalle finestre, prestissimo e bellissima. Qui fa giorno prima, siamo più ad est. E non si usano persiane. Alle cinque del mattino la nostra stanza era già tutta inondata di luce che ritagliava trapezi di pulviscolo atmosferico nell’aria. Abbiamo poltrito a letto ancora un po’, in attesa della colazione delle 7 e 30. Dalla strada arrivavano i primi rumori di un sabato che, qui, è lavorativo. È passato un camioncino pieno di zingari e di ortaggi. In strada, ancora e sempre, solo gli zingari a parlare, che da queste equivale a fare chiasso. La popolazione locale è muta e gentile. Abbiamo fatto una lunga passeggiata assieme al cugino V. detto E. e a sua moglie L. Una chiesa protestante, moderna, e una gotica e cattolica; una di fronte all’altra, in pacifica convivenza, simboleggiavano un po’ la storia di queste zone, sempre di frontiera con qualcosa e solo da poco in pace. Un mercato dei fiori tristissimo, come in technicolor, vicino a un piccolo parco; i venditori sembravano i polacchi che trent’anni fa, in Italia, vendevano binocoli e matrioske. Attorno, ubriachi addormentati sulle panchine. Di ritorno in albergo, vestizione prima del matrimonio. Nulla da fare: ogni volta che vedo il figlio piccolo in camicia e giacca penso a una comunione di paese degli anni Cinquanta dello scorso millennio. O a un matrimonio contadino senza datazione. La cerimonia nel salone delle feste del Comune di Spisska Nova Ves è stata semplice e sontuosa. L’ha officiata una specie di deputato provinciale, con un aspetto da energumeno barbuto e al collo un medaglione che gli dava un’aria tra un sommelier e Mangiafuoco. Ma era un uomo gentile, e ha detto delle cose sicuramente belle e poco burocratiche, e alla fine ha sorriso e ha fatto entrare una soprano e un tenore molto bravi, accompagnati da un pianista. Hanno cantato una canzone italiana in onore di mio cugino G., lo sposo. Era una canzone il cui ritornello diceva Io vivo per lei. Credo di averla sentita cantare da Andrea Bocelli. L’idea è stata del Comune: mio cugino non aveva chiesto niente. Il tenore e la soprano erano giovani, entusiasti e dall’aria contadina, e questo mi ha commosso molto. Dopo, preceduta da un silenzio dolcissimo e vago come il sole che entrava dalle vetrate, è entrata una signora sulla sessantina, dall’aria della professoressa di liceo in pensione, e ha recitato quella che mi è parsa una poesia. Era una donna elegantissima. Uno degli invitati, un cugino della sposa con il quale si poteva parlare in inglese, mi ha dopo detto che, in effetti, l’attrice aveva recitato un testo poetico locale, in cui si parlava di vite da coniugare al plurale. L’invitato non sapeva chi fosse l’autore del testo. A me piace pensare che l’avesse scritto la signora. Mi è sembrata degna di questo e di altro. Poi è sparita, con la stessa eleganza rarefatta e laterale con la quale era entrata in sala. All’uscita, c’è stata la vera commozione perché sono arrivati i vicini di casa della sposa. Gente modesta, famiglie di operai in pensione. Tutti gli uomini portavano un mazzo di fiori da regalare alla sposa; glielo consegnavano togliendosi il berretto, con una umiltà e una deferenza affettuosissime, come fosse per loro un privilegio timido. Anche la madre della sposa, vedova da quando la sposa (figlia unica) era bambina, si è mostrata molto commossa e confusa, e questo ha aumentato la commozione e la confusione di tutti. E poi la festa. Ho parlato a lungo con lo zio J., e ci siamo capiti in tedesco. Mi ha detto che le canzonette italiane erano per loro, per gli slovacchi che sottostavano alla ferula della dittatura comunista, come una finestra aperta sui sogni della libertà e che, quindi, potevamo pure accusarli di avere gusti volgari, ma Umberto Tozzi, Albano e Toto Cutugno non glieli dovevamo toccare. Come dargli torto? I nostri nuovi parenti slovacchi sono tutti – vecchi, giovani e di mezza età – ballerini provetti e instancabili, oltreché bevitori imbattibili. I musicisti e il fotografo, a poco a poco, si sono diluiti nella festa, che si è conclusa in un crescendo di balli locali, con mio cugino e la sposa vestiti da pastori valacchi. È stato tutto molto bello e siamo felici di essere qui. Anche stamattina c’è un sole caldo e inatteso, e andremo in giro a visitare qualche paesino dei monti Tatra. L’aria è cristallina come il canto di un affilatore di coltelli, in una lingua infranta.
14 maggio
Ieri mattina siamo andati a visitare Kezmarok, a una ventina di chilometri da Spisska Nova Ves, andando verso i monti Tatra. Dalla macchina si vedeva un panorama maestoso, di prati verdissimi e chiazzati dal giallo delle rape fiorite. Queste ultime si utilizzano per fare l’olio industriale di colza, stando a quanto mi ha detto D., la novella sposa. Forse non avrebbe dovuto rivelarmi questo dettaglio, perché ha un po’ annacquato la carica poetica che avevo attribuito a queste enormi e onnipresenti distese dorate. Arrivati a destinazione, abbiamo visitato le rovine di un castello e poi siamo andati a bere l’inevitabile pivo, cioè il birrone, accompagnato da un piccolo spuntino. Il cameriere che ci serviva era un compagno di scuola elementare di D., il che ha contribuito ad accrescere in noi tutti la sensazione di trovarci in un posto che sapeva di casa e vicinanza. Mio cugino V. detto E., che ha 54 anni suonati, diceva di sentirsi ringiovanito dall’atmosfera ingenuamente bucolica del luogo. Le bambine, vestite a festa e tutte bionde e bellissime, si preparavano per la comunione. In piazza c’era uno spettacolo di balli tipici, e la gente cuoceva al sole e sembrava felice. Gli unici a non partecipare a questa festa della vita erano gli zingari, che notavo accigliati e imbronciati, e che formavano dei capannelli a sé. Erano ormai le 14 e 30 quando ci siamo rimessi in macchina, e il cugino V. detto E. ha dichiarato che gli anni che si sentiva addosso erano ormai 42 o 43. “Ma la sentite l’aria?”, ripeteva in continuazione. Già in albergo, poco dopo le 15, siamo andati nella spa. Eravamo io, mia moglie e il figlio piccolo. Il figlio grande non è venuto, ed è stato un bene. Ci hanno ordinato di denudarci completamente, cioè di toglierci anche il costume da bagno, prima di consentirci di sommergerci nella jacuzzi. Abbiamo subito l’umiliazione in silenzio. Il figlio piccolo, al quale la professoressa di geografia ha chiesto di fare una ricerca sulla Slovacchia, da presentare al ritorno a scuola, ha detto: “Papà, sta’ tranquillo: questo non lo metto!”. Mia moglie è preoccupata per quello che potrò scrivere su questo diario al riguardo. La verità nuda e cruda, come sempre. Avevamo prenotato la cena in un bel ristorante di Spisska Sobota. Spisska è il prefisso di molti paesini della regione, il cui nome è, appunto, Spisska. Sobota significa sabato. Il paese era sede della fiera agricola settimanale, fino a qualche anno fa. Oggi questo sabato del villaggio permanente è un gioiellino turistico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Cena ottima, ma senza pane, con grande dispiacere di mio cugino V. detto E., al quale sono ricaduti tra capo e collo almeno sette o otto dei dieci anni dei quali aveva creduto di essersi sbarazzato. Coerentemente, ha pagato la cena: “Fate fare a me! Sono il cugino più anziano!”, ha proclamato, quasi paterno. Solo all’uscita dal ristorante, nel corso della passeggiata nella grande piazza spettrale circondata da baite in legno, ha ripreso la cantilena del ringiovanimento: “Ragazzi, che pace! Se potessi rimanere un mese qui, riprenderei a correre come facevo da ragazzo. Mi sento addosso 41 anni!”. Stamattina è ripartito all’alba, in macchina, assieme a sua moglie L. e a U., un altro nostro parente. Questo U è un giovane ingegnere ventottenne che non mi sembra abbia guadagnato anni di vita nel corso del soggiorno slovacco. È anzi probabile che se la sia accorciata, la vita, per tutto quello che ha bevuto. A quest’ora (sono le nove) il trio starà per arrivare a Bratislava. Io calcolo che, a partire da quel punto, il cugino V. detto E., partito quarantunenne, riacquisterà un anno ogni 100 chilometri. A Foggia ritroverà tutto il peso della vita.
15 maggio
Ieri siamo stati a Levoca. La grafia corretta non è proprio questa. Non ho riportato bene nessuna delle grafie dei centri abitati che stiamo visitando qui in Slovacchia perché la lingua locale ha dei segni grafici che non riesco a trovare sulla tastiera del mio pc. Poco male. Levoca deve la propria fama turistica alla basilica di San Giacomo, gotica, del XIV secolo. A sua volta la chiesa, di impianto semplice a tre navate e dodici colonne, è famosa per l’altare in legno, costruito dalla gloria locale: il maestro Pavol di Levoca, attivo nella prima metà del XVI secolo e che ci ha regalato una meraviglia per la quale non è stato utilizzato neanche un chiodo, ma si è fatto ricorso solo alla tecnica dell’intarsio. Oltre alla chiesa, la cittadina ha di bello anche una cinta muraria, risalente allo stesso periodo della costruzione della basilica, e una gogna tardo-medievale autentica, al centro della piazza in cui si trova anche il municipio. Prima di entrare nel centro storico, si attraversa l’immancabile quartiere degli zingari, ai quali le autorità locali hanno assegnato delle casette coloratissime e, perlomeno esteriormente, graziose. Di zingari se ne vedono dappertutto, in Slovacchia. Costituiscono circa un dieci per cento della popolazione, che non arriva a cinque milioni e mezzo di abitanti. Ma gli zingari sono quelli che si fanno notare di più, per colore e volume delle conversazioni. Se (si fa per dire) in strada ci sono 60 decibel, 55 ne vengono prodotti dagli zingari, che così invertono le proporzioni demografiche. Chiasso a parte, D. dice che gli zingari non fanno niente, in una doppia accezione: sono ufficialmente nullafacenti e non particolarmente pericolosi. Vivono di raccolta di ferrame, piccoli e fisiologici furti, musica suonata alle feste, artigianato eventuale e discontinuo… Non sono malvisti come in Ungheria o in Romania. Lo Stato slovacco gli assegna un piccolo sussidio, che aumenta in funzione del numero dei figli del capofamiglia. Non è infrequente vedere ragazzi zingari dell’età del mio figlio maggiore accompagnati da una sposa bambina incinta o già madre. Anche ieri ho visto alcune di queste coppie. Poi ci sarebbe da parlare della birra. Succede come per il vino in altre nazioni: finanche la più piccola contrada ne produce, e sono tutte ottime, le birre. Quella di Levoca, assaggiata in un ristorante attaccato al municipio, era fresca e amara al punto giusto. Al commovente prezzo di un euro per un boccale da mezzo litro. Mia moglie mi guardava preoccupata perché ha intuito che io, se vivessi qui, sbanderei di brutto e potrei pure permettermelo. La basilica l’abbiamo visitata dopo pranzo, e poi, approfittando di un sole un po’ anemico e spuntato a sorpresa tra i nuvoloni che minacciavano pioggia, siamo andati a vedere la casetta nel bosco che possiede la famiglia di D., a due passi da Spisska Nova Ves. Manca l’acqua corrente, che si va a prendere, gelida e cristallina, da una vicina fontana. La pineta che circonda la baita di D. è immensa, profumatissima e risuona dei canti di un sacco di uccelli dei quali non so il nome. A terra, mentre passeggiavamo, abbiamo trovato due aquilotti che erano caduti da un nido. Non ancora riuscivano a volare. Il figlio piccolo voleva prenderne uno in mano, ma mio cugino G. gli ha detto di non farlo perché, se avesse annusato l’odore dell’umano sul piumaggio, la mamma aquila avrebbe respinto il pulcino. Ogni tanto, nelle radure, si vedevano altre costruzioni in legno del tutto simili alla casetta di D. e della sua famiglia Avevano tutte i tetti molto spioventi, per favorire lo scivolamento della neve in inverno. Qualcuno si è fatto anche un piccolo orticello o un giardino minimo, con al centro una griglia. Sono abitazioni che si possono godere solo con il bel tempo. Poco più che capanni dei giochi dei bambini visti in Pippi Calzelunghe. Proprio per quello evocano estati infinite e una felicità semplice. Mia moglie non faceva altro che ripetermi: “Tu, in una casetta del genere, a leggere e a scrivere, ci staresti da padreterno!”. Io, in una casetta del genere, forse leggerei Tolstoj, ma non perderei tempo a scrivere le stronzate che scrivo. Le cose è meglio viverle che ricordarle. O ricordarle dopo averle vissute senza freni. Il bello e il vero nascono solo così. Bisognerebbe scrivere come Pavol di Levoca costruiva un altare: senza chiodi, senza forzature, con tutti i pezzi che si incastrano senza sforzo.
16 maggio

Abbiamo trascorso tutta la giornata di ieri a Spisska Nova Ves. Dopo le emozioni e gli spostamenti dei giorni scorsi, una pausa era necessaria. L’albergo Metropol è quasi vuoto. Gli invitati al matrimonio sono ripartiti tutti e c’è poco movimento. In zona ci sono diversi grossi stabilimenti di multinazionali che hanno scelto di trasferire la produzione in Slovacchia. Oltre ai salari più bassi rispetto a quelli di quasi tutti gli altri paesi della UE, ci sono gli incentivi garantiti dal governo slovacco, specialmente la flat tax del 19% sui guadagni. Questa presenza dell’industria fa sì che ogni tanto incrociamo nella hall dei tecnici in trasferta venuti dalla Germania o dall’Italia. Di dirigenti ne ho visti solo un paio, ma uno di loro era chiaramente un pezzo grosso. È successo poco prima delle 11 di ieri. Un addetto alla reception mai visto prima mi ha detto, concitatissimo: “Mister Wood, the car is waiting!“, mostrandomi un macchinone nero, parcheggiato fuori. Stavo per salirci, poco credibile come ero, in tuta e scarpe da ginnastica. “Il solito dirigente sportivo ed eccentrico”, avrà pensato l’impiegato della reception. I romanzi iniziano così, d’altronde. Ma poi è arrivato il vero Mister Wood, elegantissimo in un gessato sartoriale da consigliere delegato e scortato da una stangona vertiginosa, che gli sussurrava nell’orecchio gli appuntamenti della giornata, e da un vice, vestito in modo più modesto, da ingegnere in tiro. La città, di mattina, era vuota. La gente lavora quasi tutta in campagna o in fabbrica. D., la moglie di mio cugino G., dice che non è vero e proprio benessere quello che è arrivato qui dopo l’entrata nella UE, ma che un miglioramento delle condizioni di vita c’è stato. In effetti, negozi di lusso non ne abbiamo visti. E nemmeno centri commerciali che sembrano aeroporti. Ma il costo della vita non è alto; ho dato un’occhiata ai cartelli di un’agenzia immobiliare e ho visto che per acquistare un appartamento di cento metri quadri in pieno centro non si spendono più di ottantamila euro. Di attività commerciale, modesta ma viva, ce ne è: tanti piccoli negozi di generi alimentari, mercerie, un emporio dei cinesi, fiorai… E, soprattutto, birrerie che fanno anche da mangiare. Di clientela, all’ora del pranzo, ne avevano poca. Avevamo appuntamento con la mamma della sposa in un locale tipico, specializzato in carni alla brace. D. faceva da interprete e questo ci ha permesso di scoprire ciò che già avevamo intuito, e cioè che la nuova suocera di mio cugino G. è una persona buona e sensata. Il pranzo, come al solito, è stato generosamente innaffiato da un’ottima birra locale. Nel pomeriggio sono andato con mia moglie in stazione, che è proprio dietro l’albergo, ad acquistare i biglietti per Bratislava. Abbiamo chiesto scusa alla donna occhialuta che lavava il pavimento; portava delle cuffiette per ascoltare la musica, e non ci ha nemmeno ascoltato. La signora addetta all’unico sportello aperto della biglietteria non parlava inglese, ma siamo riusciti a farci capire. Era un po’ stupita perché non avevamo chiesto direttamente biglietti di prima classe. Aveva capito che eravamo turisti. Alla fine, data la differenza irrisoria tra il prezzo della prima e della seconda classe, abbiamo deciso che domani viaggeremo da signori. All’uscita, tre tassisti loschissimi giocavano a morra, come in un film muto, ma di gangsters. Mia moglie ha voluto che ci avventurassimo per una passeggiata nel quartiere ferroviario. Non è orrendo: casette basse e autorimesse con grandi portoni di legno. Molti piccoli parchi, incrostati tra qualche rado palazzone bianco. A me ha ricordato moltissimo Cisanello, vicino Pisa, nei dintorni dell’ospedale. C’erano i soliti zingari, pacifici. Uno solo mi è parso un vero delinquente, da alcune caratteristiche: maglietta nera a girocollo, muscolatura mostruosa, catenone e anelloni d’oro, Mercedes gialla parcheggiata davanti alla casetta color pastello. Parlava al telefono, torvo. A cena, in albergo, è venuto solo mio cugino G. perché D. era sfinita. Nemmeno oggi pioverà. Scrivo mentre gli altri ancora dormono, malgrado la luce sia già entrata da qualche ora, qui in camera. Sarebbe bello tornare qui in estate. Se potessi, comprerei una casetta nei boschi, come quella della famiglia di D. Potrei anche, a pensarci bene. Mi piacerebbe ritrovare questo silenzio. Il figlio piccolo, che è un poeta involontario, ha riassunto brillantemente questa pace sonora. Mia moglie gli ha domandato, rivolta anche al figlio grande: “Ragazzi, vi piacerebbe tornare da queste parti? Avete visto che posti belli ci sono?”: E il piccolo: “Vedere, abbiamo visto. Sentire, niente…”.
19 maggio
Siamo tornati a Madrid. Riprendo la cronaca del viaggio slovacco da dove l’avevo interrotta. Anche mercoledì 16 abbiamo trascorso la mattinata a Spisska Nova Ves. I ragazzi sono rimasti in albergo a studiare per non farsi trovare impreparati al ritorno a scuola. Io e mia moglie siamo usciti e abbiamo fatto un giretto in centro, sentendoci un po’ come operai in cassa integrazione, nelle strade vuote. Solo le salumerie trasmettevano calore umano e commerciale, oltreché un delizioso profumo di insaccati affumicati. Siamo tornati all’Hotel Metropol a prendere i figli, per poi andare tutti insieme a pranzo con i novelli sposi. Tanto per cambiare, carne, patate, formaggi e birra. Tutto ottimo, ma in queste zone si rischia di prendere lo scorbuto, come i marinai dei galeoni. Nel pomeriggio abbiamo provato ad avvicinarci in macchina alla montagna. Siamo saliti in quota, fino a una funivia e una stazione sciistica, ma pioveva e siamo ridiscesi verso Spisska Soboda, il paese fantasma e bellissimo in cui mio cugino V. detto E. si sentiva ringiovanito. Volevamo vedere la finale di Europa League tra Atlético de Madrid e Marsiglia. Prima di cena, approfittando del regalo di uno spicchio di sole, abbiamo passeggiato di nuovo nella piazza deserta. Cercavamo il bar spagnolo Vino&Tapas, intravisto nel corso della nostra prima visita, per prendere un aperitivo. Sotto l’insegna c’era un locale, ma era una pizzeria deprimentissima e di impronta chiaramente slovacca; dalla finestra si vedeva al suo interno un anziano con il naso bitorzoluto e lo sguardo incattivito dall’acquavite. La sorpresa, scoperta da D., si nascondeva alla fine di un cortile interno, a cui si accedeva passando sotto un piccolo arco e in fondo al quale si apriva una porticina. Vino&Tapas era lì. Non era un bar, ma un ristorantino. Di quelli deliziosiesoloperpochielettieintenditori, tanto per capirci. Di quelli che vengono segnalati dalle guide per foodies arrapati di stranezze esclusive. Di spagnolo non aveva che il nome. Il proprietario, nazionalista slovacco, è un difensore dello slow food. E anche dello slow service. Siamo entrati alle 19 e 45 e ci ha servito lui stesso un bicchiere di bianco accompagnato da una cremina di formaggio quando erano ormai le 20 e 30. Va precisato che gli unici avventori eravamo noi e tre slovacchi ricchi che bevevano champagne. Il proprietario-cameriere-maître, in guanti bianchi, ci descriveva in italiano le meraviglie della gastronomia slovacca. Con il pollicione sinistro inguantato ha anche toccato il piattino di formaggio che spettava a me, e si è offerto di ritirarlo e di portarmene un altro, intonso. Quando gli ho suggerito di lasciar perdere, ha capito che sono un disgraziato che non merita nessuna considerazione stellata. A sembrare schifato era lui, coerentemente, in qualità di padrone di uno dei migliori dieci ristoranti della Slovacchia, se dobbiamo credere alle cazzate, lentissime e dosificate, che ci sparava. I muri del locale erano tappezzati di foto che lo ritraevano in posa inespressiva con i migliori chef del mondo, ma in cucina c’era sua moglie, che non abbiamo conosciuto. Per non perdere la prenotazione al ristorante Fortuna, io ho abbandonato il paradiso dello slow food slovacco alle 20 e 40, cinque minuti prima che iniziasse la partita, e il resto della comitiva mi ha raggiunto alle 21, dopo aver ascoltato un’altra difesa a oltranza dell’eccellenza a chilometro zero e a prezzo abusivo del prodotto locale, che il barbuto e rubizzo proprietario di Vino&Tapas considera il migliore del mondo. Invece, al Fortuna, la cameriera era giovane, modesta e pallidissima. L’Atlético ha vinto l’Europa League e abbiamo cenato in maniera abbondante e senza esegesi casearie né vitivinicole. Giovedì 17 siamo ripartiti per Bratislava. La stazione di Spisska Nova Ves ci ha offerto un’ultima immagine concentrata di questo spicchio d’Europa e dei suoi contrasti: da una parte, una capostazione in uniforme che innaffiava con amorevolezza un po’ meccanica ed ebete dei vasi di gerani su una grata di legno. Dall’altra, a due metri di distanza, una banda di zingarelli nerastri che non nascondevano le proprie intenzioni di rapinare della valigia o della borsa chiunque si fosse distratto prima di salire sull’Intercity per Bratislava. Fallito il colpo, si sono ritirati ridendo. Sportivamente, direi. A Bratislava ci siamo arrivati verso le quattro del pomeriggio. Lì la rapina, riuscita, è stata nuovamente ad opera di un tassista: 18 euro, liberi dalle inutili pastoie del tassametro, per un tragitto che è durato a stento cinque minuti e che abbiamo dovuto completare a piedi, dato che l’albergo era in una via pedonale, in pieno centro storico. Tra quest’ultimo e il bel Danubio blu si snoda un’orrenda autostrada. La differenza tra Spisska Nova Ves e la capitale salta agli occhi. Non solo per la popolazione che riempie le strade, ma per l’aria di arrogante modernità hipster che ha Bratislava. Dopo questo primo impatto, però, il turista scopre una società giovane e con voglia di fare. Esclusi i tassisti, tutti sono gentilissimi con i turisti. Avevamo poco tempo a disposizione per girare. Cattedrale, castello e stradine. A me, d’acchito, queste blasonate città centroeuropee sembrano sempre tutte uguali, accomunate dal profumo di zuppa di cipolla e di salsicce che annuso dappertutto. Anche il branco di giovani aragoste inglesi ubriache, in pantaloncini e in maniche corte, credo sia sempre lo stesso: un fantasma spiritoso che si aggira per l’Europa in un road show che annoia il pubblico e in cui si divertono solo gli attori. Bratislava mi ha ricordato molto Praga. L’azzurro e il verde smeraldo pallido dei palazzi dell’Ottocento sono quelli, riconoscibili. Ho ritrovato a Bratislava anche le stesse orrende incrostazioni sovietiche già viste a Praga, a Budapest o a Dresda. Come quella del palazzone bianco degli anni del socialismo reale in piena Piazza dell’Opera, a sovrastare dei bellissimi caffè dall’aria asburgica. E poi, anche a Bratislava, il barocco controriformistico delle statue di bronzo e degli affreschi sui portoni. Ce ne è uno bellissimo, di una Madonna che sembra disegnata da un bambino bravo e che reca la data del 1593, in una casa di fronte al palazzo che ospita l’Ambasciata di Spagna. Se proprio devo trovare una differenza rispetto a Praga, potrei dire che mi è sembrato che Praga graviti verso un polo architettonico germanico, mentre Bratislava ha un’aria più italiana. Più che romana, direi veronese e finanche pisana, nel rosa scrostato di certi palazzi ottocenteschi che ospitano le facoltà universitarie, nei pressi della cattedrale. A cena ci siamo avventati sulle verdure alla griglia e le bruschette di un ristorante italiano, senza vergogna. Il ritorno di ieri, con Ryan Air, è stata la solita mortificazione. Le autorità aeroportuali scaricano i disagi su Ryan Air, trattandola come una intrusa intrufolatasi tra le compagnie di bandiera e assegnandole le piste più lontane dalla zona di imbarco o di arrivo a destinazione. Ryan Air scarica sui viaggiatori la rabbia accumulata per via di questo trattamento. La mia teoria del consumatore vessato trova qui pieno riscontro. Non mi stupirei se tra poco, prima del decollo, ci chiedessero un supplemento per il carburante. All’arrivo stavamo per perdere le valige perché nessuno sapeva quale fosse la sala in cui c’era il nastro sul quale sarebbero sfilate. Abbiamo girato a vuoto per mezz’ora nell’aeroporto madrileno di Barajas, che è venti volte più grande di quello di Bratislava. Io ho cominciato a dare i numeri. So che non dovrei, ma è più forte di me. A quel punto, e direi logicamente, la famiglia si è comportata come Ryan Air, scaricando su di me tutta la rabbia e la stanchezza accumulate. Eppure, io non chiedo niente e, se si eccettuano questi scatti d’ira nei confronti di un mondo assurdo e ingiusto, cerco di rendere felice la mia famiglia. Sono un marito e padre efficiente e low cost, alla fine della filiera delle frustrazioni. A casa ci siamo calmati. Molto ha contribuito il bidet, a raffreddare gli animi.