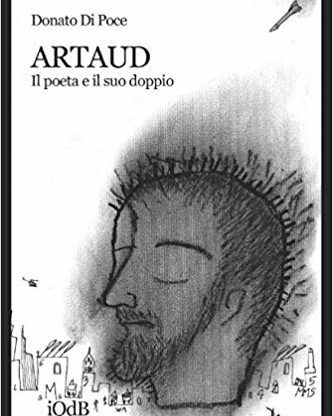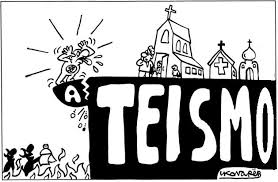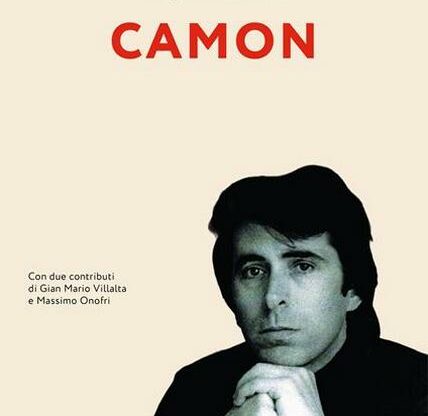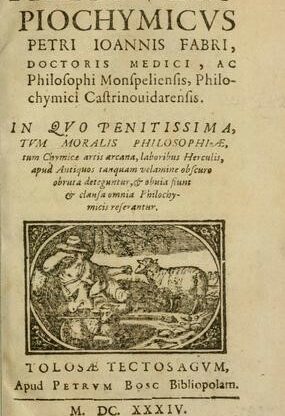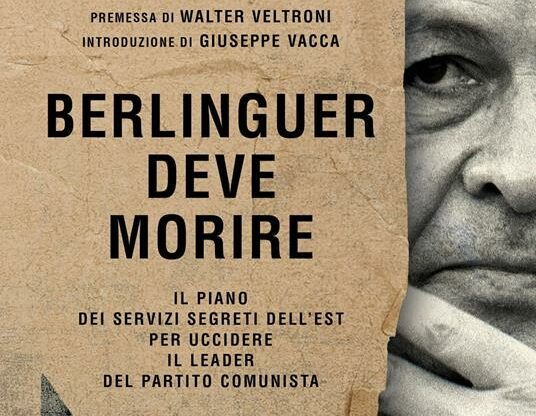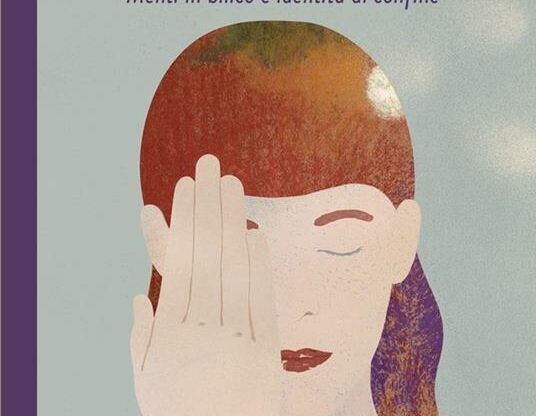La purezza delle viscere.
La stessa ampollosità immensa
Che vi impedisce di pensare
Muta in danza la vostra demenza
Uomini, o larve del creato.
Antonin Artaud, 25 settembre 1922[1]
Di Alessandro Vergari
Pensare ad Antonin Artaud equivale a pensare alla sorgente della poesia e dell’arte, fonte necessaria che ci asseta e ci prosciuga di ogni certezza. Significa attingere all’indefinibile, al cuore oscuro della verità, al taglio noumenico. Donato Di Poce, poeta-artista di impegno civile, sensibile, eclettico, intuitivo, qui coadiuvato dai disegni di Lorenzo Menguzzato, ci accompagna nella velenosa sintassi di Artaud, nel suo vocabolario di crudeltà. Negli abissi scavati da una primordiale, caotica sofferenza scorrono i versi devoti di Di Poce, in assonanza non solo con il terribile marsigliese, ma anche con la penna dinamitarda degli autori estremi amati dallo stesso Artaud: François Villon, il “divino” De Sade, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Gérard de Nerval. Autori capaci di sostenere il peso di una ribellione totale. Sono le pozze di disagio, cui si abbevera il giovane Artaud. Sono i Maestri. Impara, da loro, a disimparare ogni regola, a possedere lo scandalo, a sillabare la magia, a sfidare il reale, ad evocare i tormenti sopiti sotto le architravi del mondo: siamo stalattiti inzolfate di cultura.
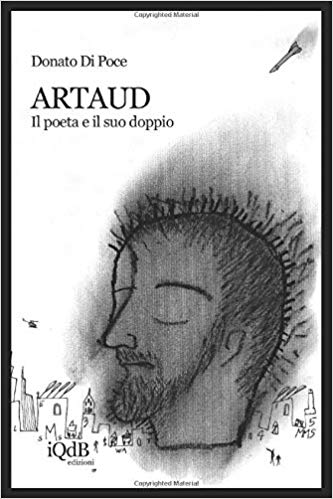
Donato Di Poce sa che Artaud tortura il linguaggio, sfiancandone gli assi portanti. Al termine della sua vita spuntano, sotto la camicia di forza, gli ultimi miracoli lessicali, le glossolalie, le deviazioni scatologiche. Sono chiodi ficcati nel muro dell’esistenza, per andare Oltre il silenzio del mondo. Il genio dell’inquietudine attraversa scuole, culti, pratiche e religioni, le saggia nell’intima natura, le apre come un chirurgo alla ricerca del sintomo inespresso e infine giunge a sconfessarle, tutte, giudicate insufficienti nel perseguire l’obiettivo finale. Il compito di Artaud riposa sotto l’orizzonte, è sospeso su un nulla, in un quid antenato e tomba del Verbo. Di Poce assorbe per noi il veleno, che circola nella testa e nel corpo del poeta esploratore, cercando una cometa d’inchiostro, che possa indicarci un cammino in una selva oscura di silenzi gridati.
Intollerante in radice al conformismo, abbarbicato ad uno sfibramento mentale, che lo condannerà agli elettrochoc perpetrati nei manicomi di Ville-Évrard e di Rodez, il marsigliese è, fin da giovane, vate della liberazione: dalla letteratura passata, dalla poesia assorbita, dalla scrittura automatica, come sottolinea Donato Di Poce nel prologo con dedica al Poemetto. Liberazione senza il conforto di un approdo. La qualità di Artaud è la sua aderenza a una rivolta onesta, pura, aliena dalle utopie, tanto da essere osteggiato, ed espulso, dai capi ideologicamente orientati del surrealismo, André Breton e Louis Aragon. Nessuno stile, nessuna sovrastruttura o architettura sociale può contenere il genio di Artaud, la sua passione ciclica, e apocalittica. Tre vite, tre morti, e forse non bastano. Scrivere è essere sopravvissuti a se stessi. Un uomo senza sollievo. Il visibile lo angustia. Irrompe l’interesse per l’esoterico, per la cabala, per lo gnosticismo, per le antiche verità sapienziali. Eppure, anche qui, ogni via di fuga è obliterata. Donato Di Poce restituisce nei suoi versi il significato ontologico di questa negazione. Artaud entra ovunque con spasmi di amore e di odio, convulsioni di convulsioni, ma il suo respiro è un soffocamento delle intenzioni.
Artaud denigra la poesia perché avverte il rischio di annichilimento celato in essa. Uno stigma, di cui l’artista ciociaro coglie peso e presenza. Il verso, per vivere, deve sanguinare, agonizzare, morire sulla pagina. Quelle parole che aprono varchi / Sui cuori abusati e infranti dell’umanità.
[1] A. Artaud, Poesie della crudeltà, Stampa Alternativa, 2011
Una mossa critica, ed esiziale, caratteristica dell’empio (solo dove c’è empietà c’è sacro e viceversa): la scommessa di attingere l’Assoluto da una posizione d’infermità, di delirio inenarrabile. Scrivere è rischiare la pelle, donarla allo scuoiatore borghese. Avanti! Assassinare i soloni! Farla finita col giudizio di dio! Degradare il cristo (con la c minuscola) a raglio d’asino! Ancora, di più: esporsi alla mattanza dei benpensanti, alle sterili certezze degli indottrinati, farsi ostia, pane del sacrificio, e profeta, novello San Patrizio, ribollire di oscenità, lapidare con contumelie i mercanti, che si sono fatti tempio da duemila anni. Sbeffeggiare l’eterno / e i sicari di futuro. Ma la poesia reca con sé un infame destino, come sa ed evidenzia l’artista-poeta di Sora. Il venire al mondo della parola è un’offesa dell’incanto, un ritorno alla fessura, alla vulva. Più Artaud si solleva, più scivola nella curva, verso l’apeiron originario. Amiamo le parole che recano / le colature del silenzio. E ancora incalza Di Poce, con la giusta carica di disincanto: Siamo solo un cimitero di parole / Distanze colorate d’indicibili visioni / Sicari muti delle nostre inesistenze. Troppa vita, in Artaud, troppa esasperazione del vettore carnale, troppo corta la miccia esplosiva per scampare all’esplosione. Spiegata pertanto l’offesa al sesso, il sigillo autoimposto della castità, le stigmate di una paradossale innocenza. Un esempio paradigmatico di martirio. Il corpo diviene calamaio, lo sperma inchiostro, la follia dispone alla creazione, fino alla consunzione di sé.
L’uomo libero vuole vivere il suo respiro animale / E scavare nell’abisso del proprio inferno. Come Van Gogh, il suicidato dalla (dalla, non della) società, che “non ebbe mai paura di morire per vivere”[1]. La società è impura e senz’anima, una tessitrice di crimini vergognosi, rivestiti con gli abiti buoni della domenica, mentre la Storia è “un fiume di stupri e di infamie”[2]. La civiltà, poi, è Satana e Satana è un “sistema di lastricatura dell’essere allo stato latente”[3]. Serve uno sforzo sovrumano, occorrono cromosomi cosmici e una tremenda grazia per tradire Dio, Patria e Famiglia, la triade assassina utile agli uomini per bene. Accade, suggerisce Di Poce, che qualcuno si sieda sulle viscere dell’infinito, veda l’invisibile, che non è l’essenziale vagheggiato dal buon Antoine de Saint-Exupéry, ma è, al contrario, il buco nero di ogni costruzione filosofica: la merda, il piscio, la colata di muchi. Onore alla figura del mendicante, del parassita, del girovago, del profugo, del migrante indesiderato, della puttana, del ladro, del nemico del decoro: lo scarto, il rifiuto, è l’unica porta di accesso alla conoscenza, l’unica purezza consentita, l’unica Via, taoista, all’eccelso.
Si possono scrivere poesie pensando a un poeta, oppure perché si vive e si opera nel pensiero di quel poeta. Il poemetto di Donato Di Poce appartiene alla seconda categoria. Non un semplice omaggio, ma un distillato di vita, di coscienza e di morte, una carezza spudorata, che tocca Antonin Artaud come fosse un’amante incompiuta.
1] A. Artaud, Van Gogh o il suicidato della società, Adelphi, 2010
2] A. Artaud, Eliogabalo o l’anarchico incoronato, Adelphi, 1969
[3] A. Artaud, La vera storia di Gesù Cristo, Nautilus, 1992
Clicca QUI per acquistare il libro