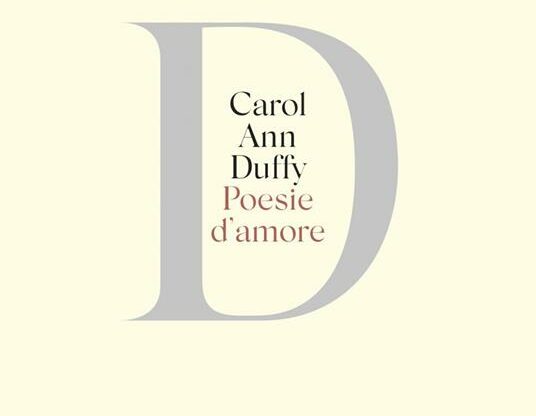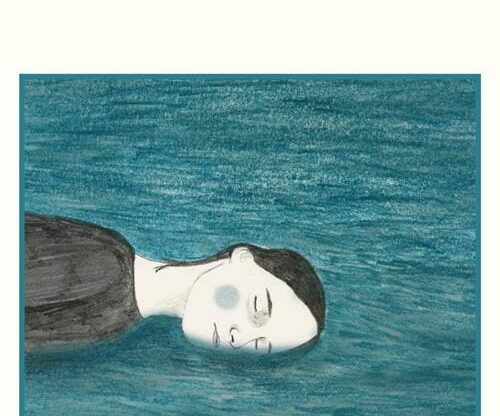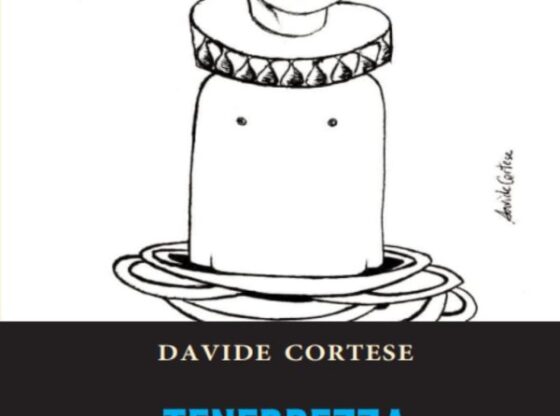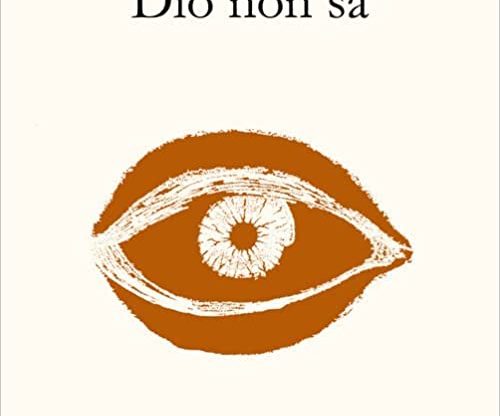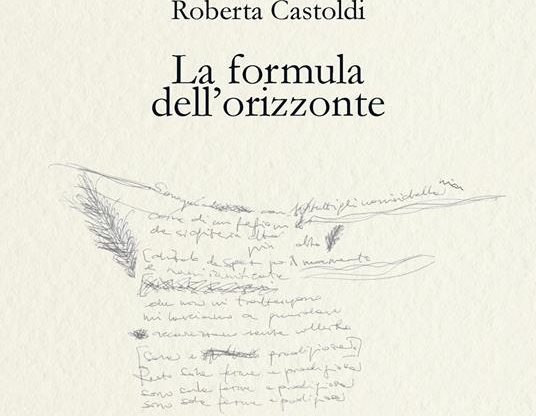Di Vladimir D’Amora
E’ bello,
per me,
che nella vitalità la morte
chiara mi legga. Dopo
che il giorno pesi all’essere, l’acqua
è una compagna di un’unica forma
accessibile al tuo viso.
Oggi la pioggia.
Ma non dir nulla,
che possa toccare corde,
questo sogno od ora
questo inammissibile sorriso.
Vedi,
qui l’ho tenuto sulla bocca il tanto
silenzio che era
anche il tu.
________________________________________________________________________
The station night
Scatola cranica.
Cubo di un cranio. Pubblico.
In una piazza, della piazza le luci sono le più deboli. Il vuoto.
Tutto serve la cosa unica e chiusa, dotata di un supplemento – la scritta con luce – come non bastasse la veste –
nuda – all’esistenze. Maria.
Da Capo Verde, negra e cavalla, senza più madre, né una sorella, suicide – esse sono state spinte al treno. Da le invisibili mani in una vita. Disegnare.
La vita.
Un vuoto.
La vita disegnata.
Contenitore vuoto, la stazione.
Ciò è, poi, i formicolii le forme le vite disastrate, le impettite, scoglionate, impegnate, le vite che lavorano bene e male e assunte e nate. A trapassare da banchina, a banchina. Colori.
Con e senza divisa. Tutto.
Tutto è placato.
E le notizie da una destra, a una sinistra. Forse immobili, su gli schermi piattissimi: che si spensero: che cedono al nulla. Intermittente.
La morte.
Con la rinascita per nessuno. Nessuno era presente. O qualche passaggio, mentre qualcuno ricordò di svegliarsi.
Mentre rimbombavano per poco di dintorno, per pochissimo di schermi: le vite.
Nella stazione.
La stazione è luogo: luogo-sicuro -luminoso -vero -felice -fedele al felice -antico: con Giovanni inciampato,
Giovanni non sanguina, Giovanni non soffre, Giovanni non è rimasto caduto, Giovanni non è stato notato.
Continuarono a disegnare.
La vita. Se la vita è disegnata. Poi si disegna la vita. Ancora.
Qualcuno, Qualcosa. In stazione non è fango, sotto, fango degno della Vita Vera. Sono, vere, le polpe e le carcasse con il verbo profferito e i pensieri mobili – vere le vite – nei pensieri.
Prima che nelle scritte con luce. Prima che tutti, tutte, ciascuna, ciascuno: come un portatore di un segno, sempre al sempre di un segno, sempre e ancora in un disegno.
Maria ora lavora. Lavorava come prima, prima della fine luttuosa. Il lutto.
Senza un pianto se piange come prima. Oggi. Prima, nel quale piangeva anche a godere, godendo delle minime spinte di un cazzo umano scossosi l’uomo e le sue lacrime. E scossisi i lacrimevoli occhi.
Di Maria.
Maria aveva occhi per piangere. Prima che per guardare.
La vita disegnata di Maria non piangeva.
Venduta all’inesistente acquirente. Che compra e consuma Maria coi fazzoletti: che compra e consuma le gomme di Volodia: o qualche cicca spenta; mentre dormono raggomitolati, mentre qualcuno qualcuna dorme. Senza il sibilo, il segno polmonare.
Macchie: le masse, le madri: scure.
Dall’Africa – colors. I negri.
Le luci sono alte, le basse lampade nel consumo di energia produssero sulle scale, che si muovono, l’operaio dalla Cina che passa a pulire con macchina scale lasciando scorrere 5 viaggiatori fermi nei loro bagagli – e pesano. Come le lievi munizioni di una vita spostata, di una vita.
Il disegno della vita si assiderò nella utilità sbiadita della merce comprata, contraffatta, che ci potev’essere una indicazione del prezzo, in una vetrina, solo vetrine: solo costi di un’epoca. Di un disegno enorme, astratto.
Mentre lo stile declinava le sue maglie grane tacche di 200 asa smarriti e invisibili e tutto: anche Maria: tutto si mangia, si assegna di nuovo alla presenza.
Un tutto ravvicinato, le lampade utili a distinguere l’attesa di un convoglio umano dal contenitore senza la poesia: senza la vita. Se il ferro sfreccia. A riposo. I nomi.
I loro nomi. Sono viventi con il nome proprio. E, a udirli, è una consumazione dell’umano prossimo, se le distanze furono inesistenti: se la stazione è il suo vuoto.
Un vuoto secolarizzato: come ogni altro vuoto.
Tanto alte, queste scatole di cranio di un architetto che fu l’architettura da fregi mastodontici di una fine di un secolo storico e svettanti come colossi di una pietra, sono.
Sono stanze scatole. Ciò è, poi, i capannelli che si tolgono nel risonare dei nomi loro.
Nomi. Che fluidificano dalle menti dei progetti di esposizione, alle pareti corte, nuove, più recenti, più locali, più morti: disegnati nel vetrale di vetrina dentro nella scatola cranica. Ed è enorme.
La stazione.
Il morire disegnato.
Avvolto da enormi flussi delle luminarie in clic accesissimo: per donne e per uomini assonnati. E per Maria.
Tornava.
Tornava Volodia, tornava Giovanni. (Che s’era ritrovato claudicante dopo.)
I funzionari comunali, davanti alla stazione, avevano casacche a segno di incidente. Come i segnali.
Ne comparve uno.
Disegnato.
Con la taglia umana.
Come un segno d’uomo.
Come un essere.
L’immagine di copertina è Stazione senza fermata, di Kasimir Malevic 1913. Presa da artemagazine.it
@Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione senza il consenso dell’autore