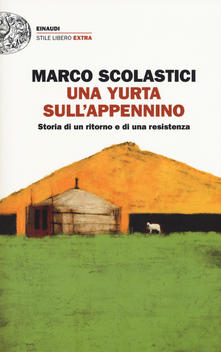Di Geraldine Meyer
“Oreste del Buono fu tra gli scrittori più eclettici e atipici del Novecento italiano: un irregolare per attitudine […] fu essenzialmente un pendolare della scrittura: autore, traduttore, critico, giornalista, editore”. Così Fabio Stassi presenta Oreste del Buono nel profilo bio-bibliografico che accompagna Racconto d’inverno, rimandato in libreria da minimum fax.
Un libro emblematico, per molti versi, dell’inquietudine di del Buono e proprio della pendolarità della sua scrittura. In molti sensi. Questo Racconto d’inverno è sì un diario di prigionia, uno dei primi esempi di letteratura che si fa testimone della guerra e della prigionia stessa. Ma è, in realtà, molto di più.

La prigionia di cui scrive qui del Buono è una sorta di destino generale dell’uomo, che si domanda a cosa serva la memoria, il ricordo e, finanche, la lingua stessa, quella lingua comune che sembra abdicare anche davanti al tentativo di condivisione del destino. A raccontarci l’immobilità del tempo, ammantato di neve e di lavoro, è Tommaso che, un po’ in prima persona e un po’ in terza persona, ci fa testimoni, come fosse l’alter ego dello stesso del Buono, di cosa voleva dire essere prigionieri nel campo di Gerlospass, sulle Alpi austriache. Tra prigionieri polacchi e ucraini, Tommaso e altri suoi compagni, deve costruire una linea elettrica tra Tirolo e Salisburghese.
Tutto attorno il livido dei giorni, l’odore del fumo e del bagnato delle baracche. E, dentro, un inverno che non è solo una stagione ma “uno stato d’animo”. Ed è questa forse la cifra di questo libro in cui si ascolta come un canto triste che coinvolge l’intera condizione umana, in una prigionia che va ben al di là di quella del campo: “A Tomaso giungono le voci, le parole abituali, ormai da tempo lise e sciupate nel meccanismo di questa prigionia”. Un meccanismo che, appunto, prende nella sua morsa la vita intera. Lo scrive, chiaramente, qualche riga dopo quando ricorda che: “ […] fuggire è inutile, perché è sempre lo stesso muro al confine dei nostri pensieri, delle nostre sensazioni e dei nostri sentimenti.”

Pubblicato nel 1945, Racconto d’inverno rappresenta una testimonianza di guerra scritta mentre ancora la guerra si stava combattendo ma parlandoci di qualcosa di marginale, dove per marginale si intende qualcosa che non entra nei libri di storia, battaglie di cui non si ha notizia negli annali ma che riguardano uomini colti in una quotidianità slabbrata. Eppure c’è sempre la certezza che del Buono ci stia parlando di altro, quando, per esempio, scrive: “La nostra è una storia di miseria, ma non riusciamo a liberarcene col non pensare ad essa: è in noi, la nostra storia, ed ogni momento grigio e squallido di questo non vivere, di questa nostra prigionia la costruisce. La sentiamo crescere nei giorni, nelle nostre parole, nei battiti del sangue e del cuore.”
La voce di Tommaso è la voce di Oreste del Buono, certo, arruolatosi volontario per rendere omaggio, con l’entusiasmo del ventenne, allo zio Teseo Tesei, eroe di guerra caduto a Malta, ma è anche una voce più ampia. Una voce di chi si chiede da dove possa arrivare la salvezza: “la nostra salvezza l’attendiamo dall’esterno, da altri: così ogni fatto appare gravato da un simbolo, una possibilità di intervento.” Come non leggere in queste parole la condizione umana, disorientata anche davanti alla possibilità di ricordare senza trovare vera pace neanche in quello.
La guerra di cui ci parla Tommaso/Oreste è, prima di tutto, come ricorda anche Ernesto Ferrero nella postfazione al libro, è “una guerra soprattutto all’interno di sé stesso: un assedio del cuore”. Assedio, questa la parola che affiora alle labbra più spesso mentre si legge Racconto d’inverno. Assedio anche nei momenti di tregua apparente, assedio del silenzio e delle domeniche vuote di lavoro e piene di niente, assedio dell’incapacità di toccare un corpo di donna provando davvero un autentico abbandono, l’assedio di avvertire di non esser più quasi umani: “Delle belve, possiamo diventarlo tutti […] Abbiamo paura di diventarlo un giorno o l’altro, spiamo i gesti, le nostre parole con diffidenza.”
Si guarda e ascolta da dentro e da fuori Oreste del Buono e, così facendo, obbliga anche noi lettori a farlo, dentro quel gelo che non è solo quello della neve che cade perenne ma, forse, quello della vita stessa che si fa sempre più fatica a vivere e che ci rende prigionieri di noi stessi: “Si possedesse una formula per vincere il nostro male alla vita, il nostro non saper vivere, ogni tanto qualcuno crede di averla trovata e per quella imprigiona gli altri con le etichette.”
 Racconto d'inverno
Racconto d'inverno
Classics minimum fax
Diari, letteratura di prigionia
minimum fax
2019
156