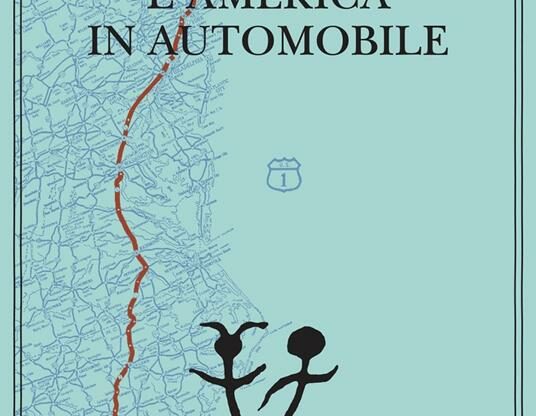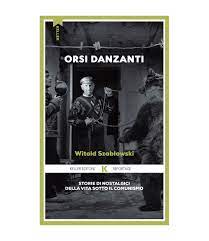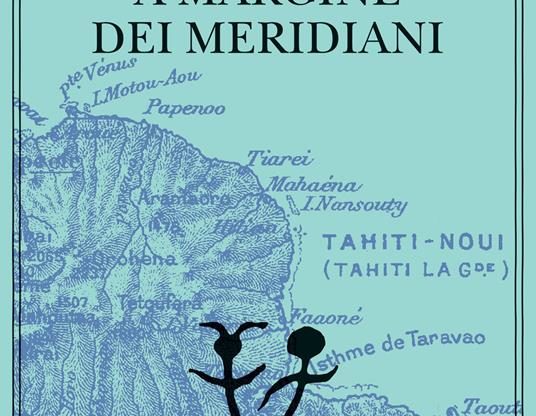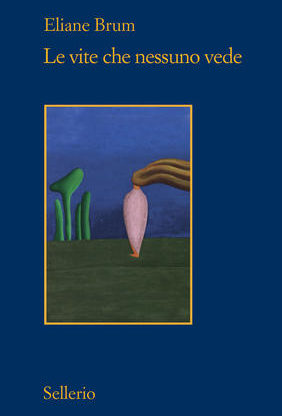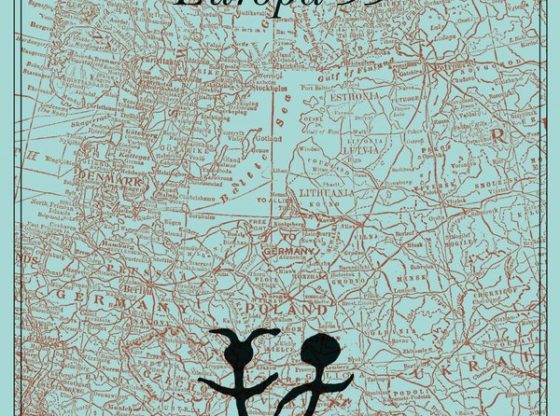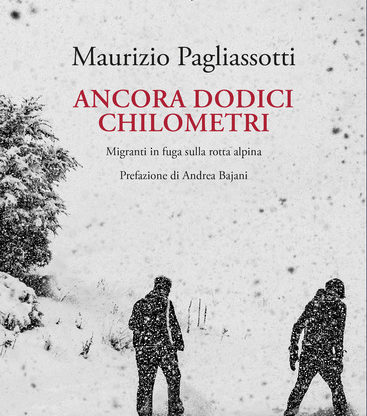Secondo reportage slovacco
Di Marcello Caprarella
6 giugno 2019
Domani partirò per la Slovacchia e ci resterò una settimana. Ci vado da solo, ché i ragazzi sono troppo impegnati con la scuola. Come dice R.N., che non ci è mai stato, in Slovacchia esce birra dalle fontanelle pubbliche. Confermo. Mio cugino G. vive a Spisska Nova Ves ed è sposato con una ragazza del posto. Al loro matrimonio, or volge un anno, ci siamo divertiti molto. I luoghi e le situazioni hanno ispirato anche alcune descrizioni del mio ultimo (in tutti i sensi) romanzo. Con particolare piacere ricordo soprattutto il viaggio in treno che dura quattro ore e che domani rifarò, da Bratislava. Spisska Nova Ves, infatti, è all’estremo est del paese, che è come una strisciolina di pineta incrostata nel cuore dell’Europa. Mia moglie e i ragazzi trovarono il tragitto troppo lungo e la città troppo povera. Con mia moglie, in particolare, ci si chiedeva se saremmo stati capaci di vivere in un posto del genere, dove gli inverni durano otto mesi e le temperature scendono fino a trenta gradi sottozero, e la gente esce poco di casa. Io non so come sarà l’inverno a Spisska Nova Ves, se non per sentito dire. So che per mio cugino è stato un periodo di letargo. Mi racconta che la gente si barrica in casa e che si esce solo quando dal cielo plumbeo fa capolino un filo di sole. E che lui, mio cugino, aveva come unico passatempo “sociale” delle gare di lotta libera in modalità valetudo: uomini (zingari, serbi e bulgari, soprattutto) che si picchiano a mani nude in una gabbia, attorno alla quale gli spettatori, al caldo del palazzetto dello sport, bevono birra ghiacciata. Mio cugino era tra gli spettatori e ogni tanto mi mandava anche le foto di qualche lottatore stramazzato a terra in una pozza di sangue, o pieno di lividi. In primavera, invece, la vita rinasce, in posti del genere, e la gente affolla le strade e le taverne, pacificamente. Mio cugino e D., sua moglie, hanno anche una piccola dacia a pochi chilometri dalla città, in mezzo a un bosco dove non è raro incontrare orsi. Anche quella baita, poco più di una baracca, ho descritto in Prigionia di una somiglianza, ma ambientando la scena in Bulgaria. L’Europa dell’est resta per me, che non ci vivo, un territorio unico e inseparabile, come se ancora esistesse il blocco di Varsavia, ma trasformato in un paese dei balocchi a prezzi da discount.
7 giugno
Dal treno, partito un’ora fa da Bratislava, uno vede tutte queste moli di ciò che un tempo erano fabbriche. Non credo funzionassero secondo i parametri di efficienza a cui tutti pensano (pensiamo) oggi, ma pure era materia pulsante e viva, al servizio di un’idea grandiosa e arenatasi in una prassi perversa e mortifera. E a vederli, ora, questi scheletri di ghisa e cemento sommersi dai campi di colza, uno pensa alle rovine di Pompei. Ai ruderi di un ideale che un tempo e per un tempo ha fatto ardere il mondo. O un mondo, risorto dalle ceneri qui, oggi, più libero e meno comprensibile ancora. Storia ridotta a un parco tematico, a itinerario libero. Gran tour low cost tra le ecatombi.
Ancora dal treno. Il paesaggio slovacco è un ibrido tra un alpeggio e un piano quinquennale abbandonato.
8 giugno
Ieri pomeriggio, quando sono arrivato a Spisska Nova Ves, c’era una festa in piazza, una specie di recita per la fine dell’anno scolastico. Era di fronte al mio albergo, il Penzion Venusa. Era una festa pazzesca, che racchiudeva bene lo spaesamento storico e umano di questo verde spicchio d’Europa. I bambini mangiavano lo zucchero filato, mentre sul palco si esibiva un gruppo neonazista di musica ska. Sono arrivato quando la band stava per chiudere il concerto e il cantante faceva il saluto hitleriano. Mamme e nonne applaudivano, entusiaste, in prima fila, e degli adolescenti ballavano come se a suonare fossero stati i New Kids on the Block. Finito lo spettacolo, sono tornato in albergo a fare una doccia e cambiarmi. L’albergo è stranissimo, ma comodo. Un affittacamere che ha ristrutturato un edificio intero. Al pianterreno c’è il ristorante, che al mattino serve anche le colazioni. E, poco fa, ho visto che le serve à la carte, le colazioni. Mica con l’assalto al buffet, sempre così ansiogeno, quando a sgomitare con noi ci sono inglesi e altri barbari dagli stomaci mattutini tronanti. Mi sono un po’ lagnato con il cameriere-portiere-mâitre perché ieri sera, al mio rientro, si continuava a festeggiare un addio al celibato (o era un divorzio?) di una cinquantenne in tiro, sorella dell’assessore comunale che ha officiato l’anno scorso la cerimonia nuziale di mio cugino G. L’assessore è un energumeno affabile, uomo di panza e di potere. D. mi ha detto che è stato anche arbitro e poi guardalinee della serie A slovacca, e che insegnava educazione fisica ai tempi del comunismo, quando l’educazione fisica era la materia più importante, nelle scuole. Ma torniamo alla festa di ieri notte. L’assessore, invitato d’onore, salutava la crème de la crème della cittadina. Nella distrazione, ha stretto la mano anche a me e ha detto qualcosa, alla quale ho assentito a cazzo. Spero di rivederlo borgomastro, la prossima volta che ci incontreremo. L’albergatore aveva spostato i tavoli del ristorante e creato una pista da ballo. Gli uomini bevevano al bancone, ma la pista era piena di milfs leopardate e prone al reggaeton, che impazza anche sotto queste latitudini e che mi ha impedito di chiudere occhio fino all’una e mezza. Io avrei almeno voluto partecipare alla baldoria, e l’ho detto al cameriere factotum, stamattina. “Private party“, è stata la sua asciutta risposta, però, alle mie rimostranze, l’uomo mi è parso così gentile e così sinceramente mortificato per il chiasso notturno che gli ho sorriso, e poi mi ha portato un caffè ristretto Vergnano buonissimo. È un tipo altissimo, malinconico e zoppica vistosamente. Somiglia a Raimondo Vianello da giovane. Parla una lingua bizzarra, ma comprensibile, come un tedesco ingentilito dall’inglese imparato a scuola. Se io abitassi qui, vorrei che questo cameriere tuttofare fosse amico mio. Se io abitassi qui, sarei avventore fisso della krucma (non so se si scriva così) nella quale siamo stati ieri sera, dopo cena. La krucma è una sorta di balera condominiale. D., la moglie di mio cugino, la frequenta sin da bambina e anche mio cugino, vivendo qui, ha cominciato ad essere un habitué. C’è l’orchestrina e la gente balla. D. conosceva tutti, ovviamente. Il ragioniere del settimo piano, per esempio, balla con una grazia innata assieme a sua moglie, segretaria comunale. Ma la più brava di tutti era la vecchia insegnante di educazione fisica di D. A vederla volteggiare con il nuovo fidanzato nessuno direbbe che sono entrambi ultrasettantenni. Gli insegnanti di educazione fisica, qui, lavorativamente attivi o meno, sono come la nobiltà decaduta o i notabili di un tempo: rispettatissimi e circondati da una specie di aureola nostalgica dei fasti perduti. Non so se la emanino loro, l’aureola, o se gliela sprigionino attorno gli ex alunni o i genitori che li hanno conosciuti nei bei tempi della formazione socialista della gioventù del futuro radioso. E poi c’era, nella krucma, una bambina vestita di rosso e che ballava con chiunque e rideva. Se la passavano da una coppia all’altra. Figlia, nipote e nipotina di tutti. Invece dell’abusatissimo proverbio africano che dice che per educare un bambino ci vuole l’intera tribù, io direi che basta un condominio post comunista. Alle ventidue l’orchestrina, dopo un pezzo turbo-folk, ha taciuto di botto, come se qualcuno avesse spento un giradischi. E, di botto, è stramazzato a terra il ragioniere del settimo piano, non si sa se per le birre o i capogiri da ballerino piroettante. Si vede che deve essere una scena abituale, perché nessuno si è allarmato. L’hanno sollevato in tre o quattro e l’hanno rimesso a sedere al suo tavolaccio di legno. Anche la bambina bionda era stanchissima e si è andata a rifugiare tra le braccia della mamma, che vent’anni fa era un’altra bambina bionda uguale. Questa, la giornata di ieri. Prendo in prestito il titolo della tetralogia di Antony Powell, per dire che questa è stata, ieri, la danza per la musica del tempo.
9 giugno
Alla Penzion Venusa si sta bene. Ieri mattina ho atteso al bar che venissero G. e D. e gli ho offerto il caffè Vergnano, facendo segnare tutto sul conto della stanza 10, come se uno fosse uno zio ricco che è andato a trovare i nipoti che studiano in un’altra città. Così mi sento. Attorno avevamo molti impiegati del vicino Comune. Tutti in pausa cicchetto, poco prima delle undici. Sbocciavano i primi calici di vino bianco e i caffè corretti. C’erano anche due puttane, che assieme facevano almeno due quintali e mezzo di carne. Mangiavano delle fette di torta e, all’uscita, mi hanno anche sorriso dalla macchina, e parlavano tra di loro come due liceali quando adocchiano un ragazzino che gli sta simpatico. È stato un bel momento, pulito e quasi puro. Poi siamo andati a fare la grigliata nella jalupa, che sarebbe la dacia/baita appena fuori città, immersa nel bosco. L’essenzialità della costruzione è molto nordica e ne ho tratto ispirazione per una descrizione “bulgara” che si trova all’interno de La prigionia di una somiglianza. Io e mio cugino siamo anche andati a prendere l’acqua ghiacciata alla fontana. Qui tutti hanno una jalupa. La “nostra”, come tutte le altre, ha attorno un pezzettino di prato ed è circondata da altissimi abeti. La grigliata è stata grandiosa. C’erano pure le cugine di D., Una si chiama M.; dell’altra non ricordo il nome, ma mi sembra che cominci pure quello per M. La cugina il cui nome inizia sicuramente per M. e che è separata da un marito problematico, ha un figlio ventenne che si chiama K, studia filologia slovacca e con il quale è stato difficilissimo cercare di imbastire una qualunque conversazione, data la sua ritrosia. Le cugine di D. sono avventiste. D. dice che nella chiesa dell’avventismo le sue cugine hanno trovato una comunità che gli infonde sicurezza, visto che sono due donne sole. E di ottimo appetito, aggiungo: da brave avventiste, sono state le prime ad avventarsi sulle salsicce, che io, mio cugino e K. arrostivamo direttamente sulla fiamma infilzandole su una specie di antenna di acciaio biforcuta. Come nei western, quando ci si ferma di notte a fare il bivacco. M. sicura, che delle due è la cugina più chiacchierona, mi ha confessato di essere nostalgica del comunismo e stufa della precarietà dei nuovi tempi, e tutti l’hanno attaccata. Io ripensavo a un romanzo di Daniel Lungu, Sono una cariatide comunista, che ho letto giorni fa e che parla, per bocca di una pensionata, della Romania di Ceausescu, dal fondo di una nostalgia che è solo il rimpianto di una gioventù persa. Siamo tornati in città poco prima di cena. Anche la mamma di D. era contentissima. Puzzavo (o profumavo?) di fumo e di salsicce, ma la doccia in albergo ha lavato via tutto. Abbiamo cenato in casa di D. e di G. Rigatoni Rummo al pomodoro, mentre la mamma di D. guardava un programma di musica folcloristica slovacca, con il televisore a tutto volume, che era come avere i cantanti al tavolo. È scoppiato un fortissimo temporale estivo, e mi hanno riaccompagnato in albergo in macchina. Al bar c’erano due ciechi e dei giovinastri che bevevano birra. Noi abbiamo preso un pezzo di torta alle noci (la stessa che, di mattina, avevo visto mangiare alle puttane) e poi abbiamo fatto due passi. Malgrado fosse sabato sera, i locali erano tutti chiusi o vuoti. L’aria profumava della pioggia appena caduta e di fieno appena falciato.
10 giugno
Ieri abbiamo trascorso tutta la giornata in un parco nazionale che va sotto il nome di Paradiso slovacco e la cui area sud occupa in pratica tutta la provincia in cui mi trovo e le province limitrofi. Abbiamo visitato un grande lago artificiale creato da una diga. Siccome era domenica, c’erano molti gitanti. Qualche ardito faceva il bagno nell’acqua gelida e trasparente, o navigava in piroga. I più si riprendevano dalla sbornia della sera precedente, prolungandola. Sulla via del ritorno abbiamo incrociato un gruppo di ragazzi che, carico di bottiglie di vodka, andava verso il bosco. Ci hanno salutato con molta allegria, che abbiamo ricambiato sobriamente. Erano colpiti soprattutto dalla tuta dell’Atlético de Madrid che indossava mio cugino. Il calcio, di questi tempi, è un elementare esperanto. Abbiamo pranzato in una specie di ranch, vicino a un ruscelletto, e poi abbiamo proseguito in macchina fino a un laghetto naturale, in una contrada che D. conosceva bene perché, da bambina, ci andava a trascorrere dei giorni di vacanza, quando il Partito assegnava alla sua famiglia una super-jalupa per qualche giorno. Ecco la vera democratizzazione del lusso! Oggi, invece, la jalupa a cinque stelle è stata privatizzata e c’era vicino alla recinzione una Mercedes station-wagon parcheggiata e appartenente al pescecane capitalista che ha sottratto questa meraviglia di baita al Glorioso Popolo Slovacco tutto teso alla conquista delle Mete Socialiste. Siamo tornati a Spisska Nova Ves verso le cinque del pomeriggio e ho lavoricchiato un po’ su una traduzione ferroviaria. Prima del “coprifuoco serale” e della cena, che abbiamo consumato alla Penzion Venusa, io e mio cugino abbiamo fatto lo “struscio” sul vialone centrale del paese. Mio cugino dice di rimpiangere ogni tanto il casino della grande città. Io credo che a me, invece, faccia bene questa pace di provincia straniera. Se qui ci vivrei? In fondo, il lavoro che faccio potrei anche svolgerlo a distanza. E poi mia moglie avrebbe finalmente l’orticello e potrebbe godersi la jalupa. Il problema sarebbero i figli, che stanno studiando e che bisognerebbe lasciare a Madrid. La lingua è ostica, ma potrei impararla. So già come si dice grazie, prego, birra e sindaco. Oltre a jalupa, chiaro.
11 giugno
Ieri siamo andati sui monti Tatra, arrivando fino a circa milletrecento metri per costeggiare a piedi un laghetto incastonato tra le montagne. Il turismo di massa è arrivato anche qui e sembrava di essere a Bormio. Tutto, però, rispetto alle Alpi, è molto più curato e naïf, e non so per quanto tempo ancora durerà questo periodo di gracile transizione tra l’incontaminato e il mordi e fuggi. Forse fin quando non finiranno di costruire l’autostrada che collegherà Bratislava con la regione montagnosa, suppongo. A pranzo, in un ristorante con le cameriere travestite da pastorelle mennonite, ho mangiato una trota alla griglia buonissima. Mio cugino e D., invece, hanno preso dei piatti slovacchi sostanziosi e invernali, pieni di panna, crauti, ciccioli di maiale e formaggio di pecora fuso. Mio cugino non faceva altro che dire che non aveva mai mangiato una cosa così buona, ma io credo fosse una tecnica di autosuggestione. Eravamo all’aperto, circondati da pensionati tedeschi e da giovanissime coppie del posto cariche di figli. Abbiamo finito di pranzare alle dodici e trenta, come negli ospedali, e ci siamo rimessi in macchina per raggiungere un’area che si trovava a una ventina di chilometri da dove eravamo, ridiscendendo verso la vallata, per visitare una residenza di caccia di un nobile locale attorno alla quale è stato ricostruito un villaggio slovacco di metà dell’Ottocento. Non era una patacca: le case erano vere e c’erano anche le pecore e le stalle. Nel pomeriggio ho lavorato in albergo e, dopo un’insalata a casa di D. e G., abbiamo fatto una passeggiata con il cane, che è un barboncino raccolto al canile. Mentre D. si tratteneva con altre signore con cane al seguito, io e mio cugino abbiamo bevuto una lattina di birra sotto la tettoia di un distributore di benzina, come personaggi di Taksim, il romanzo di Andrzej Stasiuk. Suggestione, questa, senz’altro dettata dal fatto che la Polonia è proprio dietro i monti Tatra, che da Spisska Nova Ves si vedono anche quando, come ieri sera, la foschia dell’afa li diluisce nell’aria.
12 giugno
Ieri mattina siamo rimasti in città perché volevo
comprare qualche souvenir e riposare un po’. Ho preso delle magliette di cotone
con lo stemma della Slovacchia per i figli. La commessa del locale Ente del
Turismo che me le ha vendute parlava un ottimo italiano perché, dopo tredici
anni di convivenza, si è appena separata da un sardo di Porto Torres. Con due
figli a carico e che si è portata a Spisska Nova Ves, la signora annaspa e si
arrabatta perché il sardo non le passa un centesimo. Deve essere, il tizio di
Porto Torres, assieme a E. scrittrice, l’unico sardo tirchio, visto che tutti i
sardi che conosco io sono generosissimi. Comunque sia, ho espresso tutta la mia
solidarietà alla venditrice separata. La diffamazione di un terzo (per quanto
probabilmente non del tutto colpevole e, comunque, impossibilitato a
controbattere) è un’ottima piattaforma di partenza per un’amicizia superficiale
perché crea una complicità facilona. Il problema, poi, è andare avanti, trovare
affinità meno distruttive e impostate.
Abbiamo pranzato (senza la commessa, va da sé…) in casa di D. e di mio
cugino.
D. ha imparato da mia zia A. (madre di G.) a preparare le pizze fritte, con
tutti i crismi. Non avrei mai pensato di poter mangiare in Slovacchia una specialità
foggiana che non gustavo da quasi vent’anni. Una madeleine unta.
Mio cugino G. ha avuto un culo pazzesco perché D. è veramente una perla. Oltre
a essere molto bella, è la dolcezza in persona. Lo vedo da come tratta
l’anziana madre e da come parla di mia zia A., chiamandola “mamma”.
Gli occhi di D. sono del colore del laghetto che abbiamo visitato due giorni
fa. Tutto, in lei e da lei, si irradia sugli altri e sul mondo con calma
intelligente e limpida, come dagli angeli di un’annunciazione.
Dopo pranzo, sotto un caldo degno di Porto Torres, siamo andati in macchina a
visitare l’ennesimo locus amoenus. Stavolta era la sorgente di un fiume,
lo stesso che passa sotto casa di D. e nel quale ho visto in tutti questi
giorni degli zingarelli fare il bagno in mutande, come nei film del
neorealismo. Purtroppo, la taverna in cui saremmo dovuti andare e dalla quale
avremmo dovuto ammirare il profilo azzurrino e bianco di neve dei monti Tatra
trincerati dietro i soliti birroni (noi, non i monti Tatra); il posto, dico,
era chiuso, e abbiamo fatto ritorno a Spisska Nova Ves. In camera faceva
caldissimo e ho lavorato, nudo, a una traduzione su un dispositivo usato dalle
compagnie assicurative per prevenire le frodi degli automobilisti.
Di sera, durante uno struscio surreale prima di cena, con i negozi chiusi e i
marciapiedi semideserti, abbiamo incrociato in pieno centro la signora
dell’Ente del Turismo. Era con sua figlia, una bambina piccola e mora che
dimostrava la preponderanza razziale del sardo, evidentemente generoso solo
nell’elargizione dei propri caratteri genetici. La signora, che al mattino si
era mostrata molto spigliata, ha risposto con timidezza al nostro saluto. D.,
la moglie di mio cugino, non la conosceva, pur avendo a occhio la sua stessa
età. Io avrei voluto fermare la commessa per parlarle di nuovo malissimo dei
sardi e strapparle un sorriso. Abbiamo mangiato un hamburger in un bar gestito
da gente giovane e con un ambiente universitario, con scaffali pieni di libri.
Il cameriere era un ragazzo dell’età di mio figlio Pablo. So che è un
sentimento abusato e un po’ banale, ma la gentilezza dei ragazzi di oggi mi
commuove sempre perché vedo la precarietà che li assedia e che, aumentata, li
attende al varco del mondo del lavoro da adulti.
Stamattina andremo a vistare le rovine di un castello. Mio cugino dice che è
l’unico posto della Slovacchia non circondato da una pineta. Sempre meglio di
Porto Torres, penso io.
Post scriptum: Penso a La prigionia di una somiglianza,
alla sfiga del premio Neri Pozza al quale non ha potuto partecipare e ai tanti
rifiuti editoriali a cui va incontro. Questi ultimi potrei evitarglieli, certo,
se smettessi di scrivere a case editrice prestigiose, così così o direttamente
assurde. Meglio rassegnarsi. Più dignitoso, di sicuro. Quelli che ti dicono che bisogna
insistere, insistere e insistere fino a farcela sono, nel migliore dei casi,
dei cretini che ce l’hanno fatta grazie a una grossa dose di culo, di mancanza
di dignità e di senso del ridicolo. O per sfiancamento della preda umana,
pratica o istituzionale.
Nel peggiore dei casi, dei cretini che continueranno a insistere.
13 giugno
Continua a fare molto caldo e la gente, che qui non è
abituata a queste temperature, boccheggia in strada. Fino alle 19. Poi, prima
che il sole cali, inizia il coprifuoco e, al massimo, si trovano i lavoratori in
trasferta che cenano in uno dei ristoranti del vialone centrale o alcuni degli
alcolizzati storici della città, con la faccia ancora più violacea del solito.
La mattina, invece, la vita scorre con modesto dinamismo. È una delle zone più
povere d’Europa, questa, e si nota. Non ci sono negozi di lusso, ma solo
mercerie e piccoli empori di generi alimentari che fungono anche da drogherie e
tabacchini. Molti degli abitanti lavorano all’Embraco, la ditta di compressori
industriali che ha abbandonato l’Italia alla ricerca di costi di produzione più
bassi. Il terreno e la manodopera qualificata, qui, abbondano. L’Embraco è come
conficcata in una vallata circondata dai boschi, e i dipendenti, nella bella
stagione, possono raggiungere il posto di lavoro in bicicletta, da Spisska Nova
Ves. In inverno immagino sia molto più dura.
Ieri, prima di pranzo, abbiamo visitato le rovine del castello (Spisski Hrad)
che, dal XII secolo in poi, ha presidiato la regione di Spisska. È stato un
incendio a distruggerlo, nel 1780, e non gli assedianti che si sono succeduti
nei secoli. Per arrivare sulla sommità della collina su cui si trova il maniero
diroccato bisogna parcheggiare la macchina in una radura sottostante, dove si
viene sottoposti a un esiguo taglieggiamento (cinquanta centesimi) da uno
zingaro che cerca anche di rifilare ai pochissimi turisti degli orrendi cestini
di vimini. Con me, G. e D. c’era anche una delle tante cugine di D. il cui nome
inizia per M. Questa M. è una zitellona allegra e dallo stomaco di ferro. L’ha
dimostrato nel salash, cioè l’ovile-ristorante in cui abbiamo pranzato
ad orario da degenti ospedalieri. Io sapevo di andare incontro a un massacro
colesterolico perché il menù era scritto solo in slovacco, senza traduzione. Ho
letto un lampo di terrore negli occhi di mio cugino, che qualche cosa della
lingua locale ha imparato e che, impallidendo, ha detto alla moglie: “D.,
siamo nelle tue mani… A Marcello piacciono i formaggi. Evita le salsicce
piccanti…” D. ha negoziato in un batter d’occhio l’ordine delle portate
con il cameriere, il quale, dopo le birre, ha portato in tavola un chilo e
mezzo di formaggi di pecora dai diversi gradi di stagionatura e salinità. Il
primosale era rafforzato da una scorza di paprika. Ci siamo arresi ai primi
colpi di primosale. La cugina di D. mi incalzava e continuava a servirmi una
specie di marmorea scamorza affumicata e a parlarmi in tedesco (lavora in
Austria, come infermiera stagionale). Le ho detto “Ich bin kaputt!” e
D. ha fatto mettere in un tupperware il chilo abbondante di formaggi che
avanzava e, minacciosamente, ha detto a mio cugino: “Li mangeremo nei
prossimi giorni. Ora arriva la carne…” Mio cugino G. non ha più parlato,
ma si notava che aveva paura. Guardava con invidia i ravioli ripieni di panna e
ricotta di pecora, e ricoperti di ciccioli di maiale; li avevano ordinati sua
moglie e la cugina M. ed era chiaro che G. provava invidia per la loro
leggerezza, pensando alle portate che stavano per essere servite a me e a lui.
Credendo di fare il furbo e commettendo una scorrettezza che solo la
disperazione giustifica, quando si è visto adagiare sotto il naso una specie di
crostone alle patate ripieno di prosciutto cotto, collo di maiale, funghi e
panna, G. mi ha detto: “Mangialo tu! A me la panna provoca acidità di
stomaco…” Io ho preso il piatto e ho fatto tutto il possibile, cioè
pochissimo. Mio cugino G. credeva di averla scampata, ma, quando è arrivata la
sua salsiccia piccante circondata di budella di maiale fritte e originariamente
destinata a me, ha sussurrato: “Il piccante mi provoca ancora più bruciore
di stomaco della panna. Forse il cameriere si è sbagliato o non ti ha capito
bene. Vero, D.?” D. e la cugina M. ridevano e parlavano fitto fitto in
slovacco mentre spazzolavano i loro ravioloni biancastri. Il dolce non
l’abbiamo preso. Sulla via del ritorno ci attendeva un altro piatto forte:
un’enorme bidonville di zingari. D. ci teneva a farmela vedere e, per un
momento, ho temuto che volesse dirmi: “Ecco, voi e le vostre fisime a
tavola, quando c’è gente che vive peggio che in Africa…”. Non l’ha fatto,
il paragone con l’Africa, ma l’ho proposto io, e gli zingari della bidonville
slovacca ci perdono perché in Africa, quantomeno, non ci sono le bufere di neve
e venti gradi sottozero da novembre in poi. Se penso a un titolo, sia per
questo secondo diario slovacco, sia per il primo, scritto lo scorso anno, mi
sembra appropriato quello di Ho visto anche degli zingari infelici,
parafrasando il grande Claudio Lolli.
Nel pomeriggio abbiamo preso un caffè con le altre cugine M., cioè le
avventiste di cui ho parlato qualche giorno fa; sono in rotta con la zitella
M., per cui bisognava evitare di parlare della gita che avevamo fatto assieme a
quest’ultima. Le due M. avventiste mi hanno portato un pan di spezie a forma di
cuore, da portare a Madrid. Stavo per commuovermi, ma ho retto. Ho il condotto
lacrimale forte almeno quanto lo stomaco.
Stamattina parto per Bratislava, dove dormirò. Il volo di ritorno è domattina,
alle nove.
Arrivo a Bratislava: Bratislava, con i trentacinque gradi di oggi pomeriggio e l’umidità del Danubio, sembra Lisbona. Sarà pure per i pastelli scrostati dei palazzi tardo-ottocenteschi del centro storico. La birra mi riporta in Mitteleuropa.
14 giugno
Sto scrivendo dall’aeroporto di Bratislava. Ieri sera ho fatto un giretto in centro. Potrei riscrivere le stesse cose scritte a maggio dello scorso anno. C’erano troppi turisti e a stento si riusciva a camminare. Fiaccato dal caldo, sono rientrato in albergo, all’hotel Mercure, attaccato alla stazione ferroviaria centrale, per cenare senza fretta. Pare che il giovane e promettente chef del ristorante dell’hotel Mercure sia uno dei massimi rappresentanti della nuova cucina slovacca, che è come quella vecchia, ma con stoviglie più grandi e porzioni più piccole. Ho preso pesce alla piastra. Non so che pesce fosse -diciamo, genericamente, che era di fiume- però era buono e senza formaggio di pecora fuso né ciccioli carbonizzati di maiale sopra. La camera era comoda e silenziosa. Stamattina, alle sei e trenta, ho rinunciato a fare colazione perché ho visto un gruppo di salutari, occhialuti e rubizzi pensionati tedeschi che si accalcava davanti al vassoio delle uova strapazzate e delle salsicette piccanti, e mi è venuta l’ansia. Il tassista di Uber che mi ha portato in aeroporto era un naziskin immenso, poco più che adolescente, tappezzato di tatuaggi e con la faccia da pastorello incrociato con un maialino da latte. Non ci siamo scambiati neanche una parola per tutto il tragitto, che è durato un quarto d’ora. Quando ho pagato (solo dieci euro), gli ho detto: “Horuzo!”, che non so se si scriva così, ma che significa “afa”. Non era un tentativo di captatio benevolentiae, il mio. Volevo solo confermare che il tassista avesse qualcosa di umano. Lo sventurato non ha risposto, però non mi ha neanche picchiato, limitandosi a rivolgermi uno sguardo di schifata ottusità. Sarà la mia pronuncia dello slovacco, non proprio impeccabile. E così si conclude questo secondo diario slovacco, a distanza di poco più di un anno dal primo.
15 giugno
È chiaro che lasciamo tracce del nostro passaggio. Sul cellulare e sul pc continuano ad arrivarmi offerte commerciali scritte in slovacco: agenzie immobiliari, dentisti (il turismo odontoiatrico tira che è una bellezza…) e altre pubblicità dal contenuto incomprensibile. Ieri, all’arrivo a Madrid, mi sono fiondato su un piatto di ciliegie come un marinaio del Cinquecento su un agrume. Mio cugino G. parla apertamente della possibilità di avere un infarto vivendo e mangiando in Slovacchia e alla slovacca. Esagera, ma l’avitaminosi (lo scorbuto da marinaio olandese, appunto) è un rischio concreto. Mi sono rimesso in carreggiata dietetica con un bel petto di pollo a pranzo. A cena, insalatona. Corretta da una lattina di birra Zlaty Bazant acquistata all’aeroporto di Bratislava. La gioia più grande è stata ritrovare e abbracciare la famiglia e il bidet, in quest’ordine.