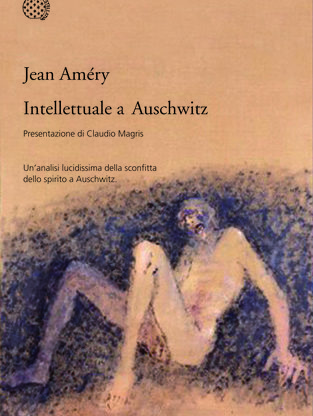Di Graziella Enna
Se ancora ci fosse bisogno di confutare le assurde teorie che sedicenti negazionisti si ostinano a diffondere come verità assolute, questo libro ci offre un’altra drammatica testimonianza da parte di un medico ungherese, Miklos Nyiszli, (Somylo, Ungheria, (Oggi Simleul Silvaniei in Romania), 17 giugno 1901 – Nagyvarad, (oggi Oradea), in Romania), 5 maggio 1956), costretto a lavorare come anatomopatologo nel Sonderkommando di Auschwitz. Egli correda la sua sconvolgente testimonianza con una premessa, in cui, in qualità di medico ed ex internato ad Auschwitz, dichiara di aver steso le sue memorie osservando oggettività e veridicità senza enfasi descrittiva e alcuna intenzione di conseguire successi letterari, con il solo scopo di far conoscere i risvolti più segreti e inquietanti degli esperimenti condotti nel campo, di cui egli compilava con doviziosa cura verbali medico-legali, revisionati dal famigerato Joseph Mengele e inviati a uno dei più famosi istituti medici del mondo, l’”Istituto di Ricerche antropologiche e Biologiche sulla Razza” di Berlino. Parlando di questo libro di memorie, mi sembra opportuno citare Primo Levi e la sua opera “I sommersi e i salvati” (Einaudi, Torino 1986), che, a buon diritto, può essere ritenuta una delle più lucide e complete analisi del fenomeno concentrazionario, nel capitolo in cui tratta il tema della cosiddetta “zona grigia” intendendo con questa definizione il ruolo di coloro che costituivano una sorta di classe ibrida di prigionieri-funzionari o semplice manovalanza, che sfuggivano a ogni possibile classificazione, cosa del resto impossibile, a detta di Levi, in una realtà così complessa, dalle logiche perverse e hobbesiane tipiche del campo, in cui ogni forma di schematizzazione e semplificazione era impossibile, tantomeno la dicotomia stereotipata vittima-carnefice. In questo caso l’opera di distruzione psicologica degli individui da parte dei nazisti, consisteva nell’affidare loro dei ruoli talvolta affatto marginali per attribuire a molti sventurati elementi di correità e incolparli di essere stati sanguinari e crudeli quanto loro stessi, i veri aguzzini: un modo perverso di condividere nefandezze inenarrabili. Ovviamente leggendo le memorie di Nyiszly il lettore acquista subito la nitida percezione che quei ruoli erano coatti, certo prevedevano una condizione di vita migliore rispetto ai comuni detenuti, che in termini prosaici si traduceva in un’alimentazione che garantiva delle elevate possibilità di sopravvivenza, dormire in letti veri con coperte e disporre di vestiario e docce, ma il fio da pagare era molto gravoso: chi entrava a vario titolo nel Sonderkommando, apprendeva ben presto di aver intrapreso una strada senza ritorno, tanta e tale era la mostruosità degli eventi a cui si era destinati ad assistere: nessuno avrebbe dovuto, (e nemmeno potuto), far trapelare all’esterno il funzionamento della perfetta e demoniaca macchina di sterminio, organizzata per funzionare in modo ineccepibile e continuo con l’ausilio di una catena di montaggio di inservienti prigionieri. Miklos Nyiszli, fu uno tra i pochissimi superstiti dell’ultima squadra del Sonderkommando e durante la sua permanenza in quell’inferno aveva assistito all’avvicendarsi di diversi gruppi che in genere restavano in carica per tre mesi per poi essere eliminati: crudele rito di iniziazione per i nuovi schiavi era quello di “infornare” i loro predecessori. Lui stesso, contando i suoi giorni di permanenza nel campo, più volte ebbe la piena certezza di essere giunto alla fine dei suoi giorni, salvo poi scoprire che la sua attività era di estrema utilità al più feroce ed efferato gerarca nazista del lager di Auschwitz-Birkenau, il dottor Mengele. Quando il convoglio degli ungheresi di cui faceva parte era giunto nella rampa dove avvenivano le prime selezioni, l’umanità prostrata e dolente che aveva per giorni occupato i malsani vagoni, seguendo la quotidiana prassi, fu divisa nelle due consuete file: a sinistra chi era destinato alla morte, a destra gli abili al lavoro. Si ordinò ai medici presenti tra i prigionieri, (il suo vagone conteneva per lo più medici e farmacisti), in particolare quelli che avessero condotto gli studi in Germania e conoscessero il tedesco, di farsi avanti: Nyiszli trovò il coraggio tra i suoi colleghi e rispose a tutte le domande che subito Mengele gli formulò, riguardanti la sua carriera. Questo fu il primo passo del dottor Nyiszly, che superate le normali procedure di introduzione al campo, incluso il tatuaggio del numero sul braccio, era convinto di dover esercitare la sua professione nell’ospedale del lager e non inviato nelle comuni baracche, di cui subito apprese le disumane condizioni, conoscendo appunto il tedesco, ma alloggiato con un gruppo di medici:
I medici sono pienamente consapevoli del proprio crudele destino e dell’impossibilità di vie di scampo, e tuttavia con la più completa abnegazione si impegnano ad aiutare chi attende la propria fine. I pazienti dell’ospedale, infatti, sono gente in pratica già morta, dal momento che lì si può andare solo se gravemente malati… Ridotti tutti pelle e ossa, del peso di una trentina di chili al massimo, autentici cadaveri viventi; il corpo pieno di vaste suppurazioni, le labbra terribilmente tumefatte per la fame, ombre dalla pelle gialla tormentate da incessante diarrea: sono questi i pazienti che bisogna salvare!
Ma l’enfasi umanitaria del dottor Nyiszli fu ben presto smorzata nell’apprendere che il suo ruolo non sarebbe certo stato quello di salvare quelle larve umane da morte incipiente, bensì un altro: dissezionare cadaveri e redigere scrupolosi verbali autoptici dopo aver superato una sorta di esame di prova, consistente in una dissezione, sotto lo sguardo implacabile e il fuoco di fila di domande dell’instancabile dottor Mengele. Egli, dopo ore trascorse sulla rampa a effettuare selezioni, trascorreva anche intere nottate al microscopio o a studiare e ricercare per soddisfare il suo sogno maniacale di apprendere quali anomalie genetiche sottendessero al nanismo, le cause delle malattie e delle tare ereditarie (prerogativa peculiare, secondo lui, di Ebrei e Zingari), quali meccanismi governassero i parti gemellari. Ovviamente, dal suo mostruoso punto di vista, quale contesto avrebbe offerto più materiale umano da sottoporre alle sue ricerche, se non il lager, in cui la vita di quei miserandi, appartenenti a “razze inferiori”, non aveva nessun valore? Ma la sua ossessione era lo studio dei gemelli, il cui scopo era la moltiplicazione della crescita naturale della “razza superiore” eletta per comandare, praticamente scoprire come consentire alle madri tedesche di metterne al mondo con innaturale frequenza. Questo sarebbe stato dunque il compito del medico prigioniero: effettuare ogni giorno autopsie su corpi di esseri umani, non certo periti in modo accidentale, o su gemelli passati a miglior vita nello stesso istante, come egli scoprì dolorosamente, tramite iniezioni di acido fenico al muscolo cardiaco. Il tormento peggiore fu, oltre a svolgere il terrificante incarico in modo sempre preciso e ineccepibile per non incorrere nelle ire dell’abominevole Kriminal-doktor Mengele, il dover tacere gli orribili segreti delle morti violente e il doversi trovare alloggiato in locali prossimi alle camere a gas: in modo incessante tutto il giorno sfilavano in quella direzione mesti cortei di condannati inconsapevoli, sconvolti da giorni di viaggio nei vagoni e spesso reduci da una vita di stenti nei ghetti di mezza Europa. Oltre agli spogliatoi e alle camere a gas, altri locali adiacenti al suo alloggio erano adibiti all’esecuzione di centinaia di prigionieri (che non trovavano posto nelle camere a gas), con un colpo di pistola alla nuca: le urla disperate laceravano il silenzio della notte. Come avrebbe potuto resistere a quello strazio quotidiano? Forse con l’oblio del sonno indotto da sonniferi per non impazzire in quell’inferno senza fine o contando i giorni infiniti di prigionia in attesa della propria fine, come inevitabilmente sarebbe avvenuto?
“Se, comunque, un giorno, tornassi in libertà e raccontassi quello che ho visto, pensate che sarei creduto? Per colmo di sventura, non vi saranno mai parole adatte a dare l’impressione di quello che qui è accaduto. Tuttavia mi sforzo di fissare bene nella memoria le immagini, per non dimenticarle mai”.
A questo punto, mi collego ad un altro capitolo de “I sommersi ed i salvati”, in cui Primo Levi si domanda se l’essere un intellettuale in senso lato o uno scienziato professionista apportasse qualche beneficio o vantaggio agli internati del lager. Egli parte da una disamina dell’intellettuale-filosofo Jean Améry, reduce da prigioni e torture prima del lager, (nel suo stesso periodo e addirittura nella sua stessa baracca ma all’insaputa l’uno dell’altro, fu internato ad Auschwitz), che tratta in modo approfondito questo tema nell’opera, (analisi complessa di carattere filosofico-analitico) “Intellettuale ad Auschwitz”, pubblicato nel 1966: Levi concorda con Amèry su diversi punti, che riguardano la carenza di manualità e la disabitudine al lavoro fisico, la destituzione del ruolo abituale del professionista che certo erano grossi svantaggi che ne impedivano l’adattamento, nel caso sia di Levi che di Niyszli, invece, la specializzazione li salvò, ma la vera condanna era un’altra, di natura psicologica. L’uomo semplice, sostiene Levi, abituato a non porsi domande, si adattava prima, nonostante le ovvie sofferenze, a quel “non cercar di capire”, primo detto sapienziale del lager. Sarebbe stato uno sforzo inutile cercare una logica o un senso, molto meglio investire le energie nella ricerca di cibo e nel modo di proteggersi da stenti e fatica. Invece chi era, per formazione culturale, incline a ricercare, analizzare, comprendere la realtà, non avrebbe mai potuto accettare tutto quel sistema. E neppure la morte era uguale lì, per l’uomo colto era abbellita nell’immaginario letterario, come la gentile trasfigurazione di Ermengarda, Clorinda, Laura, o le morti eroiche per la patria, nel lager era un fatto insignificante, prosaico, triviale, non certo “confortata di pianto”. Questo era dunque il confine tra cultura e incultura, una morte certa, scontata, crudele e intrisa di sofferenza. Niyszli ci conviveva con quella morte, prima vedendo gli orrori più nefandi con gli occhi e poi svolgendo il suo lavoro quotidiano di sezionare quei miserandi resti di uomini, ma pagina dopo pagina il lettore apprende altri suoi gravosi compiti, psicologicamente devastanti, come quello di raccattare occhiali e medicinali dagli spogliatoi delle fosse crematorie, altra terribile realtà del campo, in cui deteneva il potere “il più inumano e degenere criminale del Terzo Reich”, Otto Moll: al suo confronto addirittura in Mengele si poteva cogliere qualche barlume di umana sensibilità.” Gruppi di cinquemila persone alla volta che non trovavano posto nelle camere a gas e nei crematori erano condotte prima in una casa anonima (una volta abitata, ma poi adibita a ben altro uso), dove venivano costretti a denudarsi e lasciare i loro averi, poi ai bordi di un enorme e smisurato rogo, un cordone di SS sparava loro un colpo alla nuca prima di gettarli ancora vivi tra le fiamme divoratrici. Indicibile la paura nei volti delle vittime trascinate nel luogo del supplizio, ma allo stesso tempo nessuno opponeva resistenza, rassegnato, tanto più che chiunque avesse osato ribellarsi sarebbe istantaneamente divenuto il sadico bersaglio del tiratore scelto Moll. Ogni giorno nel campo si vivevano nuove tragedie, intere sezioni erano liquidate, un giorno era il turno degli Zingari, un altro dei Cechi, degli Ungheresi, oltre ovviamente ai selezionati degli affollati convogli ferroviari o delle baracche. Il pretesto per la soppressione in massa spesso era definito “grande campagna di prevenzione delle epidemie” i cui effetti si sarebbero palesati, dopo poche ore, in tre o quattro autocarri di cenere, il cielo oscurato dai fumi spessi dei camini e l’aria avvolta dal terrificante e nauseabondo miasma che si respirava perennemente nel campo. Il dottor Niyszli, spesso, sottoponendosi ad un elevato rischio, mentì sulla causa della morte di alcuni prigionieri, ovvero tifo o altre malattie infettive, perché sapeva cosa sarebbe successo e non aveva nessun altro mezzo per impedire di mandare a morire intere baracche, se non quello di fare carte false. L’unica parentesi positiva presente nel racconto di Nyiszli è costituita dalla gioia di aver ottenuto, tramite un’accorata richiesta al dottor Mengele, il permesso di recarsi nel campo delle donne e avervi ritrovato, seppur in condizioni miserevoli, la moglie e la figlia deportate insieme con lui. Tramite vari espedienti, riesce ad aiutarle e permettere loro di essere trasferite in un campo di lavoro: infatti nel campo si potevano corrompere guardie e SS tramite beni voluttuari come sigarette o alcool che nel Sonderkommando era possibile reperire e ottenere. Proprio l’alcool era l’unico mezzo per i detenuti addetti alle camere a gas e ai forni, con cui riuscivano a estraniarsi dall’atrocità dei compiti di dover districare i grovigli dei corpi dopo la gassazione e trascinarli nei forni, migliaia al giorno, in giorni infiniti in cui il dolore di tale incombenza era sempre più lacerante e la disperazione senza limiti. A ottobre del 1944 il Sonderkommando attendeva la fine della propria esistenza, alcuni crematori erano stati abbattuti per nascondere ogni traccia della loro esistenza all’avanzata degli eserciti alleati, i suoi membri si aspettavano la loro esecuzione da un momento all’altro, perciò fu organizzata una grande rivolta tramite l’introduzione rocambolesca di armi dall’esterno: l’unico atto di ribellione nel lager finì con una carneficina e l’esecuzione di tutti i componenti del Sonderkommando che non morirono negli scontri, solo i tre medici, tra cui Nyiszli, si salvarono, perché si trovavano nella sala anatomica sebbene fossero stati costretti a uscirne, colpiti ripetutamente dai calci dei fucili e risparmiati grazie all’arrivo del dottor Mengele che aveva ordinato la dissezione, che stavano effettuando, poche ore prima.
“Il fatto di essermi salvato non mi dà né sollievo né gioia. Ho avuto solo una proroga. Conosco il modo di pensare del dottor Mengele e delle SS. Semplicemente si rendono conto che il lavoro da me fatto è loro necessario e difficilmente io posso essere sostituito”
Infatti l’attività di camere a gas e forni viene riavviata in concomitanza con l’arrivo dei prigionieri rastrellati in uno dei ghetti più importanti della Polonia: quello di Ƚódź che contemplava circa mezzo milione di abitanti impiegati nei grandi stabilimenti dell’industria bellica, ma dopo cinque anni di vita del ghetto, in condizioni ormai impossibili, erano talmente deperiti che la quasi totalità di loro finì subito nella fila di sinistra: per un’intera settimana durò lo sterminio degli abitanti di Ƚódź. In quell’occasione un compito definito speciale dal dottor Mengele fu affidato a Nyiszli, volto, a suo parere, a dimostrare la degenerazione della razza ebraica: il mostruoso scienziato tedesco volle gli scheletri di un uomo gobbo e del figlio con una deformità al piede. Lo sterminio del ghetto polacco fu forse uno degli ultimi atti finali dei crematori, poco tempo dopo il tredicesimo Sonderkommando venne sterminato, ma ancora una volta i dottori furono risparmiati. Il dottor Nyizsli si salvò dal campo sopportando la marcia della morte e finendo in altri campi tristemente famosi: Mauthausen, Melk, Ebensee fino alla liberazione il 5 maggio 1945.
“Le umiliazioni e i dispiaceri, le atrocità dei crematori e delle fosse crematorie, otto mesi trascorsi tra i sepolti vivi, nel Sonderkommando, mi hanno fatto quasi perdere il senso del bene e del male [..] I miei occhi hanno accompagnato nelle camere a gas centinaia di migliaia di persone. Ho visto innocenti bruciare nelle fosse. Su ordine di un pazzo fanatico, che si riteneva un genio, ho aperto i cadaveri di centinaia di vittime. Due volte ho visto la morte in faccia, ho detto addio a milletrecento cadaveri di compagni di sventura, rimanendo unico testimone”.
La cruda testimonianza di Miklòs Nyiszli termina col rientro a casa e il ricongiungimento con moglie e figlia, ma ci lascia pagine uniche, intrise di sofferenza su quella sopraccitata zona grigia che molti decenni più tardi (Nyiszli pubblica le memorie nel 1946), sarebbe stata riproposta da Shlomo Venezia che, come schiavo ai forni, visse in quel luogo di abiezione in cui, nell’intenzione dei capi SS, non ci doveva essere più spazio per sentimenti e umanità che in un assurdo mondo straniato divenivano impraticabili e sostituiti da un abbrutimento disumanizzante. Niyzli invece ci riferisce episodi di umanità, nonostante tutto l’orrore a cui erano sottoposti, dei membri del Sonderkommando, che superando l’impossibilità, tentavano di aiutare altri prigionieri con cibo e abiti, oppure episodi che rasentano il paradosso, ovvero partite di calcio tra loro e le SS, dimostrazione questa, che nel lager, microcosmo di realtà deformata, tutto sfuggiva a ogni comune parvenza di normalità, conclusione a cui giunge Primo Levi nell’analizzare quest’aberrante pagina di storia e che riassume anche in questa frase: “Il linguaggio di tutti i giorni è adatto a descrivere le cose di tutti i giorni, ma qui è un altro mondo, qui ci vorrebbe un linguaggio “dell’altro mondo”, un linguaggio nato qui”. Anche quello di Niyszli appare tale, nelle descrizioni spettrali del campo e nel rendere il lettore partecipe del funzionamento della fabbrica della morte, ma pur nella sua brutale crudezza, ha consegnato ai posteri uno straordinario documento dall’enorme valenza storica contro tutte le forme di violenza, discriminazione e ingiusta sopraffazione che continuano a dominare nella società contemporanea.
 Sono stato l'assistente del dottor Mengele
Sono stato l'assistente del dottor Mengele
Saggistica
DeltaEdit
2013
192 p., brossura