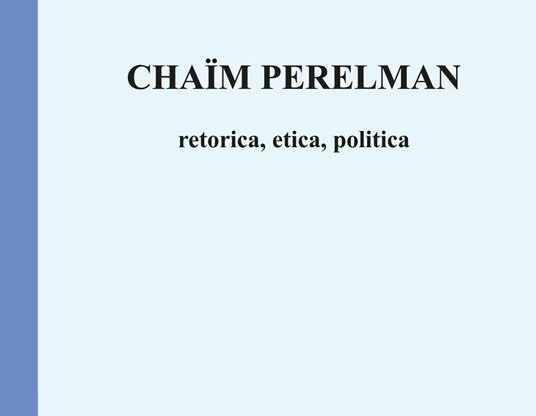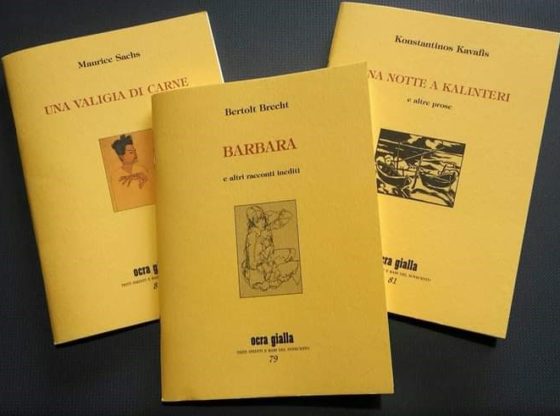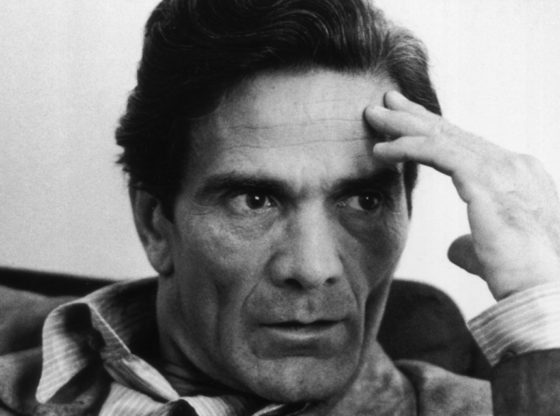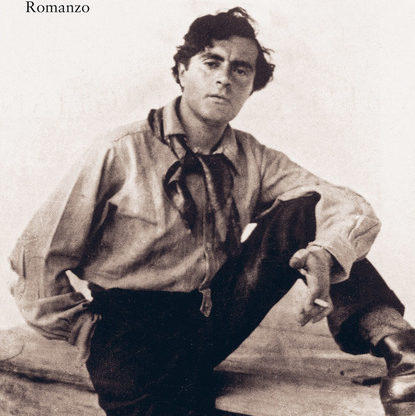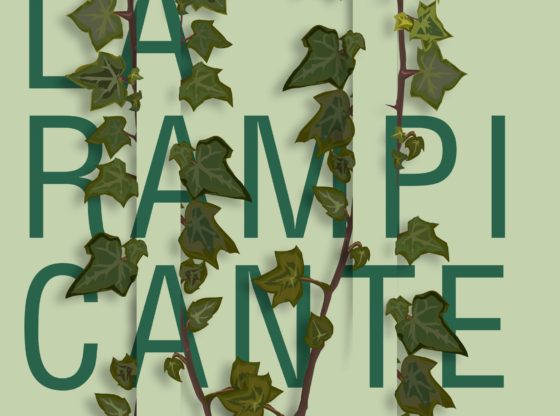Lo spazio ibrido. Intervista a Simone Casalini
Di Geraldine Meyer
Ci sarebbe un’altra globalizzazione, un’altra storia. Invece c’è la globalizzazione dell’immemoria, se così possiamo prenderci la licenza di chiamarla, la globalizzazione della chiusura claustrofobica. La globalizzazione altra potrebbe essere quella dell’ibridazione, della mescolanza, la globalizzazione di un discorso che riconosce nell’alterità il risultato eccentrico alla logica binaria. Quel “uno più uno” che non fa due ma tre. Una nuova semantica, una nuova lingua e, alla fine, una nuova logica di lettura.
Di questa nuova logica ci parla Simone Carlini, caporedattore de Il Corriere del Trentino, con questo suo Lo spazio ibrido, da poco pubblicato da Meltemi. Spazio ibrido come frontiera, come confine ma, soprattutto, come ibridazione e creolizzazione, come lo definisce in queste pagine. Lo spazio ibrido è non solo un viaggio ma un vero e proprio discorso politico che, tenendo ben presente il Mediterraneo come “spazio osmotico”, ci racconta alcuni luoghi emblematici come Mentone, Genova, Mazara, Trieste e culture come quelle, banalmente e superficialmente da molti definite islamiche. Con una definizione monolitica, priva di sfumature che è andata, e sempre più va, a arricchire la narrazione più votata alla semplificazione.

Culture, frontiere, società in transizione è il sottotitolo che mette luce su quelle che sono le parole chiave di questo saggio. Un saggio dall’approccio multidisciplinare, un saggio in cui l’autore percorre la strada più completa e complessa, quella che sa di non poter disgiungere i luoghi, con la loro conformazione e la loro geografia, dalla storia, dalla cultura e dalla società.
In esergo alcune parole di Michel Foucault che ben disegnano la cifra e la trama di questo libro: “Ciò su cui vorrei insistere, per finire, è questo: non vi è instaurazione della verità senza una posizione essenziale dell’alterità; la verità non è mai il medesimo; non può esserci verità che nella forma dell’altro mondo e della vita altra.”
Dunque, qui, non solo il Mediterraneo come cartina di tornasole di ciò che, storicamente, è una misticanza di culture, ma ancor più la constatazione di come la nostalgia sovranista e nazionalista di molti sia una deriva, non solo antistorica ma finanche semantica. Eppure. Eppure cosa sta avvenendo, cosa avviene e cosa è avvenuto quando il confine smette di essere una soglia per divenire una chiusura? Cosa accade quando si confonde multiculturalismo e interculturalità, come fossero la stessa cosa? Cosa accade quando si fa una narrazione che vorrebbe non essere colonialista ma resta comunque invischiata in un discorso in cui a definire cosa sia marginale è sempre e solo ciò che pensa di essere “al centro”?
Attraverso alcune tappe geografiche che diventano tappe storiche, sociale e anche urbanistiche, Casalini in mezzo a ciò che lui descrive come “negoziazione e interlocuzione” dicendoci che: “La negoziazione e l’interlocuzione sono piani di costruzione sociale determinanti perché consentono di sbaragliare la fissità come elemento di costruzione ideologica dell’aterità e dismontare o rallentare la macchina della stereotipia che è sempre in funzione e si ciba di molteplici significanti, dal colore della pelle al simbolico religioso per arrivare allo schematismo sessuale.”
E allora ecco un viaggio composito, articolato e sfumato tra le pieghe e le contraddizioni di un mare che diviene portatore di confronti (tra tutti quello fra cristianesimo e islam) e punto di osservazione molto più “tollerante” rispetto a quello che si può avere dalla terraferma. Un libro documentatissimo, con testimonianze e episodi storici (ma non solo) poco noti o per nulla noti. Anche questo sovvertimento, in fondo, tra ciò che molti raccontano e ciò che pochi raccontano, è il mescolamento che solo il mare riesce a compiere tra ciò che sta ai margini e ciò che sta al centro. Ne parliamo con l’autore.
Ciò che più colpisce di questo libro è il concetto di creolizzazione. Che è qualcosa che va oltre l’integrazione. Ce lo vuole spiegare con qualcosa che, per il lettore, arrivi come un esempio forte?
“Nella “Poetica del diverso” Édouard Glissant descrive la creolizzazione come un processo di ricomposizione del proprio paesaggio mentale. Significa, cioè, lasciare che codici e grammatiche immutabili vadano alla deriva per aprirsi alle innumerevoli interferenze culturali che abitano la nostra quotidianità. Un altro autore postcoloniale, il filosofo indiano Homi Bhabha, ricorre al concetto di ibridazione nella sua opera principale, “I luoghi della cultura”, per descrivere una nuova area di negoziazione del significato e della rappresentazione. Credo che le strade, le piazze, le scuole, i condomini, il mare siano pieni di questi processi in cui si verificano sovrapposizioni culturali che possono germogliare nuove culture e che rovesciano le stereotipie. A Mazara del Vallo, dove dalla fine degli anni Sessanta si è costituito un flusso migratorio consistente dalla Tunisia, si è determinata nei crocicchi della casbah una nuova lingua informale che ibrida il dialetto mazarese e quello arabo-tunisino. È un punto elevato di creolizzazione. Più in generale, le seconde generazioni (ossia i figli dei migranti) sono soggetti plurali, che compendiano e fondono più elementi culturali, rappresentando un’avanguardia. Anche se talvolta soffrono per essere considerati due volte stranieri: nel Paese nativo e in quello d’origine della famiglia. La creolizzazione è un procedimento sempre sul filo della contraddizione che ha bisogno di una componente essenziale: la parità tra culture”.
Come ha scelto, e perché, i luoghi di cui parla nel libro?
“Alcuni luoghi li ho scelti perché appartengono al mio sguardo e al mio immaginario simbolico. Penso a Genova e al suo angiporto dove persone di estrazione sociale molto differente – dalle prostitute all’intellettuale, dal migrante clandestino al professionista – convivono nelle stesse abitazioni e condividono i medesimi spazi. Poi ci sono le frontiere – come Ventimiglia/Mentone o il Brennero – in cui si rinsaldano storie che provengono da epoche diverse e che pure dialogano. Nel cimitero di Trabuquet a Mentone sono seppelliti 1.137 tirailleurs sénégalais che combatterono contro la loro volontà sul fronte della prima guerra mondiale sotto le insegne della Francia, morendo a migliaia. A cento anni di distanza, a Ventimiglia, si sono accatastate le vite dei tanti migranti che vorrebbero varcare volontariamente la frontiera francese, ma a cui è impedito transitare. E molti di loro portano gli stessi nomi e gli stessi cognomi dei loro antenati che in Francia arrivarono con la coscrizione obbligatoria. Altri luoghi ancora, come la Tunisia, rappresentano ai miei occhi un paradigma della contemporaneità: la fuoriuscita definitiva dal lungo periodo della decolonizzazione e l’ibridazione di culture e storie eterogenee anche innescate dalla violenza coloniale. La Tunisia è Africa, Medio Oriente, Mediterraneo e Europa. Un crocevia plurale con pochi eguali. E poi, ancora, ci sono gli spazi della mia città di residenza, Trento, e in particolare la Residenza Fersina, una struttura ricavata da ex caserme, che ospita i richiedenti asilo. Mi ha ispirato un testo di Michel Foucault, “Storia della follia nell’età classica”, in cui descriveva la nascita alborale dei manicomi e dello statuto del folle – poi riconosciuto dalla scienza medica – come nuova necessità di ordine della società dopo l’estinzione delle grandi pesti e dunque la liberazione dei ricoveri destinati ai malati. Accade un processo analogo nelle nostre città, si assegna un nuovo statuto, quello di profugo, e lo si destina lontano dagli sguardi della società in spazi che cambiano funzione (da quella militare a quella di ordine sociale). Ma le loro voci e i loro idiomi – dal wolof al tigrino, dal bambara all’urdu – che s’inseguono nelle strade limitrofi segnano la rottura del tempo unico e monoculturale della città, aprono uno squarcio: quello della differenza”.
Sembra che la storia abbia indicato come il punto di osservazione più articolato sarebbe quello dal mare. Eppure, in questa epoca più che mai, a dettare legge pare essere lo “sguardo da terra”, statico e pieno di pregiudizi. Come si è arrivati a questo secondo lei?
“Credo vi siano più elementi. Il primo attiene al campo culturale, ossia la difficoltà di tematizzare l’Altro e la relazione con lui. Nonostante l’evoluzione delle teorie, la ricchezza dei contributi – come quelli degli autori postcoloniali – registriamo una sistematica ripartenza. Non da zero perché le società si sono evolute in una direzione plurale. Ma l’incontro con l’Altro, con l’inatteso – come racconta Claudio Magris in una delle interviste conclusive a proposito del viaggio – rimane un tema difficile da emancipare perché la differenza spaventa e impegna emotivamente. Esiste, in secondo luogo, una ragione materiale ed economica che attiene alla Grande crisi del 2008 e al processo di globalizzazione. Le tante ferite prodotte non sono state suturate dalla solidarietà né dalla costruzione di modelli economici e giuridici alternativi che riconoscessero dignità e cittadinanza a tutti. Nel conflitto sociale tra ultimi e penultimi c’è sempre un elemento spurio che viene additato come l’appestato. La politica si è assunta questa grave responsabilità: di costruire un discorso pubblico di esclusione che ha ri-tematizzato i confini come barriere protettive e le comunità come nuclei omogenei, culturalmente e socialmente. Anche se questo è sistematicamente smentito dalla realtà”.
Spesso anche quando si è convinti di fare un discorso di tolleranza, si scade nell’esotismo. Un discorso inevitabilmente coloniale e “occidentecentrico” se mi consente questa definizione. È ancora possibile, obiettivamente, uscire da questo cortocircuito? Obiettivamente intendo con la narrazione politica che ormai si fa, in Europa e non solo, dell’emigrazione?
“Nel suo libro “Orientalismo”, che ha segnato uno spartiacque, Edward Said è risalito alle origini di questo sapere deviato. Cioè la produzione di conoscenza nelle accademie occidentali ha affrontato l’analisi storica e culturale propria dei Paesi ex colonizzati, ma ha raccontato la loro storia alla luce dell’esperienza coloniale. Del resto per molti secoli questi Paesi non hanno avuto una Storia e sono stati percepiti come epifenomeni di chi li ha colonizzati. Oggi è ancora forte questa tendenza anche se, nella fase di decolonizzazione, molte ex colonie hanno ripristinato una loro narrazione storica, hanno ricostituito una classe di storici, stanno cercando di riappropriarsi del loro passato. Per uscire da questa rappresentazione deviata dovremmo procedere alla revoca del monopolio geopolitico della storicità, come invitano i postcoloniali, o “provincializzare l’Europa”, come sostiene in un suo libro Dipesh Chakrabarty. E riportare alla luce le storie del mondo per costruire un processo narrativo plurale. È quello che ho provato a sperimentare nel mio libro: ri-scrivere la nostra vita in comune attraverso le voci dei soggetti subalterni, protagonisti di una nuova Storia”.
Oggi è diventato quasi ossessivo il richiamo a una presunta identità nazionale, a una presunta difesa di confini e valori. Non mi pare vi sia un progetto politico realmente interessato ad affrontare la questione dal punto di vista dell’ibridazione che vada realmente a contrapporsi a quella chiusura. Cosa fa maggiormente paura nel capire che l’ibridazione è un percorso inevitabile?
“È senz’altro vero, anche nel campo di chi vorrebbe includere gli strumenti di analisi sono assai deboli. Si parla di integrazione (per intendere l’assimilazione di degaulliana memoria?), di generica convivenza oppure si affronta la questione sul lato etico o religioso. E allora intervengono la pietà, la carità, la compassione. Tali approcci riproducono, come nell’esclusione, uno sbilanciamento delle relazioni tra soggetti egemoni (i caritatevoli) e soggetti subalterni (i migranti). Non si costruisce ibridazione perché è assente il presupposto essenziale: la parità. Questo è quello che fa paura: porsi sullo stesso piano, accettare la sfida dell’uguaglianza. Homi Bhabha, non a caso, afferma che l’ibridazione è eresia senza nascondersi la difficoltà di un simile itinerario. Ma è altresì vero che i concetti di identità nazionale, confine, popolo – per come li abbiamo definiti da un punto di vista politologico – sono scompaginati nel tempo coevo. Definiamo “nazione” una collettività di persone accomunate dai fattori di lingua, etnia, cultura e religione. Mi indichi un posto al mondo dove si verifica questo. Non esiste. La sovranità e il potere, poi, hanno assunto profili sovranazionali, semmai la questione centrale è ridisegnare i diritti e la cittadinanza su tali assetti. Penso, per concludere, che dobbiamo inseguire la verità. E osservava Foucault che “la verità non è mai il medesimo” e che “non può esserci verità che nella forma dell’altro mondo e della vita altra”. Se questo è il principio guida l’ibridazione è possibile nel presente – e avviene quotidianamente – così come lo è stata nella Storia”.
 Lo spazio ibrido. Culture,frontiere, società in transizione
Lo spazio ibrido. Culture,frontiere, società in transizione
Saggio
Meltemi
2019
206