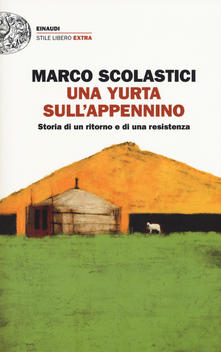Di Geraldine Meyer
Con Guerra del ’15, di Giani Stuparic, ci troviamo tra le mani qualcosa di più di un diario. Sono, forse più esattamente, schegge di vita in mezzo alle schegge delle granate e delle armi tra le trincee. Come scrive Giuseppe Sandrini nella bellissima postfazione al libro: “Sono annotazione schelettriche, un supporto alla memoria, una testimonianza dell’esserci ancora, nel quotidiano confronto con la morte.”
Quello che era, in origine, un taccuino “tutto sporco di rosso terriccio del Carso” è diventato poi la testimonianza in forma di libro vero e proprio di Giani Stuparich, all’epoca soldato del I Reggimento Granatieri sul Fronte di Monfalcone durante la Prima Guerra Mondiale. Pagine che restituisco tutta intera l’immane tragedia di quel conflitto, la corporeità del confronto con il nemico, quel sentirne la presenza anche quando tutto tace.

Un diario che è sì psicologico e personale ma intriso di quella lucida capacità di osservare che è quasi da cronista innamorato della poesia e della letteratura. Perché, tra queste pagine, di letteratura ve ne è molta, di quella vera, di quella scomodo. Utile, per comprendere ancor meglio questo piano della scrittura, leggere ancora dalla postfazione: “E qui bisogna sottolineare il carattere dell’autore di Guerra del ’15, quella disposizione di animo e di stile che l’hanno portato a scrivere uno dei libri più belli e più veri sul catastrofico conflitto di cent’anni fa. Il Giani Stuparich che parte per il fronte ha già in stampa un saggio su La nazione czeca, in cui mette a frutto la sua esperienza di studente a Praga per ragionare sul sogno, di origine mazziniana, di un’Europa come federazione di popoli liberi e indipendenti. Il suo amore, tutto triestino, per l’Italia ha una radice ideale e sentimentale che ha poco a che vedere con l’invasamento nazionalistico di tanti italiani del Regno; è un amore nato davanti ai monumenti di Firenze e sulle pagine dei libri.”
Stuparich, infatti, in quanto triestino avrebbe dovuto combattere dall’altra parte del fronte ma ha fatto una scelta di campo che è culturale, prima di tutto. E tra queste pagine, questa cultura, fuoriesce a piè sospinto in molte pagine. In questi giorni complessi e difficili, per certi aspetti inediti, in cui le metafore e il linguaggio ci parlano sovente di guerra, “siamo in guerra”, “dobbiamo resistere”, le pagine di Guerra del ’15 ci portano negli odori, nelle paure e nell’incertezza di avere a che fare con un nemico che, come nel libro, sappiamo che c’è anche non vedendolo.

Ma non è per questo motivo che le pagine di Stuparich sembrano acquistare attualità. Niente affatto, noi non siamo in trincea. Ma il motivo è, semmai, nella ricostruzione narrativa di tutto un sistema che portò allora la guerra e, oggi, una crisi che non è solo sanitaria. Non appaia eccessivamente ardito il paragone perché paragone non è quanto, semmai, chiave di lettura. Per entrare ancora di più tra le pagine di questo libro in cui alla quotidiana convivenza con la morte si accompagna la fame di vita, la nostalgia, il desiderio di tornare alla vita di prima, ma anche la consapevolezza di un dovere da compiere, anche e soprattutto da parte dei gregari, come Stuparich tra quelle trincee che, però, è convinto di quanto la disciplina sia importante. “Nell’ordine e nella chiarezza la fatica pesa meno” dice, immergendoci ancor più nella sua necessità, che è necessità universale, di avere punti fermi.
Sono struggenti le pagine in cui lo scrittore ci racconta dell’entusiasmo, ingenuo e incosciente, con cui all’inizio si parte per la guerra, sentendosi chiamati a qualcosa di grande che porta con sé, inevitabilmente, il martirio: “I guerrieri e i martiri della croce procedettero forse così sorridenti e illuminati […]” scrive Stuparich. Mentre, tra attacchi e ritirate, trova il tempo di guardare la natura, ammirarne l’apparente indifferenza a tutto, confortandosi per la vicinanza al fratello e struggendosi di nostalgia per la madre.
Vi sono parole di profonda analisi che, lette e rilette, conducono inevitabilmente a piani extra bellici, come quando scrive: “Siamo avanzati nel silenzio sacro, come conquistatori primitivi, misurando a vasti passi la terra incontrastata, intrepidi nella vergine conquista. Ed ora invece siamo vulnerabili, perché abbiamo scavata la trincea ed ogni corpo ha lavorato per il suo riparo. L’incantesimo è rotto: il nemico che può assalirci e contro cui andiamo cauti, esiste, si precisa, è fatto come noi.” È chiaro che queste parole abbiano una portata ben maggiore di quella di un proiettile.
Smarrimento e stupore, sentimenti che restano addosso al soldato che scrive e a noi che leggiamo. Che ci portano a capire come il tempo non sia il calendario e a come lo si comprenda quando esso viene catapultato in un terreno per orientarsi nel quale ci vogliono altre coordinate: “Quante volte ho percorso col treno, in tempo di pace, questa linea: da una parte le rocce del Carso, dall’altra la verde pianura; ancora vi stanno sui loro pali, disposti lungo la linea, i cartelli con la scritta Terme di Monfalcone, che allora fuggivano davanti agli occhi.”
Eppure. Eppure anche in guerra, forse soprattutto in guerra, può sorgere un sentimento profondo, che si agita in ciascuno e che non ha a che fare con dio o la religione ma che interroga sulla capacità di umanità: “Mi trema nel petto un disperato sentimento di pietà non solo per questi uomini votati alla morte, ma per ogni creatura umana.”
Sì, Guerra del ’15 è un libro pieno di pietà.
 Guerra del '15
Guerra del '15
Diario
Quodlibet
2015
195 p., brossura