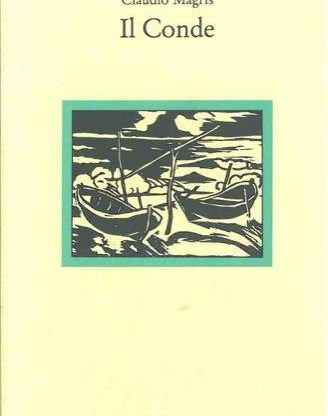L’indifferente corrente della vita
Di Laura Vargiu
Curiosare tra gli scaffali di una biblioteca, uno di quei piaceri che qualsiasi lettore dovrebbe concedersi di tanto in tanto, non è mai tempo perso: è così, infatti, che ci si imbatte in testi talvolta sconosciuti e si scoprono, addirittura, piccoli gioielli di autori già noti. Proprio come questo libriccino di Claudio Magris, che ho trovato per puro caso, in apparenza dimenticato, schiacciato tra due grossi volumi che quasi lo nascondevano.
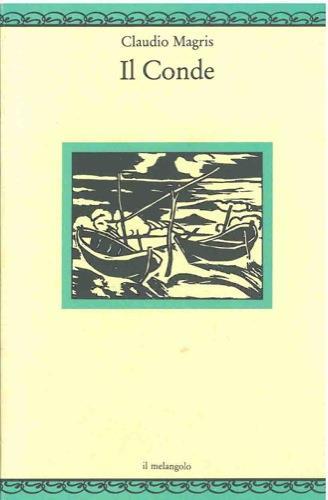
Seppure il nome di Magris, tra quelli dei maggiori intellettuali del nostro tempo, evochi l’affascinante città di Trieste e scenari decisamente mitteleuropei, oltre ad alcuni suoi famosi titoli ben più corposi, il racconto racchiuso in questa manciata di pagine ci catapulta all’improvviso lontano dal corso del Danubio, lungo quello avventuroso del Tâmega o alla foce del Douro al cospetto dell’Atlantico, là dove acque di fiume e di mare si abbracciano e confondono.

Pubblicato nel 1993 da Il melangolo e già comparso in precedenza con il titolo “Io, pescatore di anime morte” sul Corriere della Sera, nonché tradotto in diverse lingue, “Il Conde” racconta la vicenda di un barcaiolo portoghese, anonimo io narrante che, seguendo la corrente dei ricordi al pari di quella del fiume, ripercorre malinconicamente un’esistenza consumatasi a ripescare cadaveri insieme al Conde, il “conte”, signore indiscusso dei fiumi la cui fama si è sparsa ovunque per terra e per mare, proprio in virtù della sua lugubre e poco invidiabile, ma necessaria, attività di pescatore di morti annegati che col tempo gli ha conferito un’aura di misterioso fascino. La conosce a memoria il nostro protagonista, la storia del Conde, di cui parlano persino i giornali; potrebbe essere anche la sua, iniziata per mare a tredici anni arpionando merluzzi. In fin dei conti, le storie intrise d’acqua, così “amara di perdizione”, si assomigliano un po’ tutte. È l’acqua stessa che, in verità, sia essa dolce, salata o magari piovana, “si assomiglia dappertutto”, facendo divenire le cose sempre più uguali.
“Ma sentite come viene giù tutta questa pioggia, […] cosa volete che a uno importi, con quest’acqua da tutte le parti, sopra e sotto, dentro la finestra e presto dentro la camicia, che non si capisce più dov’è il cielo e dove il fiume e dove il mare, cosa volete che gli importi, non so se mi spiego, se la gente o i giornali chiamano Conde, già, il Conde del fiume, lui o un altro?”
La vita di questi pescatori di morti, ormai ombre essi stessi che sembrano provenire da una dimensione senza tempo, si perde nella silenziosa solitudine dell’acqua, da dove riaffiorano cadaveri, sorrisi enigmatici di polene smarrite da chissà quali antiche navi, ricordi che, come ferite mai richiuse, bruciano ancora. Li si sente tutti, quei silenzi, quelle solitudini, gravidi d’amarezza e rassegnazione dinnanzi alla vita che, impietosa e indifferente, scivola via nell’umido grigiore di giorni sempre uguali, appena scalfiti dalla dolcezza dell’amore, mentre la voce stanca del barcaiolo racconta di sé, del Conde e del loro mestiere misericordioso che dà sempre di che vivere poiché – verità sacrosanta e sempre valida – “[…] chi sceglie come sua specialità la morte non corre il rischio di restare disoccupato”.
“Sì, conosciamo tutti la sua storia, le centinaia che, in più di quarant’anni, ha ripescato un po’ da tutte le parti, nel Douro e negli altri fiumi […] o nel mare, guardandosi intorno come un falco o tastando il fondo con la stanga uncinata, perché qualche volta si impigliano a chissà cosa e restano sotto e lui paziente per ore e ore finché non li scopre e afferra nel modo giusto, attento a non spingerli che non scivolino via per sempre […]. A lui è sempre piaciuto quando galleggiavano gonfi da scoppiare o magari mangiati dai granchi, pronti per essere acciuffati e messi su. […] e allora è una notte buona per il suo, per il nostro lavoro, c’è tanta gente da andare a ripescare per seppellirla in terra benedetta […].”
Attraverso una splendida prosa che, fin dalle prime righe di questo lento monologo, conquista e seduce, la sapiente penna di Magris dipinge una piccola sorprendente storia che profuma di vento e salsedine, ma anche di taciuti rimpianti e orizzonti che non si è avuto il coraggio di scorgere, nella quale non si fatica a riconoscere il peso di quell’ineludibile dolore che scandisce l’umano nostro vivere; ci si affida fatalisticamente a una corrente che trascina tutto e tutti dalla stessa parte e permette pure, nel mucchio, di ritrovare se stessi, spesso al prezzo, tuttavia, di aver perduto molte vite (o di non averne mai avuta una) e di non sapere nemmeno che cosa si sia perso. Una superba prova di scrittura, questa dell’autore triestino, a mio parere sottolineata ancor più dai limiti angusti concessi a una trama a cui, tale è in essa la profondità di pensiero, soltanto chi è un grande scrittore avrebbe saputo dare vita.
Narrativa
Il Melangolo
1993
51 p., brossura