La peste scarlatta. Non si è mai abbastanza soli
Di Geraldine Meyer
Nell’anno 2013, mentre l’intero mondo si trova sotto il dominio del Consiglio dei Magnati dell’Industria, una pandemia di peste annienta tutta la razza umana. Sessant’anni dopo, quello che per lungo tempo ha creduto di essere l’unico sopravvissuto, si troverà a raccontare a uno sparuto gruppetto di ragazzini selvaggi, nipoti degli altri pochi scampati alla pandemia, ciò che accadde in quel lontano passato. In uno scenario post apocalittico di una California tornata all’età della pietra, l’uomo imbastirà un monologo davanti al fuoco, dopo una battuta di caccia, ricordando, forse più a sé stesso che ai giovani con lui, come la civiltà ebbe termine e come, soprattutto, il “pretesto” della pandemia la fece rapidamente ripiombare negli abissi della barbarie più violenta e bestiale.
Questo il tema de La peste scarlatta, romanzo visionario e ancora attuale, che vide la luce, per la prima volta, nel 1912. Gettando così in un tempo futuro, quel 2013, per noi lettori in realtà così vicino e già passato. Romanzo post apocalittico, si diceva, non molto posteriore all’altro capolavoro, seppure così diverso per stile, linguaggio e ambientazione, che fu La nube purpurea, racconto di una umanità sterminata da una misteriosa e velenosa nube. E che non può non richiamare alla mente altri due testi, a noi più vicini nel tempo come La strada, di McCarthy e Dissipatio HG di Morselli, citati non a caso anche nella bellissima postfazione che accompagna questa edizione e curata da Ottavio Fatica.
Dentro un testo di London, anche dentro un testo come questo, non potevano mancare elementi di critica sociale. Un vecchio socialista come lui ha imbastito, con questo testo, una critica feroce ad una umanità che, non solo e non casualmente si trova ad essere governata dai magnati dell’industria, ma anche spazzata via in un momento (già allora) in cui la sua protervia e la sua arroganza l’avevano portata a credere di poter dominare il mondo. Il virus del capitalismo, del dominio del forte sul debole (o del privilegiato su chi privilegiato non è) diventa, in queste pagine, il virus della peste. Che, se da un lato riporta l’umanità agli albori della sua nascita, dall’altra però la vede pronta a perpetuare le stesse dinamiche di potere, di sopraffazione, di lotta di tutti contro tutti.
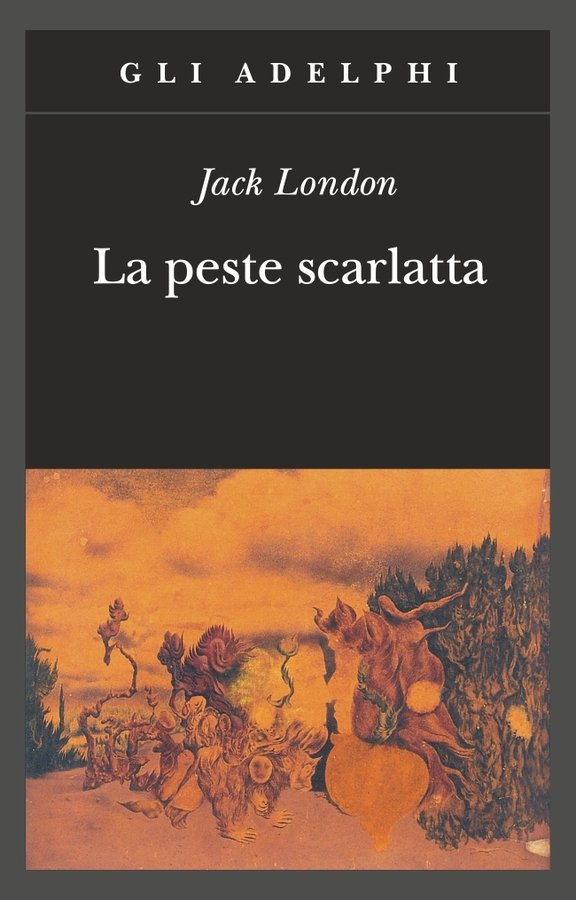
In queste pagine ciò che più colpisce è il piano linguistico su cui London pone attenzione. A fare da scissura incolmabile, tra passato e presente, è proprio il linguaggio usato dal vecchio sopravvissuto e di non facile comprensione per i ragazzini che lo ascoltano e che, spesso, chiederanno, abituati ormai ad usare parole ridotte al minimo, cosa significhino alcune parole. Il vecchio e anche questa ci appare come scelta non casuale, era professore di letteratura, nel mondo che non esiste più. Quasi una metafora di una cultura e di una parola che sono i primi elementi fondativi di una civiltà ma anche i primi elementi a risultare inutili e inutilizzabili in una civiltà tornata alla pietra e ai suoni inarticolati.
Elemento, questo, strettamente legato anche a quello della disperata riaffermazione dell’individualità (ognuno pensa per sé) che però, paradossalmente, approda ad una sorta di indistinto, in cui tutti sono uguali a tutti, brandelli di carne ridotti a sopravvivere e a diventare una massa indifferenziata di brutalità e vigliaccheria. Ma anche egocentrismo. Di cui il mite professore è, in fondo, portatore; dapprima credendosi l’unico sopravvissuto, poi pensandosi l’unico uomo degno della donna incontrata dopo anni di solitudine disperante, poi chiedendosi perché la peste non si sia portata via l’ultimo uomo talmente malvagio da non meritare la vita. Quasi una sorta di cortocircuito del pensiero e del linguaggio. Perché, alla fine, l’ego nella solitudine si inceppa e si spaventa, pur sapendosi solo. Fenomeno che Ottavio Fatica, in modo assai preciso, descrive come la sensazione di “non essere mai solo abbastanza”.
Un libro teso, che non lascia tregua e scampo, in cui più che intravvedere banalmente agganci con l’oggi, è più proficuo sentire una domanda in sottofondo. Quella domanda che chiede quanto valga davvero sopravvivere se la sopravvivenza è tutto ciò che resta. E quanto sappia, l’umanità, ricordare gli errori, i petti gonfi di niente e arroganza. Questo, in fondo, sembra dirci il vecchio narratore, malinconico, spaventato eppure, in un certo modo, nostalgico di quella stessa umanità già malata, ancora prima di essere spazzata via dalla peste.
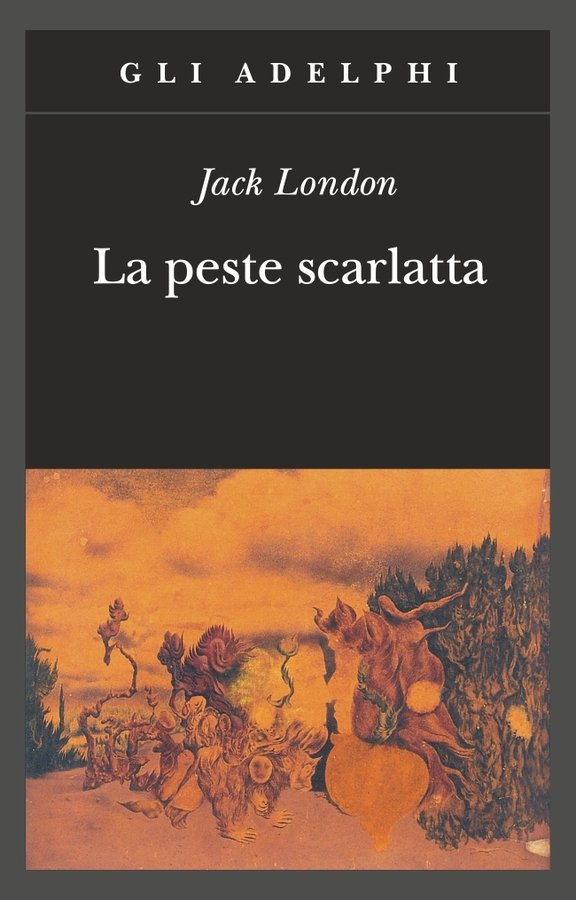 La peste scarlatta
La peste scarlatta
Gli Adelphi
Letteratura distopica
Adelphi
2009
94 p., brossura



