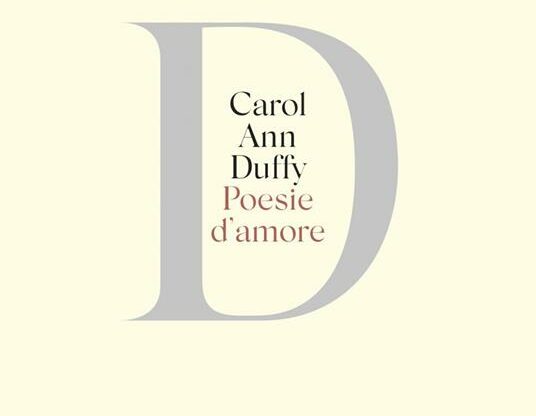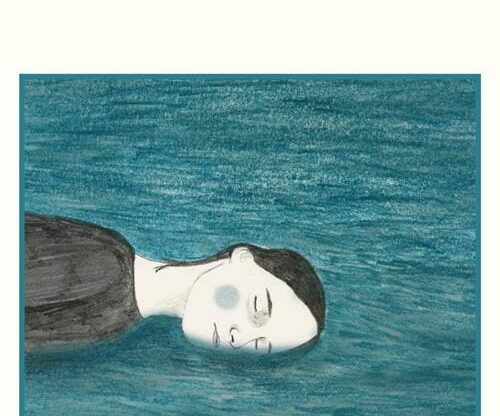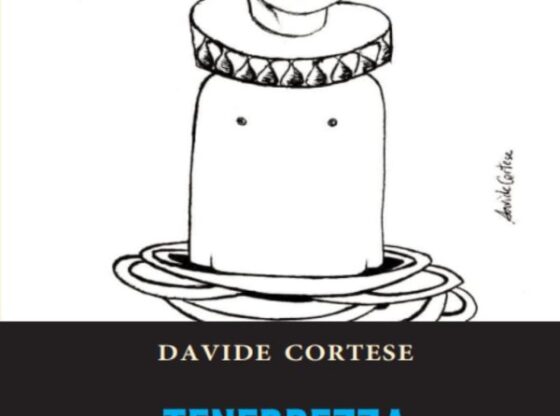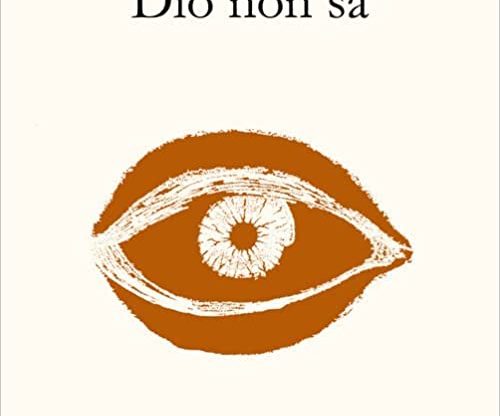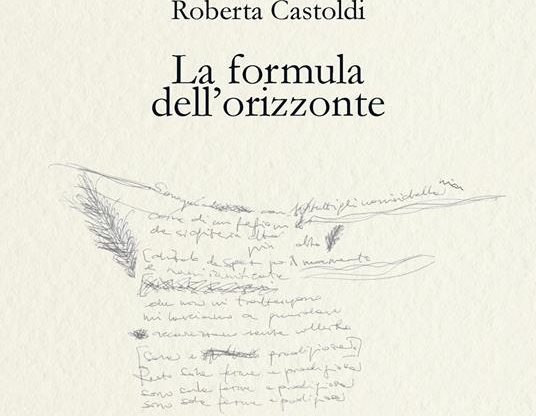Andrea Gruccia e la sua poesia
Di Andrea Gruccia
Mia zia abita in una frazione che si chiama ‘fabbrica’, una casa circondata da terra che respira.
Lei appassionata di botanica, era abbonata a riviste floreali, le teneva per me, parlavamo di fiori.
Un giorno dentro casa c’era solo lei e il sole tra le persiane. MI offrì acqua e menta, con le mani sporche di verderame.
-Siediti, che ti racconto una storia.
Nel mondo sottosopra per entrare nelle case, bisogna passare dalla cantina. Le radici degli alberi fuoriescono dalla terra, e anche il mare passa sopra; al posto del cielo, un oceano, profondo fino al buio. Il cielo d’ inverno si congela a terra, sembra un quadro.
-E tu ci sei stata?- Le dissi.
– Certo, quando ero giovane, avevo trovato una casa segreta, con una porta segreta, che si apriva a quel mondo, un giorno staccai una nuvola surgelata e la misi nel congelatore
Sono passati anni, ogni tanto la guardo.-
– Posso vederla?-
Zia tirò fuori un quadratino di ghiaccio, e io feci finta di crederle.
Mi colma un sentimento
di vuoto, intorno è silenzio
al sole, i colombi nascosti nelle grondaie,
e altri pennuti danno voce agli alberi.
Accarezzo un tavolino
come un corpo caldo
ci sono belle cose in giro
come sempre, qualcuno fa festa,
cosa mi ha portato qui?
Un mantra sbagliato,
o il completamento di una fotografia.
Il cielo azzurro buca i pensieri,
è passato un anno da ieri,
le cose belle tengono sveglio
il tempo, chiodi di nostalgia
è ruggine la tua voce
lontana come tutti i ricordi.
È cattivo il sole con noi
che usciamo come lumache
impaurite,
che rifanno il guscio ogni giorno,
e si riparano nell’ ombra.
Dalle finestre vedo rondini
sotto la grondaia un nido,
non so se fa poesia,
questo via vai,
questo vai via,
questa via che non è casa mia.
Si dona il tempo al nulla,
a voci mute che ci comandano
e la fatica ci fa ricordare
la nostra specie di missione.
Anche i sogni si addormentano
e si risvegliano quando non abbiamo forze:
bisogna incontrarsi con se stessi
per essere per un attimo felici.
L’ estate di notte, tenuta in piedi dalle luci della borgata, e dai piccoli cancelli che portavano al ciabot. Così si passavano sabati sera o le domeniche, la festa era notturna, sotto alle falene, giocavano a bocce, e sulle panchine le madri, le zie, le mogli, ridevano e parlavano di cose lontane come le stelle.
Ora rivedo quei parenti rotolare con i loro corpi, come armadilli che presi dallo spavento diventano sfere, come ricci che rotolano da piramidi. Eppure ridono, come forme rievocate, ed io come un grillo, mi nascondo nella buca, lascio il mio verso nella notte.
Avevo gli anni che si contano in tre mani, facevo giochi da villani, uno di questi era catturare lucertole.
Nella mia fame da gatto, camminavo sopra il tetto, tra nidi vespe e lastre di amianto.
Non avevo tempo per il pianto. Una volta tirai quella che sembrava una coda di rospo, bitorzoluta, verde oltremare, da drago oceanico.
Nel tirare, la coda mi rimase in mano, si muoveva, saltellava, era una morte piena di vita, grossa quanto la mia mano.
La portai a vedere a mia nonna, un ciuffo bianco seduta sulla sdraio, guardava il cielo.
Premetti la coda sulla mia fronte.
– Nonna sono un unicorno!-
Mi guardò come una bambina, sorridendo senza denti. Appoggiai la coda nelle sue mani, la guardò senza capire, intonò una ninna nanna che parlava di rondini, cullandola come una creatura.
L’immagine di copertina è dello stesso Andrea Gruccia