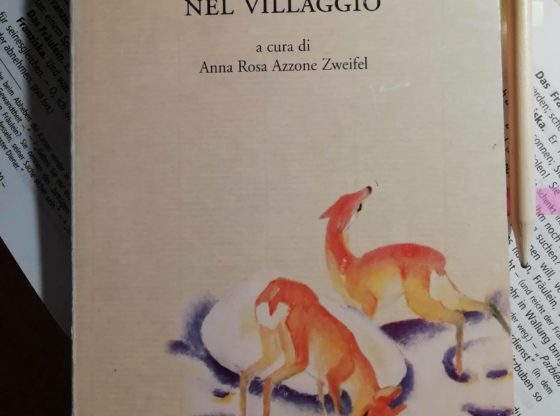La natura sofferente, ostile e caotica come specchio del dolore e del disagio esistenziale.
Il Romanticismo e i movimenti anticipatori sicuramente sono stati quelli in cui il rapporto uomo-natura è emerso con grande potenza espressiva nell’arte e nella letteratura. La natura viene vista come organismo vitale che si uniforma agli stati d’animo e ne rispecchia i moti, gli artisti romantici cercano di colmare il vuoto esistenziale nel paesaggio che viene vissuto come un doppio dell’anima, ovvero un “paesaggio-stato d’animo”, oppure ne avvertono l’ostilità e il caos che ne acuisce il senso di smarrimento. Questi elementi gettano le basi della poesia moderna e aprono la via al Novecento. Tuttavia, in un periodo ben più lontano, Petrarca è stato un illustre precursore a cui dobbiamo, come è ben noto, l’utilizzo del paesaggio come proiezione fisica e concreta della sofferenza interiore, il cosiddetto “paesaggio dell’anima”. Egli è riuscito a distaccarsi dal topos del locus amoenus che pure è largamente presente nella sua produzione poetica, ma l’ha affiancato a luoghi selvaggi, solitari e inospitali, oppure sordi di fronte al suo dolore. Il Canzoniere riporta molti componimenti che presentano questi tratti, ma si può citare come esmpio il sonetto CCLXXXVIII del Canzoniere, in cui ritroviamo il paesaggio di Valchiusa, (presente in parecchie liriche), che contiene già nel suo nome il suo destino di luogo solitario e isolato. Petrarca aveva un suo rifugio in un campicello presso il fiume Sorga e quando in alcuni scritti ne descrive l’aspetto primitivo parla di una natura selvaggia, una terra arida, rocciosa e con querce nodose, un paesaggio “petroso” insomma, che il poeta riesce piano piano a trasformare in un luogo piacevole grazie alla poesia che muta il paesaggio reale ed esteriore in luogo dell’anima. In questo sonetto esso si presenta come muto spettatore delle sofferenze del poeta: egli vaga senza meta (come nel sonetto più noto “solo e pensoso”), immerso però in una natura lussureggiante che si rivela incapace di dare conforto al suo animo straziato e addirittura assume i connotati sinistri e minacciosi della selva dei suicidi dantesca.
I’ ho pien di sospir’ quest’aere tutto,
d’aspri colli mirando il dolce piano
ove nacque colei ch’avendo in mano
meo cor in sul fiorire e ’n sul far frutto,
è gita al cielo, ed àmmi a tal condutto,
col súbito partir, che, di lontano
gli occhi miei stanchi lei cercando invano,
presso di sé non lassan loco asciutto.
Non è sterpo né sasso in questi monti,
non ramo o fronda verde in queste piagge,
non fiore in queste valli o foglia d’erba,
stilla d’acqua non vèn di queste fonti,
né fiere àn questi boschi sí selvagge,
che non sappian quanto è mia pena acerba.
Si può associare a questo componimento, il sonetto XLIII della poetessa rinascimentale di stampo petrarchista, Vittoria Colonna (1492 -1547), in cui ella proietta il suo stato d’animo malinconico e i suoi turbamenti interiori sugli elementi naturali, di cui offre una visione negativa e capovolta, consona al suo spirito travagliato. Ci rappresenta un mondo rovesciato nel quale né il Sole né la Luna né le stelle danno più luce e gli elementi naturali sono in preda al caos: l’acqua s’intorbida, il cielo si oscura, il fuoco non dà calore, il vento non rinfresca, ogni elemento ha perso la sua connotazione consueta. La causa di questo sconvolgimento è la morte dell’uomo che amava, il suo Sole. Come Petrarca dunque proietta il suo io sconvolto sugli elementi naturali e entrambi i poeti mostrano la loro modernità sorprendente nel percepire con animo angosciato la realtà circostante e renderla partecipe al proprio travaglio spirituale.
Parmi, che ’l Sol non porga il lume usato,
Nè che lo dia sì chiaro a sua sorella,
Nè veggio almo pianeta, o vaga stella
Rotar lieto i be’ rai nel cerchio ornato.
Non veggio cor più di valore armato:
Fuggito è il vero onor, la gloria bella,
Nascosa è la virtù giunta con ella,
Nè vive in arbor fronda, o fiore in prato:
Veggio torbide l’ acque, e l’ aer nero,
Non scalda il fuoco, nè rinfresca il vento,
Tutti an smarrito la lor propria cura.
D’ allor che ’l mio bel Sol fu in terra spento:
O che confuso è l’ ordin di Natura,
O il duol agli occhi miei nasconde il vero.
I sonetti citati mostrano senza dubbio che Petrarca, (e in seguito i suoi epigoni), abbiano gettato le basi della lirica moderna non solo nell’ effusione dei moti interiori, ma anche nell’associarli al paesaggio. Nel caso di Petrarca e di Vittoria Colonna, i patimenti generati dall’amore si rispecchiano in una natura ostile e capovolta. Trasferendoci però alle soglie dell’Ottocento, se si analizza un passo tratto da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” di Foscolo troviamo il tema, tipicamente romantico, della natura partecipe ai sentimenti del poeta. Si tratta di un estratto della lettera da Ventimiglia, in cui appare chiaro che il paesaggio dirupato, minaccioso e cupo rifletta non solo la sua disillusione amorosa, ma anche altri turbamenti, come il senso di sradicamento dovuto all’assenza di una patria, di tessuto sociale stabile e la delusione politica. Si può leggere tra le righe la concezione pessimistica della condizione esistenziale dolorosa dell’uomo che emerge dalla descrizione di una natura distruttiva e selvaggia tramite un lessico che enfatizza l’atmosfera cupa: precipizi, gole, burroni, viscere, bronchi che diventano l’emblema della sua sofferenza personale, delle forme di violenza che caratterizzano la storia e delle ripercussioni sulla società del suo reo tempo.
Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.
Leopardi, in pieno clima romantico, in un passo celebre dello Zibaldone (4175-4177), esprime il dolore cosmico offrendoci la descrizione di un giardino che si configura non più come un locus amoenus di delizie, pace e serenità, (come detto anche per Petrarca), ma rovescia il topos letterario e lo trasforma in un luogo di sofferenza, metafora della lotta per vita. Leopardi premette a questo famoso scritto l’affermazione che “tutto è male”, perciò anche l’immagine del giardino è un insieme di specie vegetali in souffrance, nessuna varietà è priva di una qualsivoglia forma di offesa e disagio, i fiori sono tormentati dalle api, gli alberi dalle formiche, bruchi, mosche, zanzare, altre piante soffrono per il caldo eccessivo, sono spezzate dal vento, patiscono l’umidità, sono calpestate dal passaggio di esseri umani. Gli insetti e gli altri esseri che infliggono tormenti ai vegetali non sono malvagi, ma innocenti artefici di torture che inconsapevolmente mettono in atto per perpetuare gli eterni cicli naturali. Si deve poi evidenziare l’antitesi tra le immagini del giardino nello splendido fulgore della fioritura primaverile, le api buone e industriose, la donzelletta che coglie fiori, contrapposte agli insetti crudeli, al giardiniere che pota, ai piedi che stritolano e uccidono i teneri steli. Lo spettacolo del giardino perciò, se da una parte rallegra l’animo e offre un’immagine complessiva di bellezza e armonia, dall’altra si configura alla stregua di un cimitero con tantissimi dettagli che mettono in luce infelicità e sofferenza. La conclusione leopardiana è piuttosto amara: tutta la verde famiglia preferirebbe non esistere e prosperare perché destinata alla sofferenza. Tuttavia, come la critica ha spesso sottolineato, e come chiaramente emerge anche nelle opere in toto, Leopardi è il poeta della vita, di cui vorrebbe godere ogni aspetto con ardore, perciò in virtù del suo attaccamento tenace ad essa, partecipa emotivamente alla sofferenza del giardino, ne compatisce la condizione che accomuna ogni essere vivente. La riflessione sul dolore universale che sfocia nel pessimismo comico non deve certo indurci a considerare il poeta recanatese un rinunciatario, ma un uomo che ama profondamente e disperatamente la vita pur avendone compreso l’infelicità.
Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite stagione dell’anno. Voi non potete volger lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in istato di souffrance, qual individuo più, qual meno. Là quella rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la vita; si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un’ape, nelle sue parti più sensibili, più vitali. [4176]Il dolce mele non si fabbrica dalle industriose, pazienti, buone, virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini. Quell’albero è infestato da un formicaio, quell’altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare; questo è ferito nella scorza e cruciato dall’aria o dal sole che penetra nella piaga; quello è offeso nel tronco, o nelle radici; quell’altro ha più foglie secche; quest’altro è roso, morsicato nei fiori; quello trafitto, punzecchiato nei frutti. Quella pianta ha troppo caldo, questa troppo fresco; troppa luce, troppa ombra; troppo umido, troppo secco. L’una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro nel crescere, nello stendersi; l’altra non trova dove appoggiarsi, o si affatica e stenta per arrivarvi. In tutto il giardino tu non trovi una pianticella sola in istato di sanità perfetta. Qua un ramicello è rotto o dal vento o dal suo proprio peso; là un zeffiretto va stracciando un fiore, vola con un brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta, staccata e strappata via. Intanto tu strazi le erbe co’ tuoi passi; le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi. Quella donzelletta sensibile e gentile, va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Il giardiniere va saggiamente troncando, tagliando membra sensibili, colle unghie, col ferro. (Bologna. 19. Aprile. 1826.). Certamente queste piante vivono; alcune perchè le loro infermità non sono mortali, altre perchè ancora con malattie mortali, le piante, e gli animali altresì, possono durare a vivere qualche poco di tempo. Lo spettacolo di tanta copia di vita all’entrare in questo giardino ci rallegra l’anima, e di qui è che questo ci pare essere un soggiorno di gioia. Ma in verità questa vita è trista e infelice, ogni giardino è quasi un vasto ospitale (luogo ben più deplorabile che un cemeterio), e se questi esseri [4177]sentono, o vogliamo dire, sentissero, certo è che il non essere sarebbe per loro assai meglio che l’essere.
(Bologna. 22. Apr. 1826.)
Un altro famosissimo estratto, questa volta manzoniano, si può accostare al giardino leopardiano: nel capitolo XXXIII dei “Promessi sposi”è descritta la vigna di Renzo abbandonata da molto tempo. Guarito dalla peste, il giovane torna al suo paese in cerca di Lucia e passa davanti a un luogo a lui ben noto, la sua vigna incolta e devastata. Essa è tratteggiata con estrema cura con un’enumerazione notevole di tutte le specie vegetali presenti. E’ ben conosciuto l’amore di Manzoni nei confronti della botanica e del giardinaggio, ma il suo intento qui non è certo fornire una rappresentazione poetica e artistica della vigna, mira piuttosto al ribaltamento della concezione del luogo coltivato con amore e foriero di serenità e fecondità, divenuto caos. Questo sconvolgimento scaturisce dalla violenza e dalla sopraffazione umane, al contrario, quindi, di ciò che accade nel giardino leopardiano in cui la sofferenza è intrinseca alla natura stessa. Questa famosa pagina fu aggiunta al romanzo nell’edizione ventisettana, segno che l’autore le attribuiva un valore importante: la vigna incolta diventa simbolo dello scompiglio che deriva, sul piano concreto, dall’assenza di Renzo, dalla sua responsabilità individuale che ha generato un rigoglio inusitato della natura abbandonata a se stessa, “guazzabuglio” di erbacce, una sorta di sonno della ragione che ha generato i suoi mostri. Per questo motivo Manzoni elenca con meticolosità tutte le specie con precisa nomenclatura per sottolineare insistentemente che esse hanno coperto e occultato “i vestigi dell’antica coltura”. L’enumerazione ha lo scopo di accrescere la monotonia e il senso di soffocamento che l’affastellarsi di erbe suscita. La vigna di Renzo, un tempo emblema dell’operosità razionale dell’uomo sulla natura, è infestata da erbacce di ogni tipo, una “marmaglia”, termine che offre un chiaro segno del disordine morale del tempo e del male che fa irruzione nella storia. Viene così espresso il senso di tragica inquietudine con cui Manzoni vede il dilagare del male di fronte a cui l’uomo si trova in una situazione di precarietà a cui la fede può arrecare sollievo e conforto, ma che di certo non può eliminare.
Ecco il passo:
“E andando, passò davanti alla sua vigna; e già dal di fuori poté subito argomentare in che stato la fosse. Una vetticciola, una fronda d’albero di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro; se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S’affacciò all’apertura (del cancello non c’eran più neppure i gangheri; diede un’occhiata in giro: povera vigna! Per due inverni di seguito, la gente del paese era andata a far legna – nel luogo di quel poverino –, come dicevano. Viti, gelsi, frutti d’ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio, o tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell’antica coltura: giovani tralci, in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia de’ filari desolati; qua e là, rimessiticci o getti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini; ma anche questo si vedeva sparso, soffogato, in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza l’aiuto della man dell’uomo. Era una marmaglia d’ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, d’avene salvatiche, d’amaranti verdi, di radicchielle, d’acetoselle, di panicastrelle e d’altrettali piante; di quelle, voglio dire, di cui il contadino d’ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce, o qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli, che facevano a soverchiarsi l’uno con l’altro nell’aria, o a passarsi avanti, strisciando sul terreno, a rubarsi in somma il posto per ogni verso; una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, di cento forme, di cento grandezze: spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa marmaglia di piante ce n’era alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte: l’uva turca, più alta di tutte, co’ suoi rami allargati, roseggianti, co’ suoi pomposi foglioni verdecupi, alcuni già orlati di porpora, co’ suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di porporine, poi di verdi, e in cima di fiorellini biancastri; il tasso barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra, e lo stelo diritto all’aria, e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli: cardi, ispidi ne’ rami, nelle foglie, ne’ calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggieri. Qui una quantità di vilucchioni arrampicati e avvoltati a’ nuovi rampolli d’un gelso, gli avevan tutti ricoperti delle lor foglie ciondoloni, e spenzolavano dalla cima di quelli le lor campanelle candide e molli: là una zucca salvatica, co’ suoi chicchi vermigli, s’era avviticchiata ai nuovi tralci d’una vite; la quale, cercato invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella; e, mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravan giù, pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendon l’uno con l’altro per appoggio. Il rovo era per tutto; andava da una pianta all’altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli stendeva, secondo gli riuscisse; e, attraversato davanti al limitare stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo, anche al padrone”.
La condizione di debolezza e precarietà esistenziale è una tematica che dal Romanticismo si proietta anche nel Novecento. Montale ne è un acuto interprete e la esprime, tra le altre, nella lirica “L’agave sullo scoglio” attraverso l’immagine di un’agave abbarbicata ad uno scoglio, seppur nell’ambito di sollecitazioni culturali differenti da quelle manzoniane. Questa lirica appartiene alla raccolta “Ossi di seppia” nella sezione “Meriggi e ombre”. Fa da sfondo il paesaggio ligure tipicamente montaliano, assolato, arido e battuto dal vento reso celebre in tanti componimenti. Montale utilizza i termini dantesci “ventare” e “rabido”, per definire lo scirocco quando spira impetuoso che rappresenta, insieme col mare, l’elemento naturale avverso all’uomo. L’agave al soffio del vento è in una situazione di pericolo e di sofferenza ma con tenacia si tiene ancorata al terreno ed è il correlativo oggettivo dell’uomo minacciato dalle insidie della vita che cerca di lottare strenuamente per non soccombere. La natura è descritta come un paesaggio inospitale con termini che incutono timore e danno un’idea di immobilità e impossibilità di vivere, come crepaccio, scoglio, rocce, gole, da cui l’uomo-agave tenta di sfuggire incalzato dalla furia degli elementi. Dovere dell’uomo è opporsi al dolore esistenziale, e, seppur egli sia consapevole della sua debolezza e delle insidie che da ogni parte lo minacciano, brama di vivere un’esistenza piena.
O rabido ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh aride ali dell’aria
ora son io
l’agave che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.
Le opere riportate sono dunque legate dall’elemento unificante del disagio esistenziale e della sofferenza interiore raffigurate tramite aspetti paesaggistici poco rassicuranti, filtrati dalla soggettività. A Petrarca dunque il merito di essere stato l’inventor del “paesaggio stato d’animo”, sebbene egli abbia privilegiato soltanto il suo dissidio interiore. In base agli esempi addotti, gli scrittori menzionati hanno oltrepassato la sfera individuale facendo emergere nelle loro descrizioni non solo la propria condizione angosciosa ma quella collettiva e universale. Fatto ancora più rilevante è la presa di coscienza di dover resistere alle avversità cercando in tutti i modi di raggiungere la pienezza vitale, nonostante il dolore e le spinte disgregatrice rappresentati dal disordine, dall’ostilità e dalla furia degli elementi naturali.
L’immagine di copertina è La libertà che guida il popolo, di Eugene Delacroix, Louvre Parigi