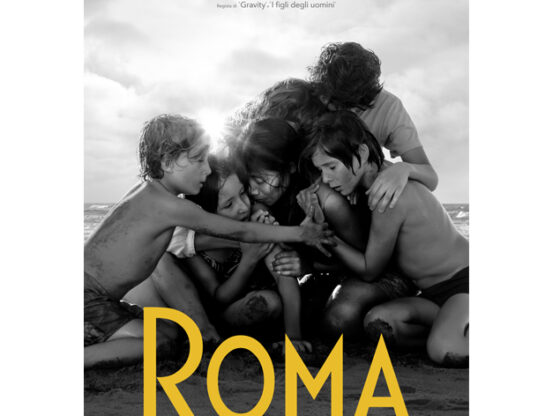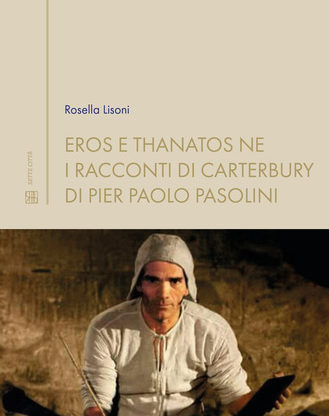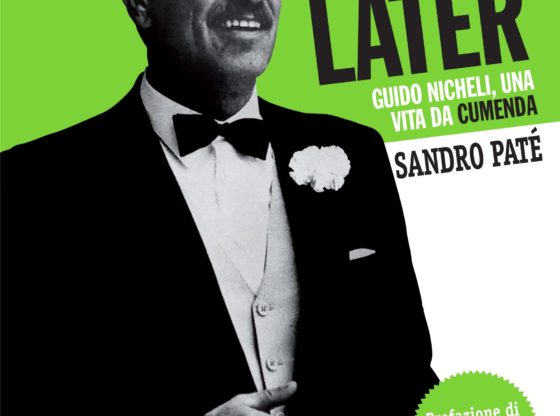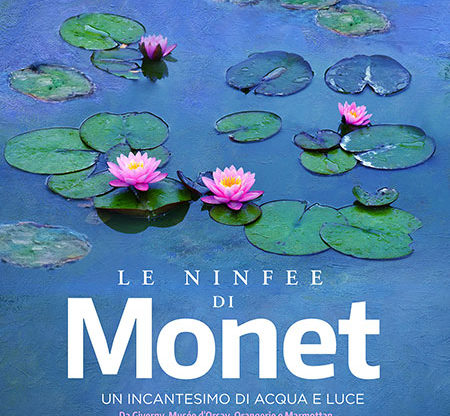La vita che ci precede, le immagini che ci attendono. Un incontro immaginario con Werner Herzog.
Di Alessandro Vergari
“Non sentite dunque tutt’intorno queste grida spaventose, che di solito chiamano silenzio? (Georg Büchner, Lenz – in apertura de L’enigma di Kaspar Hauser)
Con crescente meraviglia e sentimento di vicinanza all’autore, lo scrittore Paolo Del Colle, ho letto lo splendido Il cavallo di Aguirre, libro pubblicato da Castelvecchi Editore che reca un sottotitolo esplicativo: un incontro mai avvenuto con Werner Herzog. Con emozione sono ritornato, innanzitutto, non a un film, ma a Sentieri nel ghiaccio, il diario scritto da Herzog nel 1974 e pubblicato quattro anni più tardi. In quei tempi mi ero totalmente immerso nella poetica eterogenea, a più voci, priva di manifesti, del cosiddetto Nuovo cinema tedesco, il movimento che negli anni Settanta rifondò una nuova estetica, non solo cinematografica ma si potrebbe dire filosofico-esistenziale, in analogia con la Nouvelle Vague francese di un decennio prima.
“Alla fine di novembre del 1974 mi telefonò un amico da Parigi e mi disse che Lotte Eisner era gravemente malata ed era probabile che morisse. Io dissi no, non può essere, il cinema tedesco proprio ora non può fare a meno di lei”. Cosa mi colpì di questo diario? Forse l’innocenza dell’azione intrapresa, la sua incandescente potenza che stava alla base di tutto? “Presi una giacca, una bussola, una sacca con dentro lo stretto necessario. I miei stivali erano così nuovi e così solidi che si poteva contare su di loro. Presi la strada più diretta per Parigi, nell’assoluta fiducia che lei sarebbe rimasta viva, se io fossi arrivato a piedi”. Fin dal principio il regista espone, senza timore di cadere nel ridicolo, senza esigenza di farsi capire da chicchessia, la sua convinzione, il suo credo, il suo voto: salvare, grazie ad un pellegrinaggio invernale, solitario di una solitudine estrema, la vita di Lotte Eisner. Giornalista, critica cinematografica, poeta, durante il nazismo Lotte Eisner fu l’angelo custode di moltissime pellicole altrimenti destinate alla distruzione nella Francia sotto occupazione, nazione presso la quale aveva trovato riparo all’avvento al potere di Adolf Hitler, lei ebrea. Una categorica, apparentemente insensata testimonianza d’affetto, un gesto totale che disorienta i nessi causali: ecco Herzog nella sua purezza. Da Pasing, in Baviera, l’autore attraversa l’Europa fino alla capitale francese. Il paesaggio diviene storia. È un’Europa sommersa dalla neve, immobilizzata in una pioggia fredda, appiattita in una desolazione di nebbie e vapori, refrattaria ai colori. L’orizzonte spoglio richiama l’atmosfera di livida quiete che segue ad un bombardamento, la ricostruzione tradisce il profilo di macerie rimosse eppure presenti, una sospensione simile a quella narrata da Peter Handke in Prima del calcio di rigore, antiromanzo traslato in linguaggio cinematografico da un giovanissimo Wim Wenders nel 1972. Perché l’andare è così doloroso?, si chiede Herzog, atleta del cinema, sognatore lucido, esploratore di tempi e spazi che ci precedono.
“Abbiamo amato il cinema prima di conoscerlo, i film di cui parlavamo non erano distribuiti, non li potevamo vedere, li abbiamo amati alla cieca”, ha dichiarato una volta Jean-Luc Godard, in un dibattito televisivo ospitato, non a caso, da Alexander Kluge in una sua trasmissione culturale. Kluge, teorico e intellettuale di punta del dopoguerra europeo e non semplicemente tedesco, vincitore del Leone d’Oro a Venezia nel 1968 con Artisti sotto la tenda del circo: perplessi, più anziano dei tre involontari vessilliferi del movimento (Werner Herzog, R.W. Fassbinder e Wim Wenders, così-lontani-così-vicini tra loro) ha definito l’arte cinematografica “una patria al di fuori del reale”. Herzog, in tutte le sue opere, si è impegnato nell’invenzione di nuova grammatica della visione, immagini che si adattassero alle esigenze, ai desideri, ai deliri dell’Uomo.
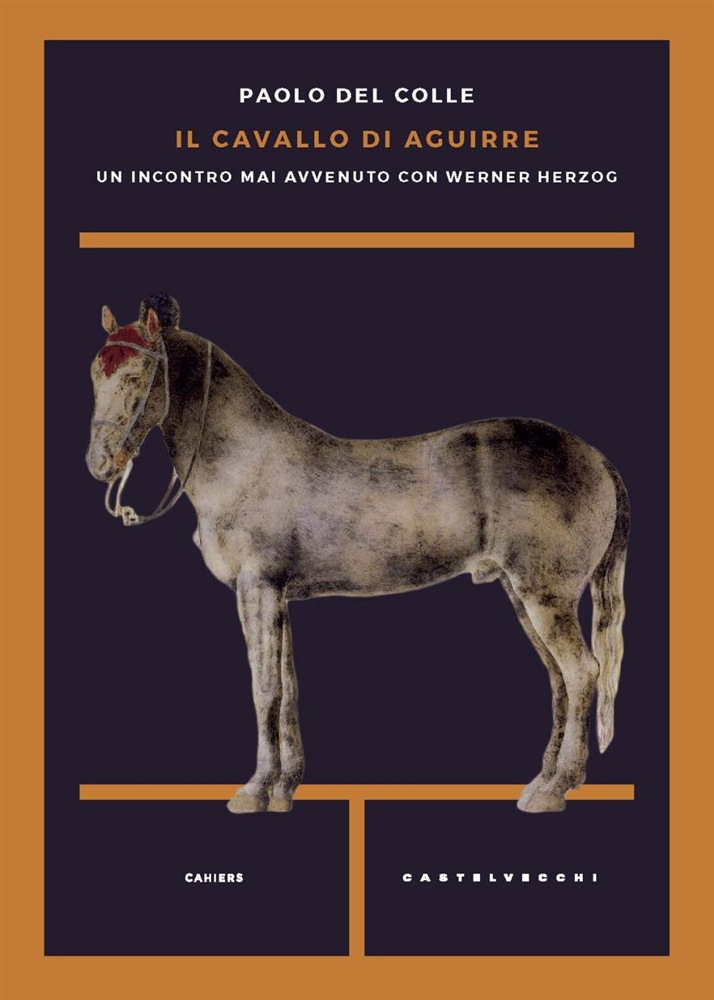
Immagini, appunto. Ripenso al piacere dell’incontro con immagini nemiche di ogni cliché e ripetizione. Vedevo quei film vent’anni dopo la loro gestazione. Dal margine di una Mitteleuropa sinistra e periferica, dai deserti abbaglianti dove realtà e miraggio si fondono, dal cuore tenebroso e intatto della foresta amazzonica, dall’anonima disperazione delle praterie del Wisconsin, Herzog sconcertava lo sguardo abituato alla regolarità. Le sue pellicole istradavano alla diserzione dal consueto, ispiravano un passaggio verso un altrove abitato dal feroce candore di esistenze illibate (il cieco, il sordo, il selvaggio, il nano, il folle, l’abnorme, l’alienato…), a contrasto con l’ottusa violenza della norma sociale. Kaspar Hauser, figlio illegittimo, vive fino a diciotto anni in un’oscura cantina per essere poi introdotto, suo malgrado, al mondo vasto e terribile. “Prima dovrò riuscire a capire meglio le cose che vedo, poi potrò capire il resto”, dice Kaspar in risposta a chi cerca di insegnargli, a mo’ di vino travasato in una bottiglia, il dogma della fede, una posizione inappuntabile sul piano epistemico, eppure intollerabile per officianti incapaci di recedere dalle proprie sicurezze. Nosferatu, prototipo di ogni inquietudine e irrequietudine, archetipo della brama di eterno che irretisce e illude la finitudine umana, è costretto a trascinare ovunque la propria bara, esplicita congiunzione, non simbolica, ma di fatto, tra origine e meta, espressione concreta di un’esistenza ibrida, umano-animale, mai riconciliata con se stessa. Aguirre, Fizcarraldo, Woyzeck, Stroszek… esistenze che deflagrano nell’assoluto di un’esperienza irripetibile, già sancita prima di compiersi. Leggenda vuole che Ian Curtis, il tormentato leader dei Joy Division, avesse guardato in tv La ballata di Stroszek quella fatidica sera del 18 maggio 1980, quando una band epocale, una generazione già bruciata dalle mode e dal Capitale, e una musica tanto sincera da risultare insostenibile, precipitarono nel buio simultaneamente con lui.
Credo, anzi sono convinto, di aver visto Apocalisse nel Deserto nei primi anni Novanta grazie a Fuori Orario di Enrico Ghezzi. Mai nessuno aveva filmato la rabbia umana esplosa contro la Natura con efficacia espressiva così disarmante. Il mio impulso a essere fagocitato dal cinema deriva e attinge, con voracità, (anche) al bagaglio di sensazioni rimaste in me dopo quell’appuntamento notturno, all’incanto provato nel guardare l’apoteosi infernale delle lingue di fuoco che dai pozzi di petrolio in fiamme puntavano al cielo, annerendolo di un fumo denso di velenosa pece. Herzog è scioccante perché coglie sempre l’intoccabile essenza di ciò che accade. Le immagini di Apocalisse nel Deserto negavano la banalità della cronaca attorno alla Guerra nel Golfo di Bush Senior e si ponevano in netta antitesi estetica, etica, rispetto alla spettacolarizzazione patinata, alla riduzione a videogame di una tragedia immane. Il Cinema, a prescindere dalla forma, film o documentario, era quello, insieme alle opere immortali precedenti, commentate dalle geniali musiche dei Popol Vuh del compianto Florian Fricke. Il Cinema approdava con Herzog a una sconfessione dell’esistente in favore del grido inascoltato dell’esistenza.
Paolo Del Colle, scrittore e poeta appartato, schivo, mosso da autentica ammirazione per il Maestro, nel corso della sua produzione letteraria ha dedicato a Herzog altro inchiostro, altre pagine vergate da passione, basti ricordare il precedente romanzo Nuda proprietà. Qui, ne Il cavallo di Aguirre, Del Colle si immagina una conversazione, teatro il tavolino del bar di una stazione che presto si trasforma in un terreno minato di confronto / rispecchiamento tra lui e l’amatissimo regista. Non sappiamo come abbia potuto intercettarlo, nel labirinto di infiniti impegni che lo attendono a ogni angolo del pianeta (ultimo nato, il documentario su Bruce Chatwin), non conosciamo gli antefatti. Si intreccia tra loro una partita a scacchi, quasi bergmaniana, avente come posta la verità stessa, l’assoluto, l’indefinibile presenza della morte quale muta testimonianza dello scorrere incontestabile della vita. È lo sbocciare di un’occorrenza miracolosa, straordinaria, eccezionale. Paolo Del Colle ha davanti a sé Werner Herzog, scarpe solide ai piedi, il classico giaccone addosso, occhi vigili e taglienti, figura scolpita nella memoria di ogni cinefilo. Nella tasca l’autore cela un libro. Un regalo da ammiratore, un omaggio autentico, una consacrazione del momento. Occorre auscultare i movimenti dell’aria e carpire il καιρός, l’occasione opportuna per consegnare il libro in quelle mani che, insieme a centinaia di altre mani, sollevarono una nave adagiandola sul costone di una montagna, per farla poi scollinare fino al fiume sottostante.
“Mi chiede solo di ordinare una bottiglia d’acqua naturale. Sapevo del suo amore per la nostra lingua, anche se mi ero appuntato per precauzione delle domande in inglese, ma resto sorpreso da come si trovi a suo agio con quelle parole che sono anche le mie, quelle con cui ho commentato i suoi film, ho scritto di lui e di me, quelle parole con cui ora cerco di creare un clima di intimità o cordialità affermando che vederlo in cravatta in questa stazione mi fa pensare alla scena in cui incontra Wenders, all’aeroporto di Tokyo. Come se anche noi ci incontrassimo casualmente ma già ci conoscessimo. Vorrei dire: sono più di quarant’anni che ci conosciamo e non siamo cambiati, tieni questo libro, è dedicato a te; ma guardo solo la giacca a vento, ora non posso darglielo, sarebbe scortese, e poi non avrei più nulla da dire: avrebbe ragione ad alzarsi e andarsene lasciandolo sul tavolino”.
Il cavallo di Aguirre è uno di quei libri che, per parafrasare Fassbinder (“Si è liberi soltanto nelle limitazioni. E non c’è cosa più terrificante che aver paura del terrore”, appuntava in un diario nel 1971), liberano la mente. Il testo reclamava di essere scritto, o meglio già risiedeva in un angolo di universo letterario a prescindere dalla sua realizzazione. Paolo Del Colle è se stesso e un altro, allo stesso modo di Werner Herzog, personaggio di fantasia eppure vero. Sebbene guardi a sé, o comunque ad un sé proiettato in una situazione immaginaria, Del Colle non è mai autoreferenziale. Ne Il cavallo di Aguirre ognuno può ritrovare il filo di domande essenziali. La traccia sommersa è l’universale paura dell’ignoto. Le parole che tessono la fibra poetica dell’opera sono frutto di un parto dialogico. Ogniqualvolta l’autore squaderna le pagine bianche, cancellate, usurate della propria vita, Herzog gli si para di fronte come un fantasma solido, un doppelgänger inafferrabile, un golem emerso dal cuoregrato e riconoscente di un ammiratore devoto. Paolo Del Colle non nasconde di essere in debito con lui, in senso morale, espressivo, linguistico, cognitivo. Nello scambio di battute, perfino nella terminologia, è esperita di continuo una mancanza, una fragilità ontologica, uno scarto non recuperabile. L’esercizio si compie nello svelarsi in un catartico rito di decostruzione, o ancora, scomodando nuovamente Handke, di “autodiffamazione”: la coabitazione con i due adorati gatti, la meccanica consuetudine dell’insegnamento scolastico (mestiere bello e ingrato), la ritualità vagamente maniacale delle trecentosessantasei cravatte, il rapporto non semplice, non risolto con i cari che non ci sono più, il rimorso per il non-detto, l’amore perduto per una donna svanita in un tempo inaccessibile. Fassbinder, ancora, si adatta: “Sognare un amore vero è proprio un bel sogno, ma le stanze hanno sempre quattro pareti, le strade sono quasi tutte asfaltate e per respirare c’è bisogno dell’ossigeno”. Nel suo lirismo, Del Colle è scabro, leale, in bilico sulla parete scoscesa di una confessione irrimediabile.
“Avrei dovuto essere più preciso con delle parole inadatte alla realtà, quelle che cerco di usare quando scrivo: più scompare la realtà più la si può intendere, farne lo sfondo impenetrabile da cui escono il sole la luna gli uomini le strade, ricordandoci che non sono mai come le vedi; la somiglianza è il modo con cui si danno a noi. Per questo non sono uno scrittore, ho fatto bene a non dirtelo. Riesco a scrivere solo di ciò che non esiste o di un mondo che è pura probabilità, una via di scampo da ciò che consideriamo vero. Ecco, è tutto chiaro in questo libro che ho in tasca, dovrei dartelo, questa immagine della realtà mi viene da te, ma sarebbe farti un complimento? La struggente bellezza delle tue immagini denuncia sempre l’assenza di un compimento, creando la possibilità che il mondo esista”.
I fatti non sono la verità. Pensarlo è stupido ed Herzog ha orrore della stupidità umana. È estremamente ridicolo credere a una Natura buona. La Natura è un fondo cieco, un linguaggio inarticolato, un grido perenne. La Natura è violenza. Occorre approssimarsi al confine invalicabile delle possibilità umane per comprenderlo, ad esempio occorre toccare il bordo di un vulcano intenzionato ad esplodere. Solo per cogliere un’immagine che rappresenti gli ultimi / originari segni di vita. Il cavallo di Aguirre è anche un saggio raffinato sul cinema di Herzog, una interpretazione personale del suo messaggio profondo, un controcanto intrecciato alla sua estetica. Mentre intorno a Paolo e a Werner scorre la turistica normalità di una media mattina italiana, tra caffè troppo amari (intollerabili per il palato di un bavarese giramondo) e bottiglie d’acqua servite a ripetizione per tastare la regolarità di un sapore mai identico a se stesso, la conversazione attraversa le opere maggiori note al pubblico, con Bruno S. o Klaus Kinski nel ruolo di protagonista, e quelle rare alla stregua di reperti, conservate nello scrigno della memoria di pochi appassionati. In letteratura è infrequente riscontrare una simile coincidenza tra scrittura e vita. L’incontro mai avvenuto con Werner Herzog, in realtà, è avvenuto fin dall’inizio, l’incontro anticipa il pieno, il vuoto, la distruzione, la creazione.
“Hai citato un film che amo molto, girato vicino ai luoghi dove sono nato, ambientato nel paesaggio epocale che hai detto; la stilizzazione fortissima impedisce che affiorino miei ricordi o nostalgie o immagini che denunciassero un già visto, un riconoscimento; sì, il senso della catastrofe è quello che dici, ma c’è il profeta Hias, il puro dal cuore di vetro; vede ciò che è possibile dopo la catastrofe, non si limita ad annunciarla, vede anche la rinascita, la nuova terra, il mondo di chi ricomincerà da capo: nella sua ultima visione gli appaiono gli uomini di un’isola sperduta, dopo un lungo scrutare alcuni partono verso l’orizzonte per scoprire se la terra è piatta come sanno oppure no, fanno rinascere la storia con nuovi occhi: non abbiamo altre possibilità, le nuove scoperte potranno essere un rivedere tutto ciò che abbiamo fatto, perché non è, né era inevitabile”.
Il regista conclude il suo pellegrinaggio del 1974 con la frase: da qualche giorno io so volare. Volare alti, leggeri, sconfiggere la gravità, sovvertire la prevedibilità, innalzarsi verso forme di spiritualità che trascendano la logica stantia dei fatti. Grazie, Werner Herzog. E grazie a Paolo Del Colle per questo dono bellissimo.
(Paolo Del Colle, Il cavallo di Aguirre. Un incontro mai avvenuto con Werner Herzog, Castelvecchi, 2020, pp. 125, € 15,00)
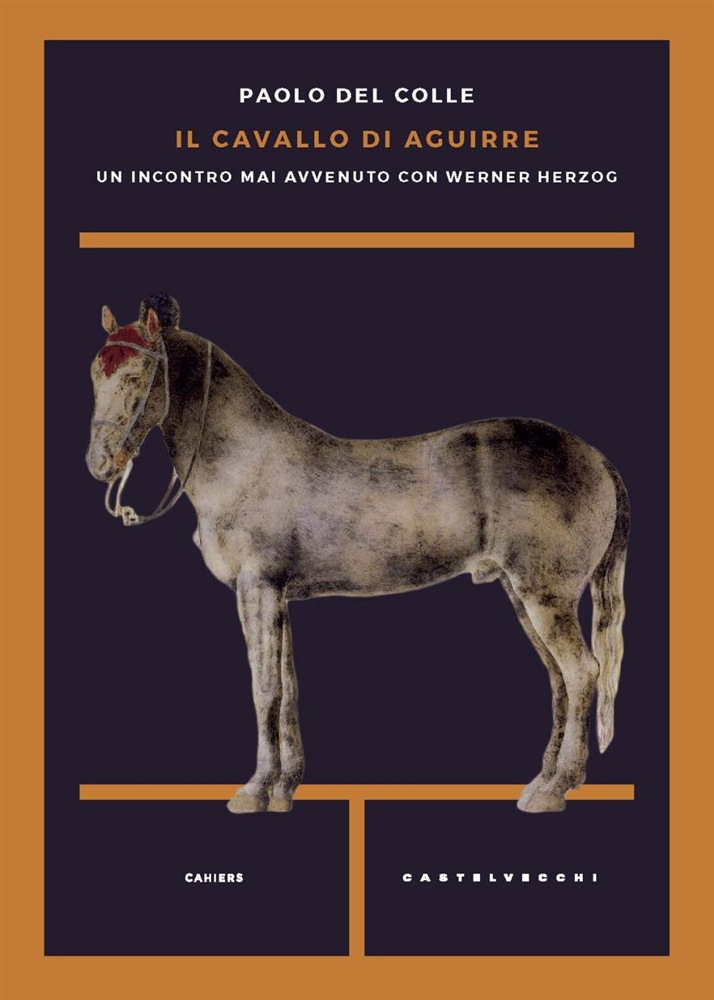 Il cavallo di Aguirre. Un incontro mai avvenuto con Werner Herzog
Il cavallo di Aguirre. Un incontro mai avvenuto con Werner Herzog
Cinema
Castelvecchi Editore
2020
125 p., brossura