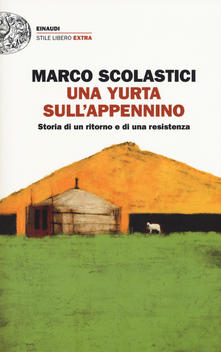Diarismi: da “1984” a “Seven”
Di Michele Nigro
Comincerei affermando che la diaristica può essere anche un genere letterario; è bene specificarlo – sottolineando il “può essere anche” – perché non tutti i vostri “sfogatoi su carta” chiusi nei cassetti, ahimè, diventeranno opere letterarie da leggere o studiare. A meno che non vi chiamiate Cesare Pavese (Il mestiere di vivere, 1935 – 1950) o Martin Heidegger (Quaderni neri, 1931 – 1969), temo che i taccuini che custodite gelosamente, preservandoli dagli occhi indiscreti di congiunti spioni, siano destinati al macero in vista di un trasloco draconiano (o perché testimoniano uno scomodo passato da cancellare) e quindi all’oblio, o nella migliore delle ipotesi alla conservazione post mortem da parte di qualche familiare mosso da curiosità o doveroso affetto, che forse un giorno li leggerà oppure no, trovandoli, dopo le prime pagine, tremendamente noiosi e autoreferenziali, quando non addirittura indecifrabili e illeggibili. Per poi essere eliminati definitivamente, e stavolta senza appello, nel corso di un successivo scarto compiuto da parenti più distratti e insensibili, o più ignoranti, come accaduto alle carte di Marcel Proust date alle fiamme dal fratello Robert e da sua moglie Marthe. La vita autonoma degli oggetti, a volte, rappresenta un po’ il lento prolungamento della morte dei loro proprietari: ma alla fine anche essi muoiono, si diluiscono nella Storia e spariscono, si disintegrano per ritornare nel ciclo inorganico della materia e in quello dell’energia che la teneva insieme. Le altre cose, per motivi “repertologici”, finiscono miracolosamente e in maniera anonima in musei pubblici o privati. Oppure accade il contrario, ovvero che gli oggetti durino meno dei loro padroni: se i due antichi pompeiani, recentemente rinvenuti e “ritornati in vita” grazie alla realizzazione di calchi, morti durante l’eruzione del Vesuvio, avessero per ipotesi tenuto un diario su tabulae scritto a suon di stilus, questo con molta probabilità non sarebbe giunto intatto fino ai nostri giorni. C’è il diario ma non il corpo o c’è il corpo ma non il diario. Non si può avere tutto dalla vita dopo la morte.
Ma non tutti i diarismi non letterari sono inutili, anzi.
Per Winston Smith, protagonista del romanzo “1984” di George Orwell, il diario rappresenta un atto rivoluzionario, una sfida aperta – non riportata in cronaca – al sistema “fraterno” del Big Brother; è un modo privato per difendere e conservare il proprio privato, l’umanità residua, l’indicibile protesta, il desiderio inconfessabile di intimità con se stesso e con l’altra; persino la paranoia, quand’è riportata su carta, può fare compagnia e diventare un caro argomento a cui tornare. È l’ebbrezza fornita da una decisione personale e per una volta non collettiva, coltivata sapendo di essere controcorrente, solitario e disperatamente originale; è il sano terrore provato nel sapere di essere, agli occhi di una società inconsapevole, uno psicocriminale che ancora gode dell’anonimato e di un’euforica clandestinità scritturale. Il diario è l’onanismo del pensatore che non dovrebbe pensare; è il momento tutto per sé; è l’embrione di una criticità riesumata; è lo strumento con cui programmare le varie fasi della propria liberazione interiore; è l’alter ego con cui confrontarsi; è il “pallone marca Wilson” del naufrago di “Cast Away”; è lo specchio che non riflette ma fa riflettere; è l’inebriante entusiasmo che scaturisce dall’aver fregato il sistema; è la convinzione di poter lasciare qualche traccia di sé a un eventuale lettore del futuro: come accade con la lettera dal carcere di Valerie Page, in “V per Vendetta”, scritta sulla carta igienica e lasciata in un buco del muro, nella speranza che qualche persona degna la possa trovare, leggere e condividerne emozionalmente il contenuto.
La penna è complice del diario.
Perché il diario è pericoloso? Il diario, così come la lettura, induce alla riflessione privata, alla creazione di un mondo interiore difficile da controllare, alla coltivazione di desideri improduttivi e non collettivistici. In una scena dell’omonimo film, il dottor Živago chiede, forse ingenuamente, a un partigiano rosso: “Dov’è il fronte?”. E si sente rispondere, come da manuale del perfetto rivoluzionario: “… il fronte è dovunque sono i nemici della rivoluzione […] e dovunque ci sia un borghese incallito, un insegnante infido o un poeta dubbio che si crogioli nella sua vita privata…!”. Il diario è il dovunque privato incontrollato e incontrollabile; è il confine impalpabile ma altrettanto reale di un fronte in una guerra senza trincee. Perché lo psicoreato non è rappresentato dall’atto in sé ma, come dice il nome stesso, dal pensiero che l’ha generato. Infatti il “1984” di Orwell fu una critica, sotto forma di narrativa distopica, al totalitarismo sovietico sperimentato direttamente dall’autore britannico e che non disdegnava, prim’ancora dell’eliminazione fisica dei suoi nemici, un controllo del loro pensiero (Thought Control).
Oggi il diario è stato sostituito dai social network: confessionali pubblici frequentati da milioni di contatti (ovvero ‘persone’) in cui depositare aspetti della propria esistenza che interessano a pochissimi soggetti o a nessuno, ma che rappresentano il carburante – sotto forma di dati – dell’unico vero Grande Fratello di quest’epoca: un “Big Brother informatico” a cui aderire spontaneamente e senza alcuna costrizione. Il motto in voga è: “Il social networking è gratuito perché il prodotto siete voi stessi!”. Siamo noi che paghiamo in natura. La profezia orwelliana dell’adesione convinta, spontanea, fatta propria in maniera intima e incontrovertibile, si è venuta così inesorabilmente a realizzare nel modo più dolce e indolore possibile. Scrive Orwell: “La cosa che [Winston] si disponeva a fare consisteva nell’incominciare un diario. Ciò non era illegale (nulla era illegale, poiché non c’erano più leggi)…”. La frase contenuta tra parentesi costituisce il fulcro del sistema psicopoliziesco raccontato in questo angosciante ma straordinario romanzo fantascientifico: obiettivo del Grande Fratello non è il mero controllo delle masse ma l’accoglimento convinto da parte di queste di un sistema di pensiero incontrovertibile. La legge è inutile se il cittadino ingloba e fa definitivamente suo il pensiero programmatico del partito; illegale diventa sinonimo di innaturalità: chi va contro il pensiero del partito è un deviato dalla natura, ovvero dalla naturale adesione al bene comune della nazione.
In questo periodo storico caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, molti hanno utilizzato a sproposito la distopia orwelliana per descrivere una presunta “dittatura sanitaria” in atto: i decreti governativi sono stati addirittura paragonati a strumenti antiliberali. Le dittature pure, invece, come riportato nello stralcio citato, non hanno bisogno di decreti, di leggi promulgate continuamente: la vera dittatura mira al controllo interiore, al convincimento sincero da parte del cittadino. La democrazia, al contrario, comprende la contestazione, la rivolta popolare, l’indisciplina dei furbetti, il dubbio (anche quello che nasce dalla disinformazione e dall’ignoranza), l’indignazione dei viziati, la non obbligatorietà a determinati strumenti sanitari (vedi il non obbligo a vaccinarsi!). Comprende addirittura il negazionismo. Lo comprende ed è costretta persino a garantirgli una deleteria rappresentatività pubblica: vedi le manifestazioni di piazza dei negazionisti, guarda caso, di estrema destra. I neofascisti che urlano alla dittatura sono l’equivoco, al limite del comico, se non ci fosse da piangere, di quest’epoca ideologicamente scellerata. A volte bisognerebbe chiedersi con onestà intellettuale se un eccesso di democrazia, assicurata a determinate minoranze, non vada a minare la libertà della maggioranza. La libertà, ad esempio, di liberarsi di una pandemia.
Di altra natura è senz’altro la diaristica di John Doe, il serial killer del film “Seven” diretto da David Fincher nel 1995; se Winston Smith riesce a malapena a procurarsi un vecchio diario da un antiquario/archeologo nei quartieri riservati ai Prolet, John Doe ha a disposizione scaffali di taccuini riempiti meticolosamente nel corso degli anni e arricchiti con dovizia di particolari e dettagli iconografici degni di un ricercatore ossessionato dall’oggetto dei suoi studi. Se per Winston il diario è uno strumento di liberazione personale, per John Doe è un vomitorio privato e acritico in cui riversare il proprio disprezzo nei confronti dell’altro, della società in generale; è un registratore mentale senza soluzione di continuità. Afferma il detective William Somerset: “[sui taccuini] non vi è neanche una data, sono abbandonati sugli scaffali, senza nessun ordine. È la sua mente trascritta su carta”. Il tempo non conta perché vi è solo un esteso presente occupato da un unico obiettivo; John Doe è un cosiddetto predicatore: la sua azione non mira alla salvezza personale bensì a quella di una società che ha bisogno di essere mondata dai propri vizi capitali in maniera cruenta. E per farlo non è più sufficiente scriverlo su un diario che nessuno leggerà, ma è necessario dare l’esempio, scegliere delle precise categorie umane ree di personificare determinati peccati, attuare una serie di punizioni esemplari e spettacolari che lascino il segno, che abbiano una eco mediatica “educativa”. Il diario in questo caso non si rivolge compassionevolmente a un ipotetico lettore futuro, ma John Doe parla a se stesso, usa quelle pagine per programmare il suo infernale piano di redenzione sociale; in quei taccuini lo motiva per anni prima di attuarlo, lo alimenta con descrizioni di vita quotidiana, di sensazioni all’apparenza poco importanti ma che nella sua mente costituiscono il movente della sua missione punitiva. L’imperfetto, il vizioso, il peccatore, il diverso, l’insopportabile altro da me, che non corrisponde alla mia educazione “religiosa”, al mio rigore autodisciplinante, alla mia visione di mondo ordinato e allineato a un presunto Piano Superiore, deve essere fermato, rieducato con esempi forti, adeguatamente punito, altrimenti non comprende, non assimila l’insegnamento, non cambia.
Che differenza c’è tra un diario scritto per se stessi e uno in cui il diarista immagina costantemente la presenza di un lettore che ancora non legge le sue pagine ma che un giorno arriverà e lo giudicherà? Moltissima, ed è una differenza che si scorge nel tono, nello stile, nella cura del testo: forse quella costante presenza è la coscienza di chi scrive, che vuole preservare l’autore del diario da futuri giudizi sommari. Anche nel privato un certo autoediting appare fin dalle prime pagine necessario: si dice di farlo per se stessi, per rileggersi senza difficoltà, per rispetto verso il proprio pensiero espresso in quelle pagine, ma in realtà il diarista, anche il più ritroso e solitario, spera (o teme) sempre di essere letto, non importa se da un lettore in carne e ossa o da un occhio invisibile (più potente di quello del Grande Fratello) che lo accompagna e lo aiuta dall’alto. In questo caso il diario diventa quasi preghiera, si rivolge a improbabili entità superiori, ad angeli custodi, o a un Super-io che giustifichi le azioni dell’Es anche se a scriverlo materialmente è l’Io. Perché è sempre l’Ego l’unico, vero, onnipresente editore dei nostri diari.